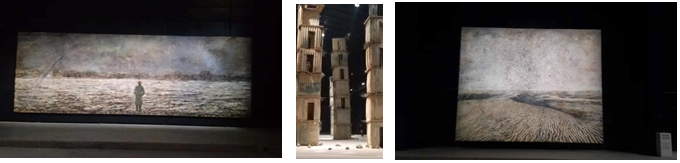Appunti per un bilancio ed una prospettiva di un progetto comunista rivoluzionario.
Agosto – Novembre 2018
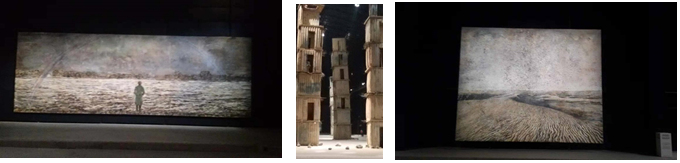
INDICE
Conti: la lunga transizione italiana e il PCL
La lunga transizione
La costruzione del PCL
Scorci: le dinamiche ineguali e combinate della crisi; Angolazioni, le linee di frattura e possibili sviluppi
Le dinamiche ineguali e combinate della crisi
Angolazioni, linee di frattura e possibili sviluppi.
TRACCE: per un cammino comunista e rivoluzionario
CONTI: la lunga transizione italiana e il PCL.
La lunga transizione
- Il 4 marzo si è chiuso un ciclo. In Italia si era infatti aperta nei primi anni novanta una lunga transizione, sospinta dalla fine della guerra fredda e dalla contrastata costruzione della UE, dell’euro, di un mercato e un capitale continentale. Una lunga transizione, perché questi processi sono stati caratterizzati da incompiutezze e contraddizioni. L’integrazione è stata infatti segnata da politiche di austerità, allargamenti successivi (1995: Scandinavia e Austria; 2004, 2007 e 2013: Europa centrale e orientale) e un sistema istituzionale incompleto (bilancio, fisco, regolamentazione delle società di capitale, difesa). Da una parte è stato radicalmente ridotto il salario diretto, indiretto e sociale delle classi subordinate di tutto il continente, dall’altra si è progressivamente ridefinita la sua struttura produttiva intorno ad un nucleo mitteleuropeo, favorendo divergenze e disequilibri tra i diversi paesi.
- Con la crisi del 1992/93, in particolare, l’Italia ha avviato pesanti politiche d’austerità (Amato-Ciampi-Dini, seguiti poi dagli esecutivi Prodi e Berlusconi) e progressivamente smantellato il suo imponente apparato pubblico (privatizzazioni di banche di interesse nazionale, infrastrutture e società di servizi, oltre che dei 3 colossi ENI, ENEL e TELECOM). Si sono quindi allargate alcune sue storiche fratture, produttive e anche territoriali. In particolare, quelle tra un grande capitale che ha provato a giocare la partita continentale, un grande capitale che si è focalizzato sui mercati nazionali (anche sfruttando concessioni e posizioni monopolistiche), una piccola e media impresa che ha sfruttato le dimensioni globali dei mercati ed una più ripiegata su realtà locali (compresa un’industrializzazione meridionale sostenuta da patti territoriali, bassi salari, scarsi diritti, interessi clientelari e mafiosi). Una scomposizione che ha determinato divisioni e conflitti nel padronato italiano, fronti compositi e alleanze variabili che hanno sostenuto ora la grande svalutazione (92/94) e ora l’entrata nell’euro (96/2001), ora strategie concertative e ora offensive frontali contro il lavoro. Una scomposizione che ha avuto, ovviamente, anche conseguenze sul lavoro: nelle diverse strategie di accumulazione, non solo si è diversificata la composizione di classe, ma si sono differenziati anche tempi e temi del conflitto di classe. In ogni caso, si è registrato un rapido spostamento del baricentro produttivo verso le esportazioni (dal 17,8% del PIL nel 1991 a circa il 25% nei primi anni duemila, per poi superare il 30%), con due fasi espansive: una nei primi anni novanta (svalutazione lira) e una anche più significativa dopo il 2004 (con l’euro, quindi sospinta soprattutto dalla ristrutturazione industriale, che è stata interrotta ma non fermata dalla recessione del 2009). Esportazioni che si sono prima focalizzate sui mercati europei e poi su quelli mondiali (in scia alla strategia di accumulazione tedesca), rendendo quindi il sistema produttivo del paese particolarmente sensibile al quadro internazionale.
- Il 4 marzo si è chiuso un ciclo. In Italia si era infatti aperta nei primi anni novanta una lunga transizione, sospinta dalla fine della guerra fredda e dalla contrastata costruzione della UE, dell’euro, di un mercato e un capitale continentale. Una lunga transizione, perché questi processi sono stati caratterizzati da incompiutezze e contraddizioni. L’integrazione è stata infatti segnata da politiche di austerità, allargamenti successivi (1995: Scandinavia e Austria; 2004, 2007 e 2013: Europa centrale e orientale) e un sistema istituzionale incompleto (bilancio, fisco, regolamentazione delle società di capitale, difesa). Da una parte è stato radicalmente ridotto il salario diretto, indiretto e sociale delle classi subordinate di tutto il continente, dall’altra si è progressivamente ridefinita la sua struttura produttiva intorno ad un nucleo mitteleuropeo, favorendo divergenze e disequilibri tra i diversi paesi.
- Con la crisi del 1992/93, in particolare, l’Italia ha avviato pesanti politiche d’austerità (Amato-Ciampi-Dini, seguiti poi dagli esecutivi Prodi e Berlusconi) e progressivamente smantellato il suo imponente apparato pubblico (privatizzazioni di banche di interesse nazionale, infrastrutture e società di servizi, oltre che dei 3 colossi ENI, ENEL e TELECOM). Si sono quindi allargate alcune sue storiche fratture, produttive e anche territoriali. In particolare, quelle tra un grande capitale che ha provato a giocare la partita continentale, un grande capitale che si è focalizzato sui mercati nazionali (anche sfruttando concessioni e posizioni monopolistiche), una piccola e media impresa che ha sfruttato le dimensioni globali dei mercati ed una più ripiegata su realtà locali (compresa un’industrializzazione meridionale sostenuta da patti territoriali, bassi salari, scarsi diritti, interessi clientelari e mafiosi). Una scomposizione che ha determinato divisioni e conflitti nel padronato italiano, fronti compositi e alleanze variabili che hanno sostenuto ora la grande svalutazione (92/94) e ora l’entrata nell’euro (96/2001), ora strategie concertative e ora offensive frontali contro il lavoro. Una scomposizione che ha avuto, ovviamente, anche conseguenze sul lavoro: nelle diverse strategie di accumulazione, non solo si è diversificata la composizione di classe, ma si sono differenziati anche tempi e temi del conflitto di classe. In ogni caso, si è registrato un rapido spostamento del baricentro produttivo verso le esportazioni (dal 17,8% del PIL nel 1991 a circa il 25% nei primi anni duemila, per poi superare il 30%), con due fasi espansive: una nei primi anni novanta (svalutazione lira) e una anche più significativa dopo il 2004 (con l’euro, quindi sospinta soprattutto dalla ristrutturazione industriale, che è stata interrotta ma non fermata dalla recessione del 2009). Esportazioni che si sono prima focalizzate sui mercati europei e poi su quelli mondiali (in scia alla strategia di accumulazione tedesca), rendendo quindi il sistema produttivo del paese particolarmente sensibile al quadro internazionale.
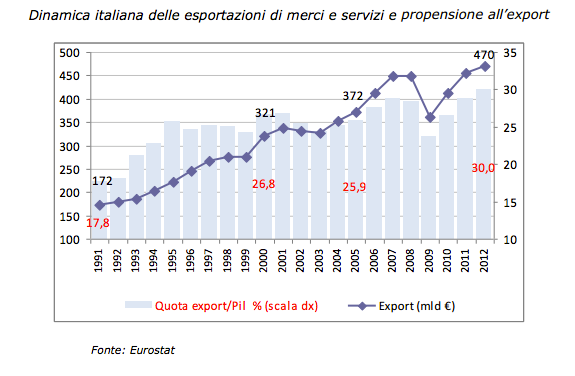
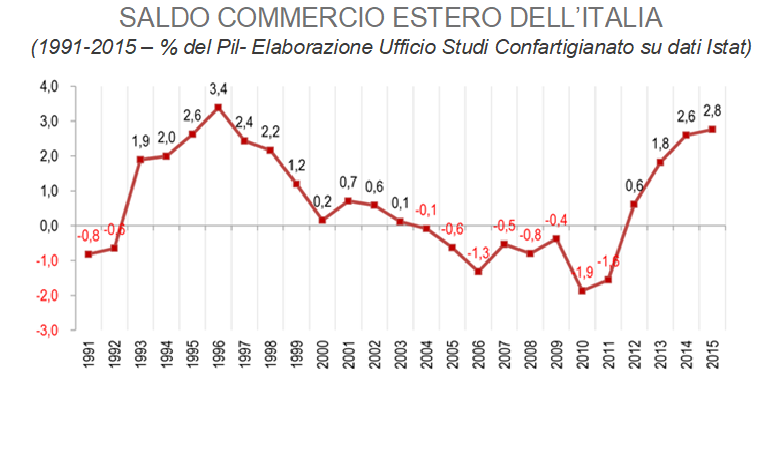
- Con la crisi del 1992/93, il sistema politico ha conosciuto un drammatico superamento del cosiddetto bipolarismo imperfetto, congelato negli anni ottanta per la sopravvivenza del PCI (bloccato tra spinte modernizzatrici e le sue radici nel movimento operaio) e le incertezze dei governi pentapartito (divisi tra forze clientelar-popolari e spinte liberiste). La trasformazione del PCI in forza social-liberale e poi Tangentopoli hanno aperto un nuovo assetto. La legge elettorale maggioritaria e la discesa in campo di Berlusconi hanno quindi riorganizzato un nuovo bipolarismo, con una matrice liberale trasversale. Però l’ampio dissenso del lavoro e delle classi popolari (attivato dall’esondare delle politiche neoliberiste), come le divisioni sociali e territoriali delle classi dominanti, hanno compromesso la forza e la stabilità di questo assetto. Da una parte, i due blocchi sono stati costretti a cooptare forze della destra o della sinistra sociale (dal PRC a MSI-AN), dall’altra si è reso comunque difficile costruire stabili maggioranze. Per vent’anni abbiamo quindi conosciuto vittorie alternate, determinate dalla mobilità del voto nelle classi subalterne (contro la maggioranza del momento e le sue politiche economico-sociali), seguite da governi spesso bloccati da conflitti interni.
- Questa transizione si è dispiegata durante un ciclo mondiale di recupero e rilancio dello sviluppo capitalistico. Il triennio 1979/81 (elezione di Thatcher e Reagan, governo Mitterrand e sua svolta neoliberista, vittoria di Deng e inizio dello sviluppo capitalistico nella Cina, invasione dell’Afghanistan e crisi polacca, rivoluzione iraniana) ha infatti segnato la chiusura del “lungo sessantotto” operaio, studentesco, femminista e dei movimenti di liberazione nazionale, sbocciato con l’esaurimento del ciclo espansivo postbellico. I primi anni ottanta hanno quindi visto l’avvio di una globalizzazione finanziaria e commerciale sotto l’egida di politiche neoliberiste (una globalizzazione costruita anche con le flessibilità monetarie successive alla svalutazione del dollaro ed il nuovo protagonismo delle istituzioni internazionali, impostato dalla lunga presidenza McNamara della Banca Mondiale); l’abbandono di politiche di compromesso sociale (welfare e redistribuzione dei redditi); l’estensione della valorizzazione capitalistica oltrecortina (rivoluzione passiva in Cina, stagnazione e crisi sovietica); l’esaurimento della decolonizzazione nei paesi periferici, il loro inserimento nei mercati mondiali e le conseguenti nuove dinamiche di subordinazione o resistenza nazionale. Non a caso dalla seconda metà degli anni ottanta la caduta tendenziale del saggio di profitto registra un arresto, ed anzi segna una piccola inversione per tutto questo ciclo, sino al 2009. Il crollo dell’URSS e il riassetto capitalistico cinese (giro al sud di Deng e XIV congresso del PCC) hanno quindi stabilizzato nei primi anni novanta questo ciclo espansivo. Un ciclo che è stato comunque segnato da diversi squilibri e contraddizioni: la persistente pressione della tendenza alla riduzione del saggio di profitto, nel quadro di un accresciuta competizione e di una nuova concentrazione del capitale; una crescente divergenza tra i saggi di profitto monopolistici delle multinazionali e quelli delle piccole imprese; una tendenza alla sovrapproduzione di merci e capitali; la crescita delle disuguaglianze sociali e dei disequilibri tra territori, anche per i processi di ristrutturazione e deindustrializzazione nei paesi a capitalismo avanzato; un grave, progressivo e accelerato logoramento dell’ambiente e delle sue risorse.
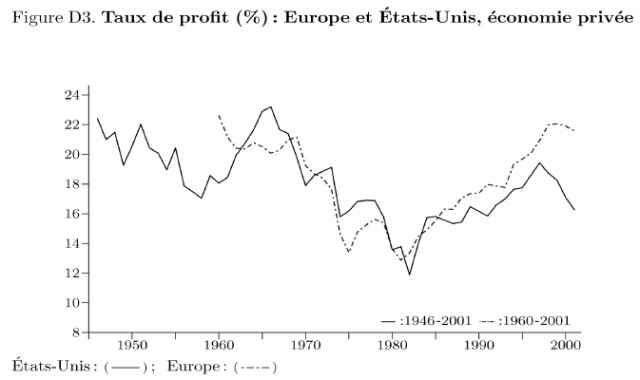
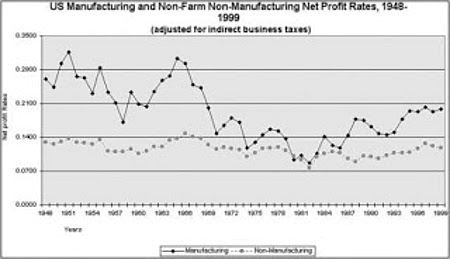
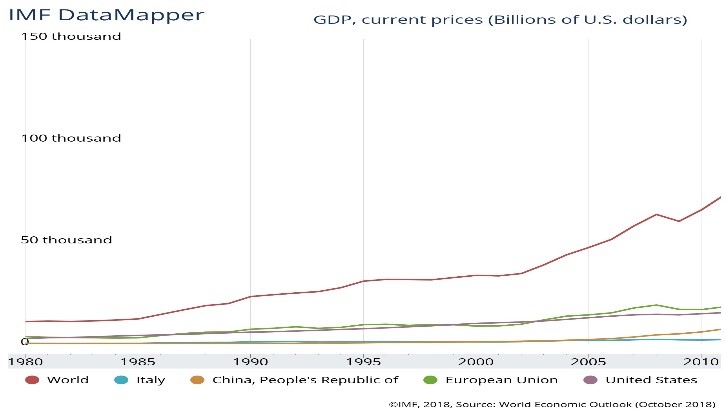
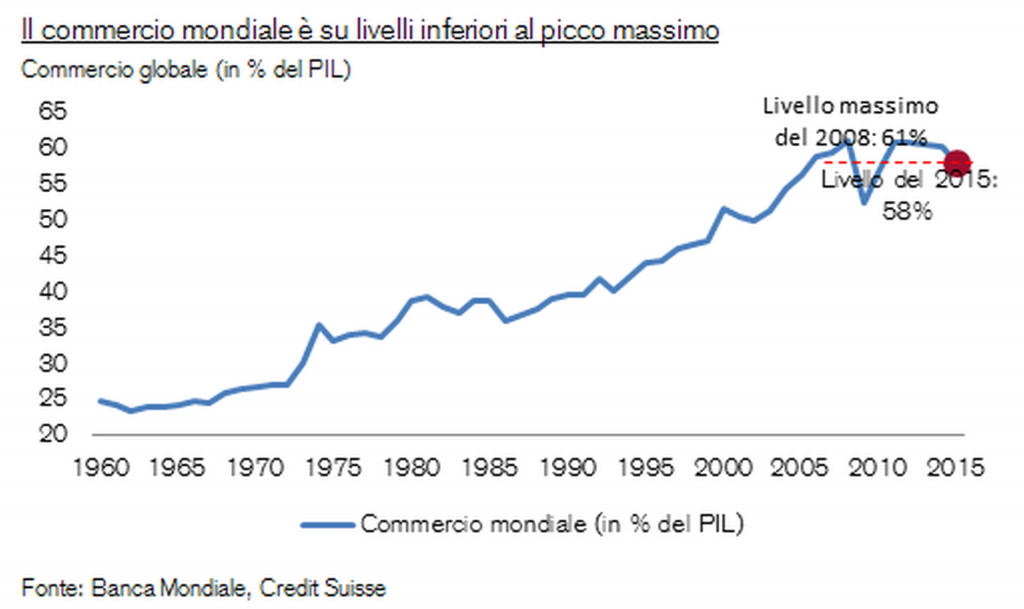
Per contrastare alcuni di questi limiti sono state dispiegate diverse controtendenze, che talvolta hanno amplificato contraddizioni e squilibri: l’intensificazione dello sfruttamento (riduzione salario diretto, indiretto e sociale; flessibilizzazione degli orari), l’estensione della valorizzazione capitalistica (nei servizi, nelle ICT, nei nuovi mercati), la crescita esplosiva della finanza internazionale con i suoi relativi crolli periodici (1987, 1994, 1997, 2001, ecc); la formazione o il rafforzamento di aree monetarie e commerciali a livello continentale (Nafta, UE, ecc). Un ciclo che è stato contraddistinto da molteplici resistenze: lavoratori e lavoratrici, che hanno subito l’aumento dello sfruttamento; un proletariato migrante coinvolto in un’estesissima ed accelerata urbanizzazione; il mondo contadino e rurale, in particolare nelle periferie, che ha subito il rapido inserimento nei mercati mondiali; molte popolazione locali, compresi settori di piccola e anche media borghesia, colpite dalla globalizzazione e dalle sue nuove gerarchie. L’Italia ha allora rappresentato in questo ciclo una sorta di “anello debole” tra i paesi a capitalismo avanzato (con un’elevata instabilità sociale, politica e istituzionale), conseguente alle diverse contraddizioni nel processo di integrazione europeo, nella struttura produttiva, tra i territori ed i soggetti del paese.
- La Grande Crisi ha interrotto questo ciclo espansivo, ma la sua gestione capitalistica ne ha evitato il crollo. La crisi, partita dalla flessione dei prezzi delle case negli Stati Uniti (2006) e dalla conseguente esplosione della bolla dei subprime (2007), ha infatti colpito il cuore del sistema finanziario internazionale (fallimento di alcune grandi banche d’affari newyorkesi, 2008), quindi i consumi ed i sistemi produttivi dei paesi a capitalismo avanzato (2009), poi le grandi banche europee e conseguentemente i debiti nazionali (2010), infine il commercio mondiale e l’assetto del precedente ciclo espansivo (dal 2010 in poi). La Grande Crisi è quindi arrivata in Italia con due pesanti recessioni (2009 e 2012) ed una lunga depressione, che ha tagliato quasi dieci punti di PIL e ridotto la capacità produttiva di oltre il 20%. La crisi in realtà si è ripercossa con forza in tutta la periferia europea: prima i crolli finanziari nei baltici, Irlanda e Islanda (2008-2009), poi l’annuncio di default in Grecia (2010, Papandreu scelse per l’occasione la magnifica Kastellorizo, l’isola in cui Salvatores ha girato Mediterraneo), infine le recessioni e le conseguenti speculazioni sui debiti pubblici di Portogallo, Spagna e soprattutto Italia (2010-2012).
La crisi però ha trovato anche una sua gestione capitalista. La nuova presidenza Obama, la dirigenza cinese intorno a Hu Jintao e poi Xi Jinping, la BCE di Draghi (unica reale direzione dell’Unione Europea) ed il nuovo governo Abe in Giappone hanno agito con determinazione per contenere il crollo dei mercati finanziari e garantire la riproduzione del circuito di accumulazione capitalistica. A questo scopo, sono stati abbassati quasi a zero i tassi di interesse (ed in alcuni casi si sono applicati persino tassi negativi, come in Giappone, Svezia, Danimarca, Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Malta e Olanda). Soprattutto, tutte le principali banche centrali (FED, BCE, PBOC e BOJ) hanno inondato di soldi l’economia, con un mastodontico intervento volto ad affogare la crisi nella liquidità, per contenerne gli effetti (memori degli anni trenta, una grande depressione esacerbata da politiche monetarie restrittive). I bilanci delle banche centrali, tra stampa diretta di moneta e acquisto di titoli (il cosiddetto quantitative easing), sono passati da 4mila miliardi di dollari nel 2007 a più di 20mila nel 2017: è quasi il 30% del PIL mondiale (circa 72mila mld di dollari nel 2017), contro solo il 6% della fine degli anni Novanta.
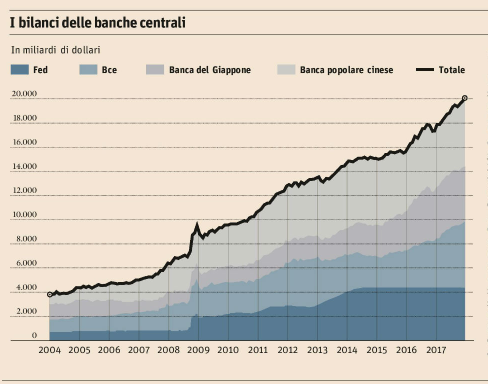
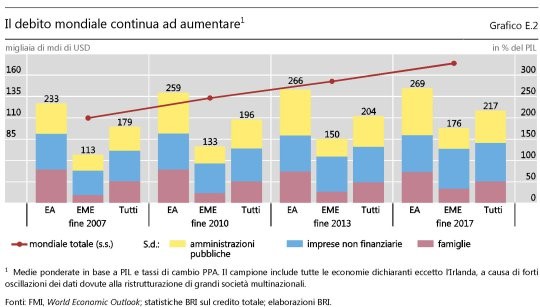
Un’inondazione che ha permesso di stabilizzare i mercati, anche attraverso una nuova e inusitata espansione del debito (da 162mila mld di dollari nel 2007 a circa 233mila nel 2017, più del triplo del PIL mondiale). Espansione trascinata dai debiti pubblici dei paesi a economia avanzata (EA) e che ha inevitabilmente riavviato la speculazione finanziaria internazionale. Questa gestione ha quindi permesso un fragile e contradditorio riavvio del ciclo.
Negli USA ha prodotto più di 110 mesi di crescita del PIL: una delle più lunghe della storia, ancora in corso, passando dai quasi 14mila mld di dollari del 2007 ai quasi 20mila mld del 2017 (il PIL italiano, al confronto, in questi dieci anni è calato da 2,2 a 1,9 mld di dollari). Una crescita che però non si è riflessa nella società ed ha aumentato le disuguaglianze: se la disoccupazione è tornata sotto al 5% (ai livelli pre crisi), la percentuale di adulti che lavorano è scesa stabilmente sotto il 60% (ci sono cioè oltre 15 milioni di americani che nel frattempo hanno smesso di cercar lavoro); lo stipendio settimanale medio è passato da 345 dollari a settimana ai 347 di oggi, dopo una caduta a 330 nel 2014; e l’indice di Gini (un indicatore della disuguaglianza) è nel frattempo salito da 0,466 a 0,479.
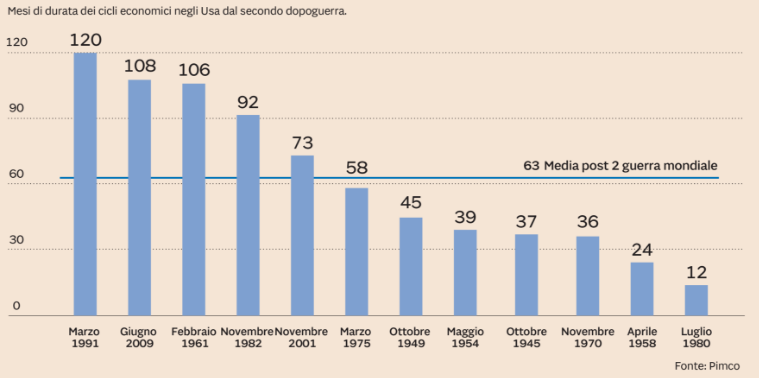
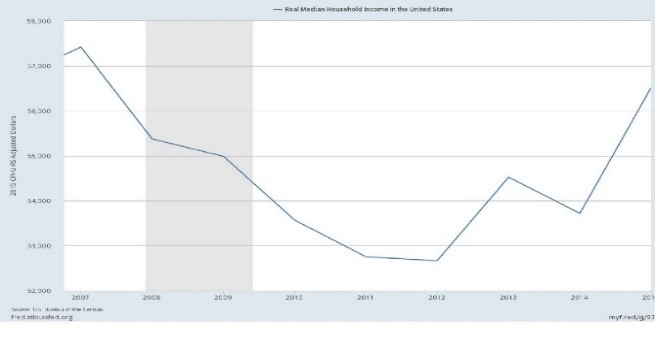
In Cina, il contraccolpo della crisi nel 2008-2009 (con una vistosa contrazione dell’export, il fallimento di 67mila imprese e la perdita di circa 20 milioni di posti di lavoro), è stato contenuto e superato. Non attraverso una ripresa del consumo privato (che ha iniziato a crescere solo dopo il 2012-2013), ma bensì attraverso una nuova sostanziale espansione degli investimenti (in particolare quelli strutturali, dalla tav alle strade), finanziata con centinaia e centinaia di miliardi del bilancio pubblico. Un modello di crescita che ha rilanciato gli squilibri e le contraddizioni dell’iper-espansione cinese di questi decenni, riducendo progressivamente la crescita del PIL (intorno al 6% annuo dal 12-14% prima della crisi) e facendo esplodere il debito complessivo (da circa il 140% del Pil nel 2009 a oltre il 260% di oggi).
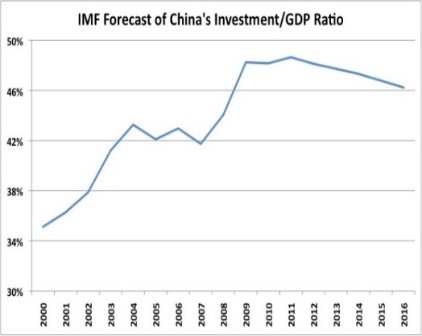
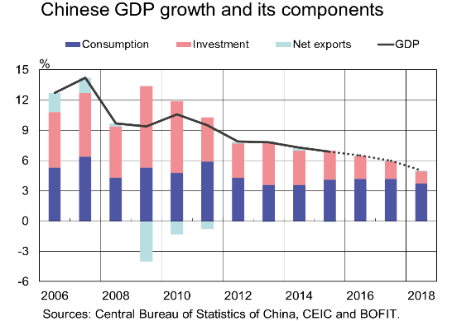
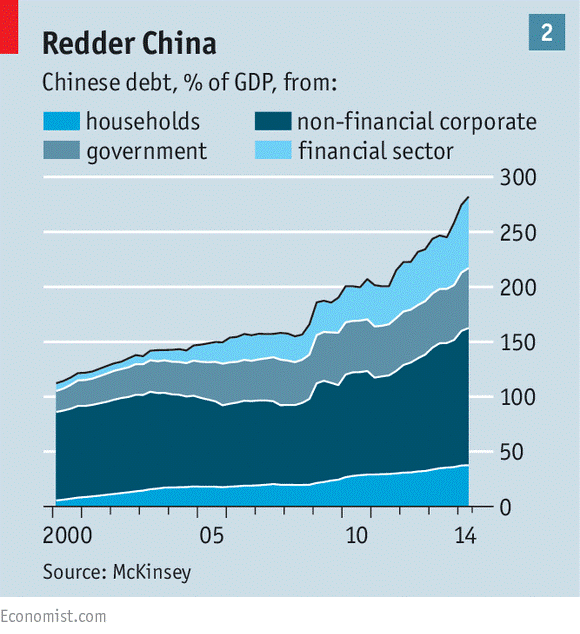
In Europa, la BCE ha garantito il contenimento della crisi dei debiti pubblici (il famoso “whatever It takes” del 2012) e quindi una stabilità del continente, pur con una crescita limitata e disomogenea. Si è registrata infatti una grave recessione nel 2009 (-4,4%) ed una più contenuta nel 2012 (-0,5%), con aumenti moderati del PIL negli altri anni (tra 1,5 e 2%). Quest’andamento è il risultato di dinamiche diverse. Ad esempio, la Polonia ha registrato una crescita costante; Germania, Francia e Regno Unito hanno conosciuto una stabile ripresa dopo il 2009; Grecia, Italia, Croazia e Portogallo non hanno invece ancora recuperato il Pil del 2007. Gli investimenti sono stati volatili (aumento nel 2007, crollo nel 2009, fluttuanti dopo il 2010): in Germania e Polonia in lenta crescita (dal 19 al 20% dei PIL), in Italia in calo (dal 21 al 17%), in Grecia e Portogallo un crollo (dal 21 all’11% e dal 23 al 15% dei PIL).
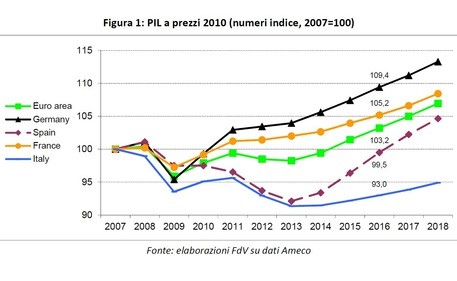
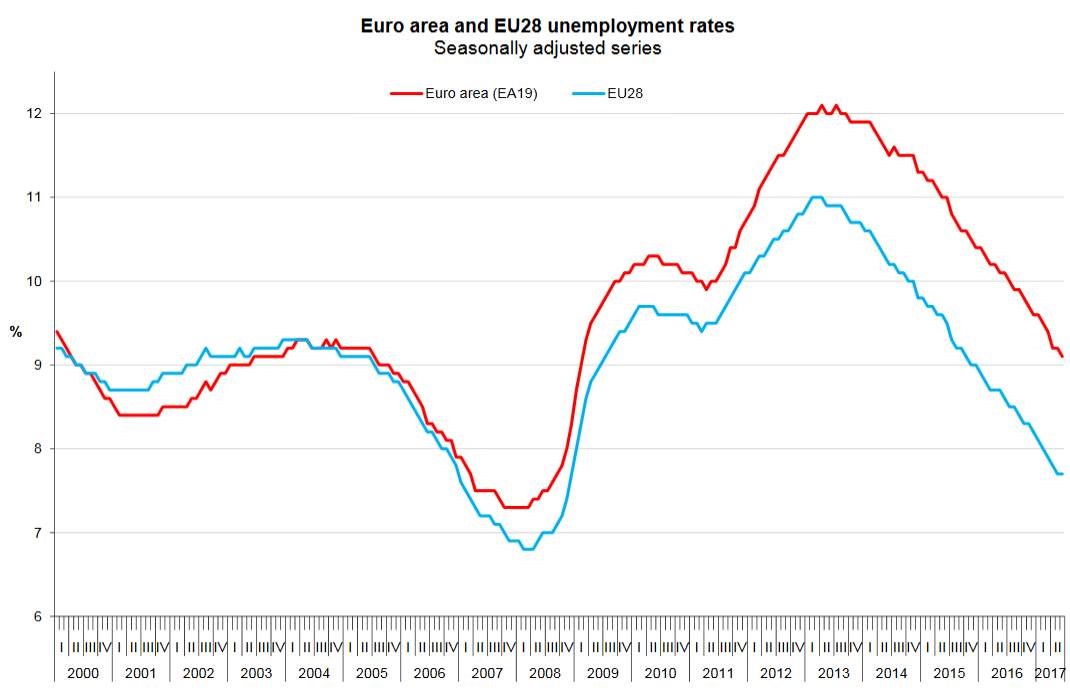
- La gestione della crisi non si è sostanziata solo in questa ondata di stimoli, ma ha condotto anche processi di ristrutturazione produttiva e sociale. Lo sforzo per garantire il riavvio di un’accumulazione ha comportato nei paesi a capitalismo avanzato una politica economica e sociale regressiva, finalizzata a garantire la ripresa dei tassi di profitto. In Europa Draghi, proprio mentre garantiva i debiti pubblici, ha non casualmente sottolineato anche il “superamento del modello sociale europeo”: BCE, Ue e diversi governi europei si sono infatti impegnati per smantellare le garanzie costituzionali dei diritti sociali ed i sistemi universali di welfare. Inoltre, come in ogni fase di crisi, si è colpito il lavoro su salario e orario. In una stagione di bassa inflazione, la politica di contenimento dei salari si è trasferita sulla loro stessa struttura, cercando di comprimere il più possibile la parte fissa (stabile e uniforme per tutti i lavoratori e lavoratrici di un livello), a favore delle componenti variabili (non solo instabili nel tempo, sulla base delle condizioni di mercato, ma anche diversificate tra i lavoratori, spesso legate a indici prestazionali individuali, di squadra o di stabilimento). L’orario, oltre che una pressione per un suo aumento assoluto (riduzione pause, ferie e festività; aumento orario settimanale tout court), lo si è reso più flessibile: da una parte introducendo turni (in modo di saturare i tempi di produzione), dall’altra allargando la multiperiodalità (per concentrarlo o ridurlo a seconda delle esigenze produttive, riducendo i costi), ed infine omogeneizzandolo (straordinari obbligatori e festivi lavorativi).
Parzialmente diverso è stato il discorso in Cina e in altri paesi asiatici, nel quadro di uno sviluppo ineguale e combinato. Le lotte di una nuova, estesa e concentrata classe operaia (pensiamo alle aree costiere cinesi, con i grandi stabilimenti Foxconn che raggiungono anche i 200mila dipendenti), oltre che la spinta determinata dalla stessa crisi a spostare le strategie di accumulazione da export e investimenti al consumo interno, hanno permesso negli ultimi dieci anni non solo il miglioramento di salari diretti e condizioni di lavoro, ma anche la riconquista di un salario sociale (in particolare pensioni e sanità).
Infine, nei paesi a capitalismo avanzato come in quelli emersi ed emergenti, la gestione capitalistica della crisi ha comportato ampie ristrutturazioni produttive (tentativo di conquistare posizioni mono od oligopolistiche sui mercati di riferimento, per poter inseguire tassi di iper-profitto attraverso acquisizioni o focalizzazioni della produzione; concentrazione con aumento del valore aggiunto sui singoli prodotti; digitalizzazione della produzione e sua automazione, per poter integrare organicamente progettazione, produzione e commercializzazione e ridurre drasticamente i costi). In un periodo di crisi, tali ristrutturazioni (che spesso comportano investimenti significativi) si sono concentrate in settori e imprese ad alta remunerazione. Anche se poi il sostegno pubblico, fiscale e infrastrutturale, le ha estese (Industria 4.0, Industrial Internet, Industrie du Futur, High Value Manufacturing, Made in China 2025)
- La Grande Crisi e le sue politiche di gestione hanno quindi radicalizzato i disequilibri italiani. Come evidenziato nei grafici precedenti, infatti, l’Italia ha aumentato la distanza dalle altre potenze europee. La crisi ha ulteriormente frammentato il suo sistema produttivo. Non lo ha fatto scomparire, come molti hanno supposto: l’Italia rimane la seconda potenza manifatturiera del continente. Si è però scomposto in diverse direttrici. Molte grandi imprese hanno ridotto fatturato e manodopera: da Eni (che passa da quasi 90 mld di fatturato nel 2007 a circa 55 nel 2017, da quasi 80mila a 33mila dipendenti) a Telecom (da 31 a 19 mld, da 76 a 66mila), da Techint (da 25 a 18 mld, da 59 a 50mila) a Unicredit (da 27 a quasi 19 mld, da 175 a 150mila), da Leonardo (Finmeccanica, da 15 a 12 mld, da 60 a 45mila), da Intesa (da quasi 18 a 16,9 md, da 107 a 90mila) a Finivest (da oltre 6 a 4,7 mld). Alcune sono cresciute, anche sensibilmente, per acquisizioni o espansioni di mercato (Poste, da 20 a 33 mld di fatturato; Enel, da 60 a 70 mld; Ferrero, da 6 a 10 mld; Fincantieri, da 2,9 a 4,2 mld). Altre sono diventate perno di multinazionali (FCA, Luxottica, Atlantia) o ne sono state acquisite (Pirelli in Chemchina, Ansaldo STS in Hitachi, Ducati in VW, Eridania in Cristalalco, Italcementi in HeidelbergCement, Prada in LVMH, ecc). Altre ancora sono scomparse, si sono ridotte di scala o si sono dovute subordinare ai propri acquirenti (da Alitalia a Parmalat, da Perugina alle principali acciaierie italiane come Ilva, Terni e Piombino). La piccola impresa si è sostanzialmente ridimensionata (con migliaia di fallimenti e chiusure). Nei distretti e nei territori, però, proprio in questi anni si sono sviluppate o agglomerate alcune “piccole” multinazionali, centrate sulle esportazioni: è il cosiddetto quarto capitalismo, composto da medie imprese all’inizio spesso con poche centinaia di dipendenti, che sono cresciute sino ad arrivare tra gli uno e i tre miliardi di fatturato (da Indesit a Mapei, da Brembo a Calzedonia, da Lavazza a De’Longhi, da Geox a Tod’s). È questo settore che consente alle PMI italiane di recuperare e persino ampliare il fatturato complessivo rispetto al 2007. Si sono quindi divaricate le strategie di accumulazione: alcuni rilanciano automazione e investimenti (gruppi maggiori e il quarto capitalismo +4,9% rispetto al 2007); altri, in settori affamati di capitali o concentrati sui mercati locali, intensificano al massimo lo sfruttamento. È cresciuta quindi la disoccupazione, con una caduta soprattutto degli operai (-8%), mentre aumentano gli impiegati (+1,5%): infatti anche se nelle PMI rimane stabile la quota operaia, nei gruppi maggiori che hanno esternalizzato o ridotto la produzione cala la sua incidenza. Si sono divaricate soprattutto le differenze tra territori e aree del paese, in particolare nel meridione che ha conosciuto una nuova desertificazione industriale, l’esplosione della disoccupazione ed il ritorno ad una migrazione di massa (non solo giovane ed intellettuale).
- È cambiata la struttura del paese: è venuto meno il baricentro del grande capitale, è collassato il blocco dei ceti medi, si è sfaldata l’identità della classe lavoratrice. In primo luogo, si è frantumata l’egemonia sociale e politica del grande capitale italiano. Il “salotto buono” delle grandi famiglie e dei suoi funzionari (Agnelli, Pirelli, Pesenti, Ligresti, Tronchetti Provera, Caltagirone, Benetton, Cuccia, Geronzi, Palenzona, ecc), in grado di dare e nel caso imporre un asse di regolazione al sistema produttivo, si è disarticolato. La frammentazione produttiva, radicalizzata dalla crisi, ha quindi frastagliato le politiche padronali: dal modello Marchionne a quello Luxottica, dalle fuoriuscite dalle associazioni datoriali all’incremento esponenziale dei contratti nazionali. Si sono quindi moltiplicate le linee di frattura all’interno del blocco borghese, tra le sue frazioni ed i suoi principali esponenti. Di conseguenza, si è indebolita la capacità del grande capitale di influire sulle politiche del paese, di controllare e guidare il sistema politico e sociale. In questo quadro, rientra anche l’indebolimento e la delegittimazione del sistema bancario. Da una parte si è ridotto il volume dei grandi istituti (da quelli più continentali, come Unicredit, a quelle più legati agli equilibri nazionali, come Intesa o MPS) e si sono terremotati molti dei piccoli e medi, che spesso avevano puntato sulle speculazioni per sorreggere la propria espansione (in particolare in Veneto, Toscana e Lombardia). Dall’altro, i tracolli che si sono riversati su risparmi e risparmiatori hanno prodotto un cambio di percezione sociale sia per i grandi istituti (non più campioni che difendono gli equilibri nazionali o conquistano mercati, ma semplici “prenditori”), sia della rete del credito (vista la diffusa emersione di trame e raggiri, su cui si reggevano equilibri e circuiti affaristici territoriali). Nel contempo, è cambiata la struttura sociale, modificando rappresentazioni collettive e appartenenze di classe. Come riportano diversi studi (Istat, Datamedia, Barbagli), questo è vero soprattutto per la classe media e quella lavoratrice.

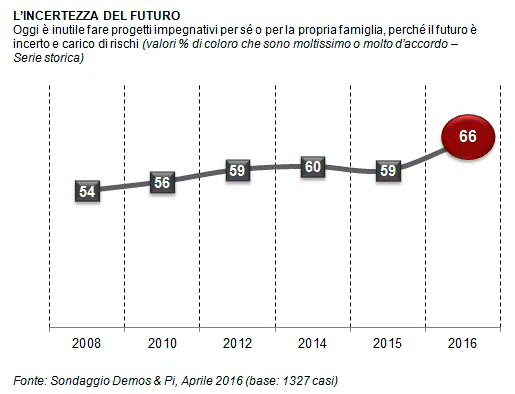
- In secondo luogo, infatti, è collassato il blocco della piccola impresa e della media borghesia. La “terza Italia” dei distretti e delle piccole imprese, che era prepotentemente emersa negli anni ottanta, è colpita al cuore dalla crisi (crollo dei consumi e restrizione del credito) e dall’euro (impossibilità di svalutare). Non è l’unico settore della piccola borghesia che è colpito. I piccoli commercianti sono stretti anche dall’incudine della liberalizzazione e della crescita impetuosa dell’e-commerce: in dieci anni, si riducono di 63mila unità (-10,9%: soprattutto edicole, librerie, alimentari, calzolai, erboristerie, ecc); un calo concentrato nelle grandi città e non compensato dall’aumento di altre attività, spesso incastrate in catene nazionali e internazionali (alberghi, bar e ristoranti, meno di 40mila nel decennio). Dinamiche anche più radicali di impoverimento, se non di proletarizzazione, hanno coinvolto alcuni professionisti, improvvisamente inseriti nei circuiti di valorizzazione del capitale in processi di sussunzione formale (false e vere partite IVA, freelance, ecc) e persino reale (nuove associazioni e società di servizi, come Caredent o Medical Line Consulting). Non è solo un dato produttivo. Questi settori, soprattutto nell’ampia provincia italiana, nella fase precedente si erano culturalmente e politicamente saldati tra di loro e con altri di matrice tecnico-impiegatizia (quadri e dirigenti, pubblici e privati). Questo blocco ha rappresentato nel corso della lunga transizione italiana l’asse portante delle cosiddette classi medie: un “blocco d’ordine” che ha sostenuto politiche anti-salariali, defiscalizzazioni e federalismo (il cuore del centrodestra). La crisi del piccolo capitale, del piccolo commercio e dei piccoli professionisti segna allora una divaricazione fra diverse frazioni della piccola borghesia, lo sfaldamento di questo “blocco d’ordine” che viene quindi interessato da processi di polarizzazione sociale e politica. Non sono solo gli interessi contingenti che si divaricano, ma anche e forse soprattutto le percezioni e le emozioni collettive (aspettative, frustrazioni, speranze, paure e rabbie). Se guardiamo i dati della tabella sopra riportata, vediamo un calo drastico (oltre il 20%) della soddisfazione in imprenditori, professionisti e piccola borghesia, mentre dirigenti e impiegati la mantengono o la riducono molto di meno (secondo l’ISTAT, più di dieci milioni di persone, con un buon tenore di vita, un diploma di scuola superiore e spesso laureati, a cui potremmo forse aggiungere la categoria dei “pensionati d’argento”, oltre 5 milioni, con livello di istruzione alto, reddito elevato, alto livello di spesa). Altri dati della stessa ricerca segnalano un sorpasso un tempo impensabile: persino gli operai sono più soddisfatti dei lavoratori autonomi per la propria situazione economica (nonostante l’evidente contrazione della soddisfazione anche in lavoratori e lavoratrici).
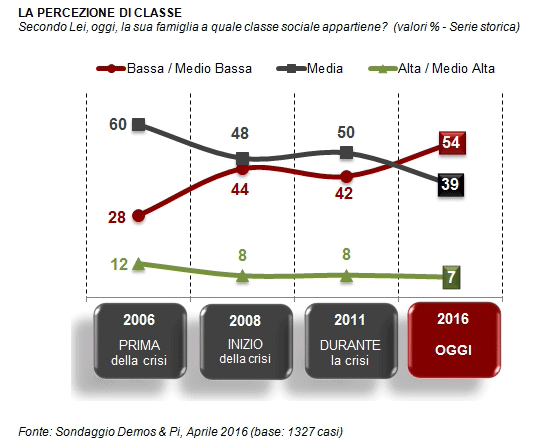
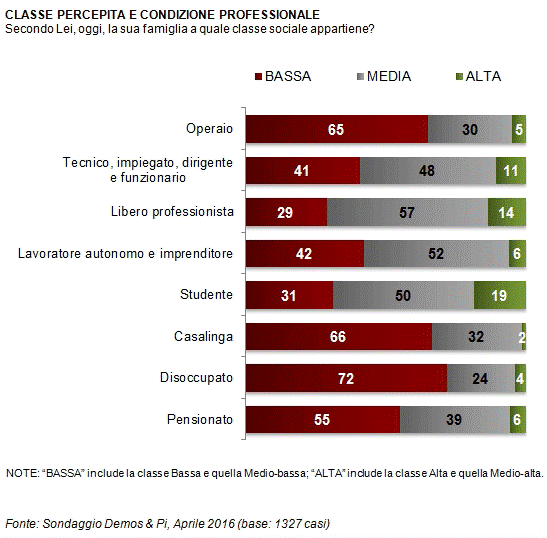
- In terzo luogo, infine, si è sfaldata la classe lavoratrice. Nella lunga transizione italiana era già emersa la scomposizione del lavoro. Le sconfitte dei primi anni ottanta (dalla FIAT alla scala mobile) avevano tracciato o rilanciato linee di faglia tra pubblici e privati, grande e piccola impresa, contratti a tempo indeterminato e precari (in particolare dopo le leggi Treu e Biagi), italiani e migranti (in particolare quelli nei settori marginali come edilizia, logistica, raccolta), nord (dove rimaneva radicata una cultura industriale e contrattuale) e sud (dove l’incrocio tra patti territoriali, deindustrializzazione, vecchi e nuove grandi stabilimenti perpetuava debolezze e disomogeneità). Linee di faglia che avevano reso difficile la costruzione di un blocco delle classi subalterne. Queste linee di faglia, però, sono state contenute da diverse controtendenze: una forte partecipazione sindacale, in particolare nella media-grande impresa e nel pubblico (iscrizioni oltre il 30%, voto alle RSU, adesione agli scioperi); l’impostazione generalista dalle confederazioni, pur con una matrice concertativa; la presenza di avanguardie organizzate in settori centrali, in grado di resistere e avviare nuovi cicli di lotta (talvolta in CGIL, FIOM e non solo; talvolta nei sindacati di base, come in scuola, trasporti, precari, ecc); periodici conflitti che erano in grado di segnare il panorama politico, gli immaginari e le identità collettive, oltre che alcune vittorie (il ‘92 dei bulloni; le lotte contro le chiusure, dal Sulcis a Crotone; il No a Dini nel 95; la lotta contro il concorsone della scuola nel 98-99; le mobilitazioni in difesa dell’articolo 18 nel 2001-2003; i 21 giorni di Melfi nel 2004); la presenza di forze politiche che, pur tra mille contraddizioni e ambiguità, continuavano a coltivarne identità e immaginari (il PRC e, a lungo, alcuni settori DS).
La Grande Crisi ha visto però allargarsi le linee di faglia e indebolirsi diverse controtendenze. Quasi tutta la sinistra, proprio prima della crisi (2006-08), ha compartecipato al governo Prodi (squalificandosi agli occhi delle classi subalterne) e nel contempo ha abbandonato l’identità del lavoro (PD e Sinistra Arcobaleno). I principali conflitti degli anni seguenti sono stati conclusi nel vuoto, sospesi e abbandonati, con sconfitte a cui non è seguita nessuna elaborazione collettiva (Fiat, pensioni, Jobsact, buonascuola). La precarizzazione si è intrecciata con la progressiva destrutturazione dei luoghi, delle reti e dei nodi di sostegno delle identità di classe (quartiere, circoli, radio, giornali). Lavoratori e lavoratrici di ogni categoria e territorio si sono attestati su punti di tenuta e caduta diversi, rendendo difficile far circolare i conflitti, condividere immaginari ed identità comuni (perché nella frammentazione produttiva, diverse sono condizioni, temi, percorsi e anche le composizioni di classe che le sostengono). Ogni categoria, ogni realtà, talvolta ogni stabilimento è spesso diventato un mondo a sé stante. Nelle parole di un operaio, intervistato in uno studio sociologico e coinvolto in prima linea in una lunga vertenza del milanese, è facile sentirsi “metalmeccanico” (anzi, questa identità è stata rianimata proprio dal lungo picchetto che ha caratterizzato quella vertenza), ma oramai non c’è nessuna aspettativa o immaginario di un conflitto generale di cui si sarebbe parte. Si sfalda cioè l’identità di classe: evapora la rappresentazione, anche solo la percezione, di uno scontro generale tra capitale e lavoro. In questo quadro alcune ricerche hanno recentemente provato a identificare nuovi macro-raggruppamenti in formazione nelle classi subalterne. La classe operaia blue collar, 6/7 milioni di cui più di 3/4 a tempo indeterminato, organizzata nelle imprese medio grandi e dispersa nelle piccole. Gli operai in pensione, oltre 10 milioni, con un reddito medio e stabile. Il precariato intermittente o disoccupato (6/7 milioni), non più giovane (oltre 40 anni), spesso con figli e ad alto rischio povertà. I lavoratori e le lavoratrici migranti, 5 milioni, il gruppo più giovane, spesso soli (35,7%) o senza figli (34,4%), con le peggiori condizioni economiche. Le famiglie marginali (oltre i 5/6 milioni), anziani soli a basso reddito e coppie disoccupate con molti figli (4,3 componenti familiari in media), a rischio povertà.
- Nel sistema politico, la Grande Crisi ha quindi determinato da una parte il logoramento dei due blocchi principali, dall’altra una maggior instabilità istituzionale. La recessione del 2009 e la crisi dei debiti pubblici del 2010 ha portato ad implodere il governo Berlusconi, anche in seguito alla pressione delle istituzioni europee e dei mercati. Per diversi anni si sono quindi succeduti governi tecnici, di larghe e piccole intese (Monti e Letta). I due poli, infatti, alle elezioni politiche del 2013 sono passati da oltre l’84% dei consensi a meno del 59%, rendendo impossibile una maggioranza parlamentare di uno dei due blocchi (considerato che il maggioritario, al Senato, è costituzionalmente basato sulle singole circoscrizioni regionali): il centrosinistra è calato dal 37,55% del 2008 al 29,55% del 2013, il centrodestra dal 46,81% del 2008 al 29,18% (tracollo non compensato dalla crescita del centro, passato dal 5,62% al 10,56%). Il dato nuovo è quello dei cinque stelle, che conquistano oltre il 25% dei consensi, e la crescita del non voto (l’astensione passa dal 19,5% al 24,8%, mentre i voti validi scendono da 36,5 a 34 milioni). Questa dinamica ha reso più complessa ed incerta la formazione dei governi, radicalizzando l’instabilità precedente. Si è resa quindi palese la crisi di egemonia delle classi dirigenti e la necessità di un cambiamento di sistema.
- In questo quadro, Renzi ci ha provato. Il nuovo leader del PD, diventato premier nel 2014 sulla base di una maggioranza parlamentare di “piccola intesa”, ha provato cioè a farsi carico sia della costruzione di un nuovo blocco sociale dominante, sia della revisione istituzionale necessaria a garantire una stabilità di governo.Da una parte, ha ridisegnato il PD come “partito della nazione”, fuori dai tradizionali schemi destra/sinistra e dalle rappresentanze sociali del novecento, con l’obbiettivo di raccogliere e condensare gli interessi dei ceti medi in scomposizione, della borghesia impiegatizia e di quella imprenditoriale, agglutinandole nella visione di un futuro di speranza e crescita economica (80 euro di bonus, buonascuola e Jobsact come rilancio dello sviluppo).
Dall’altro, ha tracciato nelle prassi e nella riforma costituzionale una nuova centralizzazione, di impianto autoritario e plebiscitario, in grado quindi di garantire nell’azione del governo (dello Stato) le esigenze di ristrutturazione imposte dalla gestione capitalistica, di ricomporre nel governo (nella sua persona) l’egemonia su soggetti sociali scomposti e frammentati.
Renzi ha fallito. Ha fallito cioè il suo tentativo di rappresentare questi nuovi assetti in formazione (il nuovo baricentro della struttura produttiva, la divaricazione nei ceti medi, l’impoverimento e la scomposizione delle classi subalterne), proseguendo la gestione capitalistica della crisi secondo le direttrici liberali dell’ultimo decennio. Da una parte, il suo futuro di speranza è stato costruito su una montagna di parole, evaporate con la prosecuzione della lunga depressione e delle sue contraddizioni. Dall’altro, il suo progetto ha negato percezioni ed emozioni diffuse: la fatica, la rabbia, la preoccupazione, la paura dovute all’impoverimento di ampie fasce di popolazione e di elettorato. Cioè, la sua politica e la sua retorica hanno fatto presa su settori limitati (i ceti medi soddisfatti), contrapponendosi frontalmente ai sentimenti dominanti proprio in quei settori di piccola e media borghesia, a quelle classi subalterne e popolari, a cui si rivolgeva con il partito della nazione. Anzi, proprio il suo stile (dal jobsact alla buonascuola) ha suscitato un’ampia reazione (attiva e passiva, con movimenti di piazza e una sfiducia diffusa), sviluppando un progressivo ricompattamento contro la sua persona. Renzi ha quindi fallito, ma sul suo fallimento è emerso un nuovo quadro politico, potenzialmente in grado di rappresentare i nuovi assetti sociali e di stabilizzare una nuova gestione capitalistica della crisi in questo paese.
- Le elezioni 2018 segnano un cambio di fase, facendo prevalere tendenze che si stavano sviluppando da tempo: movimenti reazionari e una diversa gestione della crisi. La gestione liberale della crisi dell’ultimo decennio ha determinato un diffuso disagio sociale. L’egemonia delle classi dominanti è stata scossa in tutta Europa, con specifiche dinamiche in ogni realtà (anche relative al precedente ciclo ed alle contraddizioni dell’integrazione). In ogni caso, ovunque si è logorato il consenso socialista e popolare, aprendo una fase di instabilità politica e anche istituzionale: dalla Germania alla Gran Bretagna, dalla Spagna alla Francia. Non solo: in questi anni si sono sviluppati movimenti importanti contro questa gestione (oltre a quelli italiani contro jobsact e buonascuola nel 2014-2015, ricordiamo le mobilitazioni britanniche in difesa del welfare del 2011, gli indignados spagnoli del 2011/12, le lotte belghe contro l’austerità del 2016, quelle francesi sulle pensioni del 2010 e sulla “Loi du travail” del 2017, le decine di scioperi generali greci contro la troika). Questi conflitti, però, sono stati relativamente contenuti, episodici e tra loro scollegati. L’unico momento in cui è parso seriamente in discussione lo stato di cose esistenti è stato nel 2014-15 in Grecia. La radicata e permanente mobilitazione, la vittoria di Tsipras, le resistenze iniziali alla troika da parte del governo Syriza-Anel (sinistra e destra nazionalista), la netta vittoria dell’Oxi (il no) al referendum sul piano dei creditori: pur nel sostanziale isolamento (al di là di una simpatia diffusa, non si sono sviluppati particolari movimenti di solidarietà), tutto questo è parso aprire una seria crepa nella gestione liberale della crisi. La capitolazione dell’estate 2015, con la piena assunzione di politiche antipopolari da parte del governo Tsipras (dai tagli alle privatizzazioni, dall’individualizzazione dei contratti alle norme antisciopero), non ha solo determinato la sua piena integrazione nella sinistra riformista, ma anche una relativa stabilizzazione delle politiche continentali di gestione della crisi stessa.
In questo quadro (in cui la crisi e la sua gestione hanno consumato l’egemonia delle classi dominanti e sollevato ampi movimenti, ma la scomposizione della classe lavoratrice e le sue direzioni riformiste/confuse non hanno innescato una rottura di sistema) si è sviluppata una diversa ipotesi di gestione capitalistica della crisi, contrapposta a quella dominante. Non è ancora un’impostazione organica. Soprattutto, non trova ancora il pieno sostegno del grande capitale, almeno in Europa e Stati Uniti. Con il protrarsi della crisi, però, e con l’acutizzazione dei conflitti interimperialistici, emerge con sempre maggior forza l’opportunità di una svolta. Cioè, il ritorno di un diffuso interventismo statale, dalla regolazione dei capitali alla difesa delle proprie imprese (non solo politiche fiscali, incentivi e sussidi, ma anche il diretto sostegno e controllo di aziende strategiche). Politiche assumibili e assunte da movimenti reazionari, nazionalisti o anche xenofobi, in una logica di difesa della propria comunità contro i nemici esterni. Movimenti che, sviluppando strategie corporative di parziale redistribuzione, riescono a conquistare ampi consensi non solo sulle paure indotte dalla crisi, ma anche con politiche sociali comunitarie e sicuritarie. In questo modo, possono quindi sostenere una relativa stabilizzazione e perseguire quelle politiche contro il lavoro indispensabili alla gestione capitalistica della crisi. Movimenti quindi non semplicemente di contestazione, ma anche di governo: hanno sospinto la Brexit e guidano paesi intermedi (PiS in Polonia e Fidesz in Ungheria), ma per certi versi anche potenze asiatiche (Abe in Giappone, Modi in India, Duterte nelle Filippine e Xi Jiping in Cina) e gli USA con Trump.
In questo quadro, le elezioni italiane del 4 marzo hanno avuto un significato storico. Come quelle del ‘48 (egemonia DC), del ‘76 (PCI oltre il 30%) o del ‘94 (Berlusconi). Hanno segnato cioè una discontinuità e tracciato un nuovo scenario, con la vittoria di movimenti reazionari “di governo”: la Lega al 20% nelle ex-regioni rosse, al 14 in Lazio ed al 5 nel Sud; il Movimento5stelle al 20% al nord e quasi al 50% nel sud.
- Lega e 5stelle: matrici comuni e differenze di due movimenti reazionari. Lega e 5 stelle sono infatti due formazioni reazionarie che, nel quadro della lunga transizione italiana, hanno interpretato questa domanda di svolta nella gestione della crisi, ricompattando classi medie e subalterne. Certo, queste due formazioni sono diverse per storia, base sociale e profilo politico. La Lega si è strutturata all’inizio del precedente ciclo (‘92/’94), come movimento antisistema che interpretava rabbie e insoddisfazioni della provincia padana. Nel tempo si è ridefinita come forza di destra, sia nella sua collocazione politica, sia nella percezione del proprio elettorato. La svolta salviniana, dopo l’emarginazione del cerchio magico bossiano, ha accentuato questa connotazione proiettandola fuori dal recinto settentrionale. Il M5S è molto più recente ed ha ancora, nella percezione dell’elettorato e nella sua stessa composizione, diverse connotazioni antisistema dei primordi (i vaffaday e la lotta contro la casta). Inoltre, il M5S ha avuto sin dalle sue origini tratti progressisti, rilanciati dal legame con movimenti di base, comitati civici e ambientalisti. Da questa radice provengono infatti alcuni temi portanti della sua identità (la partecipazione, i diritti, l’uguaglianza, la contrapposizione all’establishment), flirtando anche con culture acapitalistiche o addirittura anticapitalistiche (la decrescita felice, i notav, gli antisignoraggio, ecc).
Entrambi questi movimenti, però, si costituiscono intorno agli interessi e alla rappresentanza di alcuni settori di piccola e media borghesia (la Lega sugli imprenditori dei distretti e delle PMI; i 5stelle sui professionisti, in particolare quelli di nuova genererazione). Entrambe, soprattutto, propongono una rappresentazione comunitaria della realtà (gli uni intorno al popolo padano prima ed italiano poi, gli altri intorno al cosiddetto “popolo della rete”). Sono forze “reazionarie”, allora, perché promuovono la nostalgia di un tempo mai vissuto: il “ritorno” ad un mondo idealtipico, mai esistito e mai esistibile, in cui la vita sociale e l’economia è dominata da piccoli imprenditori e autoproduttori cognitivi, protetti dallo Stato dalla famelica grande finanza e dai sicofanti al suo servizio (la BCE, le banche, la casta, Roma Ladrona, ecc). In questo modo interpretano frustrazioni e paure, occultando ogni contrapposizione nelle loro comunità immaginate, in primo luogo quelle di classe.
Il governo Conte, dopo lungo travaglio, si è quindi formato non perché Lega e 5stelle siano le due forze che hanno vinto le elezioni, ma perché le loro nature e i loro programmi sono amalgamabili: se le loro ragioni sociali fossero state antitetiche, non sarebbe nemmeno cominciato un discorso. Certo, hanno identità e storie diverse, rappresentano diversi settori, ma hanno una matrice comune su cui possono sviluppare un’azione comune. Il programma di governo, il famoso “contratto”, è espressione di questa natura e di questa possibilità: dalla Flat-tax (la diminuzione radicale delle tasse ai padroni) al reddito di cittadinanza (nella versione reale dei 5stelle, non quella evocata, cioè l’individualizzazione monetaria dei servizi sociali in un regime di lavoretti obbligatori a basso stipendio); dalla repressione dei migranti ad una maggior liberalizzazione della legittima difesa; da nuove politiche protezioniste ad un rinnovato protagonismo sovranista. In questo quadro, allora, si collocano le ancora incerte ed ambigue proposizioni sull’euro: non la messa in discussione radicale dell’austerità e del carattere padronale dell’Unione Europea, ma la costruzione di politiche economiche in grado di salvaguardare maggiormente il capitale nazionale (questa è l’evidente cifra, politica e autobiografica, del ministro Paolo Savona).
- Infine, una nota sulla sinistra in questo ulteriore passaggio di fase. Le elezioni 2008, dopo la disastrosa compartecipazione al governo Prodi, hanno ridimensionato il suo consenso e la sua influenza per tutto il decennio, aprendo anche divisioni profonde sul rapporto con il PD (partito liberale di massa a vocazione maggioritaria, con una componente laburista sempre più rachitica). È sopravvissuta con rappresentanze ridotte nei territori, nelle Camere (qualche esponente del centrosinistra e SeL-SI dal 2013) e in Europa (lista Tsipras). I processi di sfaldamento dell’identità di classe, le sconfitte e poi l’assenza di movimenti generali, hanno quindi progressivamente rattrappito il popolo di sinistra. Non solo nella sua consistenza, ma anche nelle proprie identità. La disfatta del 4 marzo e delle amministrative (Terni, Pisa, Massa, Siena, Ivrea, Imola, ecc) è illuminata da tanti reportage: dal CEP di Pisa a Sampierdarena, dalla Bolognina al Valdarno, quello che emerge è il passaggio delle classi subalterne alle nuove formazioni reazionarie. Non è un semplice fuga dal centrosinistra. È un passaggio identitario. Ne è un’immagine plastica quella degli applausi e dei fischi ai funerali delle vittime del ponte Morandi. Un passaggio che avviene soprattutto nel lavoro (occupato e disoccupato), in particolare nel lavoro organizzato (dalle fabbriche lombarde a Melfi). I settori che ancora votano PD sono spesso quelli con una composizione sociale e politica più arretrata. In questo quadro, il popolo di sinistra non solo si rattrappisce, ma al suo interno penetrano temi e impostazioni neomercantiliste, aclassiste, popolar-plebiscitarie: su migranti, Europa, rappresentanze, comunità di riferimento e uomini del destino, semplificazione dei processi e dei conflitti. In questo quadro, i settori più combattivi, le avanguardie sociali, si riducono spesso a dimensioni minimali, scomposte ed isolate anche nelle proprie realtà, alla ricerca di una dimensione di massa che sfugge spesso alla loro comprensione. In questo quadro, in una sinistra ridotta a qualche centinaio di migliaio di voti e qualche decina di migliaia di attivisti, risultano isolate soprattutto le visioni e le componenti classiste ed internazionaliste (che sono più in controtendenza con senso comune e sentimenti dominanti), mentre ritrovano una piccola prospettiva impianti sovranisti, campisti o “nazional-popolari” che sembravano essersi annichiliti negli anni precedenti (PCI, PC di Rizzo, RdC, le impostazioni mutual-popolari di pap,, ecc).
La costruzione del PCL
- In questa lunga transizione, si sono sviluppati processi di scomposizione e ricomposizione di tutta la sinistra. In primo luogo, con l’improvviso scioglimento del PCI, si è vissuto un rapido tramonto dell’egemonia di questo partito su larga parte della classe lavoratrice di questo paese. Con il cambio del nome si è infatti rattrappito il consenso (da 9 milioni di voti del PCI nel 87-89, circa il 28%, ai 6 milioni del PdS, circa il 16%, nel 1992), l’organizzazione (da 1milione e 400mila iscritti al PCI nel 1989 ai 700mila del PdS nel 1992-93) e quindi anche la storica presa sulle masse della sua impostazione togliattiana (una pratica democratico-riformatrice, di governo del sistema, in una confusa prospettiva di trasformazione sociale di impronta genericamente comunista). Da una parte le nuove forze eredi di questo partito (Pds, DS, Ulivo) si sono date una matrice sempre più esplicitamente social-liberale, estraniandosi progressivamente dalla sinistra ed in diversi momenti contrapponendosi direttamente al mondo del lavoro (facendosi portatori in prima persona delle politiche di austerità e delle connesse controriforme, dalle privatizzazioni alla precarizzazione). Dall’altra, intorno ad un nucleo di matrice stalinista e togliattiana (la composita area cossuttiana del PCI) si sono raccolte altre aree (da Garavini a settori ex-Pdup e FGCI), capaci di dar vita ad un percorso di resistenza con una dimensione non residuale (circa 120mila iscritti ed oltre 2 milioni di voti nel 92-93). Un successo che ha portato il PRC a darsi un profilo di resistenza, classista e comunista, che ha dovuto ricomprendere matrici molteplici, molto più ampie di quelle originarie.
Questa dinamica ha determinato la trasformazione dei settori dell’estrema sinistra sopravvissuti al riflusso ed alla repressione degli anni ottanta. DP (divisa tra componenti neocomuniste e settori movimentisti), come altri gruppi (dai CUC ad LCperilcomunismo), sono sostanzialmente confluiti nel nascente PRC, contribuendo a moltiplicare sia la sua presenza nella classe e nei movimenti, sia le sue componenti e matrici teoriche (esemplari le mobilitazioni operaie del 92-93, che videro nel PRC uno dei suoi anticipatori e che videro i suoi diversi settori protagonisti sia della contestazione dei palchi sindacali, sia della loro difesa da parte dei servizi d’ordine sindacali, sia del tentativo di interposizione per evitare la degenerazione degli scontri). Quel che rimaneva dell’Autonomia (allora fondamentalmente nelle vesti del Coordinamento antinucleare ed antimperialista) si è scomposta, per svilupparsi nel variegato movimento dei centri sociali, con le sue articolazioni disobbedienti, classiste ed anarchiche ed i suoi variegati centri di coordinamento (territoriali e nazionali): una realtà composita, che più volte nel corso degli anni successivi sarà capace non solo di grandi mobilitazioni (giovanili e non), ma anche di un’incipiente influenza di massa (spesso intirizzita prima ancora di esprimersi dalla contrapposizioni interne, anche nelle dinamiche di piazza).
Nel contempo, nel mondo sindacale, lo sganciamento della CGIL dai partiti di riferimento (per la loro fuoriuscita dal solco del movimento operaio o la loro sostanziale sparizione), ha permesso l’apertura di un’esplicita dialettica tra categorie e componenti programmatiche, con la definizione di diverse sinistre interne: dopo la prima amalgama di Essere sindacato tra terza componente e sinistra PCI, possiamo infatti ricordare Alternativa sindacale (intorno al nucleo demoproletario di Democrazia consiliare), il gruppo dirigente FIOM intorno a Sabattini e i fratelli Rinaldini, il circuito Cremaschi-Zipponi-Botti, CaraCgil e l’Areadeicomunisti; negli anni successivi LavoroSocietà e la Rete28aprile (intorno a Cremaschi e l’estrema sinistra), Democrazialavoro e negli ultimi congressi la piccola area classista de Ilsindacatoaltracosa Opposizionecgil (con un proprio documento alternativo). Nel contempo, dalla fine degli anni ottanta, si è sviluppato e consolidato un sindacalismo di avanguardia (in particolare nel pubblico impiego, nei trasporti e nella logistica, ma non solo), politicizzato e variamente dislocato intorno a tre poli: il mondo Cobas (egemonizzato da diverse avanguardie politiche: dal circuito dell’Alfa di Arese a Miliucci, da Bernocchi a Milani); il nucleo intorno a Tiboni, espulso dalla CISL milanese (che darà vita alla FLMU e poi la CUB); RDB e poi l’USB (costruitasi intorno al nucleo politico della OPR, poi Rete dei comunisti).
La rottura dei solchi politici, teorici e simbolici scavati negli anni settanta tra questi diversi mondi ha in ogni caso permesso lo sviluppo di grandi fronti unitari di lotta, determinando cioè movimenti che saranno in grado di comprendere sostanzialmente tutte le diverse organizzazioni, facendo vivere quindi al proprio interno il confronto tra molteplici matrici teoriche e posizioni politiche (dalla Pantera ai social forum). Questa lunga stagione ha infatti conosciuto diversi cicli di lotta e resistenza, non solo centrati sul lavoro: dal movimento della scuola 87-88 (lo sciopero degli scrutini) alla Pantera del 90-91, dal risveglio operaio del 92-94 ai tanti conflitti sulle chiusure industriali negli anni novanta, dai movimenti per i diritti dei migranti (dalla prima manifestazione per la morte di Jerry Masslo nel 1989 al corteo antirazzista del 3 febbraio 1996) a quelli contro la globalizzazione (di cui gli appuntamenti di Genova e Firenze nei primi anni duemila sono solo i più partecipati), sino ad alcuni movimenti territoriali diventati punto di riferimento nazionale (dalla TAV alla base USA di Vicenza).
In questa lunga transizione, cioè, è vissuta un’ampia avanguardia, di molte decine se non centinaia di migliaia di compagni/e, capace di dar vita a più cicli di lotta e grandi movimenti politici di massa. Movimenti unitari, con un confronto plurale (talvolta uno scontro) tra diversi settori, progetti e matrici teoriche, senza che nessuno di questi avesse in sé elementi tali da garantire un’indiscussa egemonia o un controllo determinante delle loro direzioni politiche.
- In questa lunga transizione, in questa complessa scomposizione e ricomposizione, si è costruito un progetto comunista e rivoluzionario, classista e internazionalista. In questa fase, cioè, si è riusciti a comporre un soggetto politico con un programma e un metodo transitorio, indipendente e potenzialmente in grado di sviluppare un’influenza di massa (non solo sul terreno elettorale). Lo sviluppo di questo soggetto attraversa tre diverse stagioni.
La prima, nel PRC, è stata quella di definizione programmatica nell’avanguardia larga e di capitalizzazione delle forze (1991-2006). È la stagione in cui si costruisce, nel quadro del composito mondo politico e teorico di Rifondazione, un raggruppamento su posizioni politiche (fronte unico di lotta; opposizione ai governi di unità popolare e necessità di un polo di classe; centralità del lavoro e della sua organizzazione) e sulle matrici teoriche che permettono di sviluppare quelle posizioni (il progetto rivoluzionario e comunista, quindi l’obbiettivo di cambiare il modo di produzione in senso socialista attraverso la conquista del potere politico; il programma transitorio, per collegare lotte e resistenze sociali con questo obbiettivo di trasformazione strutturale della società; la democrazia consiliare, perché al centro del processo rivoluzionario c’è sempre l’organizzazione democratica della classe lavoratrice ed il partito; l’internazionale, perché nel quadro di un modo di produzione mondiale organizzato in formazioni sociali diverse, solo un organizzazione internazionale può raggiungere l’obbiettivo e contenere le possibili degenerazioni nazionalistiche). Questo raggruppamento viene costruito con diversi percorsi. Uno, nel PRC, con la partecipazione al documento alternativo contro le alleanze di centrosinistra (2° congresso, 1994), poi la direzione di un’alternativa composita (3° congresso, 1996) e infine la promozione diretta di un’opposizione alla lunga gestione Bertinotti sui propri punti qualificanti politici e teorici (congressi successivi). Due, nelle lotte e nei movimenti di massa (dall’autunno dei bulloni a Genova2001), con l’esplicitazione delle proprie analisi e posizioni, con il sostegno attivo ad ogni tendenza o polarizzazione in senso classista o rivoluzionario. Tre, sul piano internazionale, con la promozione di un raggruppamento programmatico che porterà nel 1997 al documento di Genova, poi allo sviluppo del Mrqi e quindi alla fondazione del CRQI.
La seconda stagione, più breve e a cavallo della crisi (2006/2010), è stata quella della costruzione indipendente del PCL. Come ricordato nel secondo congresso, è stato il tentativo di “costruire, intorno ad un nucleo marxista rivoluzionario, un centro di attrazione per quei compagni e quelle compagne che, formatisi all’interno di diversi percorsi storici e teorici… potevano coagularsi..in una prospettiva comunista, rivoluzionaria, antistalinista e internazionalista. Nel momento in cui si esplicitava la parabola riformista del PRC (governo Prodi e Arcobaleno), nel momento in cui aree significative dei centri sociali si inserivano stabilmente in un quadro istituzionale moderato (vedi l’esperienza del Leoncavallo), nel momento in cui risaltava la necessità di un partito che mantenesse chiara un’identità ed un programma rivoluzionario, si riteneva possibile stabilizzare forze significative, se pur quantitativamente limitate, nella nascita del Partito Comunista dei Lavoratori. Il passaggio cruciale di questo processo si concretizzava nella capacità del Movimento Costitutivo del PCL, e del PCL stesso, di costituirsi come organizzazione nazionale, con un proprio programma, una propria struttura ed una propria autonoma capacità di proiezione politica”. Questa stagione si è quindi concretizzata, in primo luogo, nell’impegno per lo sviluppo di un’opposizione di sinistra, internazionalista e classista al governo Prodi, partecipando e promuovendo fronti di lotta contro le politiche di austerità e gli interventi militari (dai cortei del 2006 e 2007 contro la precarietà alle mobilitazioni contro l’intervento in Libano, in Afghanistan e contro la visita di Bush il 9 giugno 2007). In questo quadro, il terreno elettorale è stato uno dei principali canali di costruzione di una propaganda ed un’influenza di massa del nuovo partito, cercando di affermarsi come principale punto di riferimento a sinistra del governo. Alle politiche del 2008 il PCL ha quindi raccolto oltre 200mila voti (0,6%), alle Europee del 2009 circa 170mila voti (0,54%) solo nelle tre circoscrizioni centrosettentrionali (0,9% in quella centro e 0,7% in quelle del nord).
La terza stagione, successiva al 2010, è stata quella in cui il partito si è stabilizzato politicamente ed organizzativamente, rimanendo per un lunga periodo la principale forza politica a rivendicare un identità ed un progetto comunista (PRC e PdCI infatti si imbarcavano in coalizioni alternative, civiche e benicomuniste, da Rivoluzione Civile alla Lista Tsipras; Sinistra critica si qualificava per il suo impianto movimentista; il PC di Rizzo rimaneva marginale e la RetedeiComunisti in una dimensione di stretta avanguardia). In un ciclo dominato da una lunga depressione, dalla resistenza a Marchionne e dalla capitolazione della FIOM nelle fabbriche (Grugliasco e successivi eventi a Pomigliano, Termoli e Melfi), dalla dispersione e l’arretramento delle lotte, il PCL ha stabilizzato una presenza in quasi tutte le regioni (seppur debole nelle aree metropolitane), in una cinquantina di sezioni, come ricordava il documento del quarto congresso, con una “continuità instabile con segnali di logoramento”. In questo quadro, ha sviluppato anche un suo intervento continuativo e coordinato in Cgil (in particolare nella CGILchevogliamo e poi nel Sindacatoaltracosa) e nei sindacati di base (in particolare in USB e nella CUB, poi anche nel SGB), una delle poche forze politiche a mantenere una presenza in tutti questi settori di avanguardia. Il principale campo propagandistico di costruzione del partito è comunque rimasto quello della presentazione elettorale, anche se con evidenti difficoltà: le politiche del 2013 hanno visto una presentazione in un numero molto più ridotto di collegi (115mila voti, 0,4%) e i due successivi appuntamenti sono sostanzialmente mancati (Europee 2014 e Regionali 2015). Inoltre, alle amministrative si sono registrati alcuni risultati negativi (ad esempio Napoli e Torino, 0,1%), anche se in altre occasioni sono stati positivi (in Liguria, 0,8% del candidato presidente a fronte dello 0,7% di Altraliguria; a Bologna e Savona intorno 1,2%).
- Tutte queste stagioni si sono rette, sostanzialmente, su una comune prospettiva di fase. Come abbiamo visto, si valutava l’Italia un paese a capitalismo avanzato segnato da una permanente instabilità sociale, politica ed istituzionale (per le sue contraddizioni e le incompiutezze dei processi di unificazione continentale). Un’instabilità resa evidente dalla crisi del 1992-94 e dalla successiva precarietà dei governi di centrodestra e centrosinistra. Nel contempo, permaneva nel paese una radicata tradizione classista ed una diffusa coscienza politica (costruita nei decenni dal PCI e da un’articolata estrema sinistra), rilanciata da resistenze e movimenti di massa: come abbiamo visto, cioè, rimaneva un ampio tessuto di avanguardie sociali e politiche, radicato in aziende e territori (quartieri operai e zone rosse). Il combinato disposto di questi due elementi (una prolungata instabilità, con scarsa legittimità delle strutture politico-sociali di gestione del paese; un’ampia avanguardia senza una direzione consolidata) rendeva possibile l’apertura di crisi generali dagli effetti potenzialmente dirompenti. Si valutavano cioè diffuse sia le fascine (contraddizioni e conflitti potenziali), sia il carburante (avanguardie politiche e sociali) per innescare i fuochi dello scontro di classe, con esiti potenzialmente rivoluzionari. In questo contesto, si poneva quindi soprattutto l’urgenza di costruire una direzione sufficientemente credibile e radicata, in grado di cogliere, sostenere e proteggere le prime fiamme del conflitto di classe, capace quindi di soffiare sul fuoco e diffonderlo nella prateria. Cioè, fuor di metafora, di estendere e generalizzare il conflitto, ma anche di radicalizzarlo ponendo in maniera esplicita il problema dello scontro con il potere politico (che non è neutro ma sostiene e difende il capitale), l’obbiettivo di una transizione ad un diverso modo di produzione (in cui socializzare i mezzi di produzione) e quindi la necessità della costruzione di un’alternativa di classe (polo di classe e soprattutto governo dei lavoratori e delle lavoratrici).
Il problema strategico principale era cioè quello della costruzione stessa del partito, di una sua presenza nei territori e nei conflitti. La capacità di diventare punto di riferimento per la generalizzazione e la radicalizzazione del conflitto in senso rivoluzionario sarebbe poi stata funzione soprattutto della capacità di indicare una direzione alternativa alle lotte, demarcandosi dalle altre possibili direzioni nel movimento. Direzioni riformiste, centriste o antagoniste che avrebbero potuto interpretare il conflitto in una semplice ottica di contenimento (settoriale o rivendicativo, al semplice fine “contrattuale” di migliorare le condizioni delle classi subalterne nel quadro degli attuali assetti sociali) o di contestazione (limitandone la portata rivoluzionaria, sottovalutando o non ponendosi il problema della sua radicalizzazione e generalizzazione, a partire dalla questione del potere, in un’ottica di auto-valorizzazione o diffusione di “zone autonome liberate”). L’azione, prima nel PRC e poi come organizzazione indipendente, era quindi duplice.
Da una parte, sostenere ogni lotta, ogni fiammella che avrebbe potenzialmente potuto incendiare la prateria (ricca di fascine secche e di carburante sparso), partecipando e supportando lo sviluppo di ogni fronte unico (cioè favorendo, nei limiti delle nostre forze, l’unificazione nel conflitto di tutte le tendenze con un richiamo di classe, al fine di favorirne la generalizzazione e di facilitarne la radicalizzazione politica). Potendo cioè contare su una coscienza diffusa per quanto confusa (il cosiddetto “popolo di sinistra”) e su un antagonismo generale della classe, lo sviluppo di dinamiche di lotta generali rappresentavano il terreno più favorevole su cui innescare processi di radicalizzazione e politicizzazione del conflitto.
Dall’altra parte, sviluppare una propaganda politica e teorica (intorno ai nodi prima richiamati), in particolare nei confronti dell’avanguardia larga di delegati/e, attivisti e organizzatori nei movimenti. Portare cioè avanti una critica serrata alle altre direzioni, un’azione costante di demarcazione sul terreno politico e nei movimenti di massa, rimarcando la necessità di coerenza e consequenzialità nelle rivendicazioni di lotta e nella progettualità anticapitalista. In questa azione, volgeva un ruolo fondamentale il programma ed il metodo transitorio, le parole d’ordine sulle lotte (scioperi prolungati, comitati di lotta, assemblee delegati/e) e sul terreno politico generale (la “sinistra che non tradisce”).
- Per diventare punto di riferimento nelle lotte e sostenere la diffusione dei fuochi, l’azione del partito si è quindi focalizzata in particolare sulla propaganda. Quella rivolta all’avanguardia larga, politica e sociale, diffusa nei territori: cercando quindi di costruire una presenza in tutte le mobilitazioni, i cortei, le assemblee e le iniziative (con volantini, prese di posizione, giornali; ed anche solo con una presenza visibile, bandiere e striscioni, per comunicare intervento e sostegno del partito alle iniziative in corso); volantinando periodicamente davanti le principali fabbriche e luoghi di lavoro, per raggiungere con continuità e costanza i settori di classe più attivi e organizzati.
Quella di massa, in particolare in occasione delle elezioni: il terreno elettorale è cioè stato interpretato come il principale strumento per far emergere il PCL, nella percezione diffusa, come uno dei soggetti del panorama politico nazionale. Far conoscere quindi il profilo, le posizioni ed il progetto del partito a larghe masse. Permettere cioè da una parte di diventare uno dei punti di riferimento politici dell’immaginario collettivo, in particolare nei settori di classe (seppur un punto di riferimento marginale, nel senso di estremo e radicale); dall’altra di raggruppare intorno a sé, anche grazie a questo ruolo, le avanguardie sociali e politiche attive nelle lotte e nei movimenti. Un punto di riferimento che poteva quindi poi esser utilizzato nei conflitti sociali, per sostenere la loro generalizzazione e radicalizzazione. E, appunto, incendiare le fascine diffuse.
In questa azione sul terreno elettorale, ma anche nei territori e nelle lotte, ha assunto un ruolo particolare il portavoce del partito. Si è cercato cioè di promuovere e rilanciare in tutte le occasioni una faccia ed un discorso riconoscibile, in grado di facilitare un’identificazione diffusa. Un portavoce, appunto, sul piano formale e di fatto. Nel PCL, infatti, non c’è un leader, un segretario, un presidente o comunque un soggetto che ha una gestione verticale della linea politica o dell’organizzazione. Come non c’è, per il portavoce un ruolo o uno spazio, formale e sostanziale, maggiore che per altri. Per un piccolo partito, si è però cercato di concentrare su questa figura la comunicazione, per facilitare il processo di riconoscimento e identificazione, e quindi diventare più facilmente un punto di riferimento.
- Questa strategia ha ottenuto diversi risultati. Il cambio di fase del 4 marzo ne ha portato in superficie limiti e contraddizioni, che pure esistevano da tempo. Partendo da un piccolo nucleo di qualche decina di militanti, questa strategia ha permesso di costruire prima un’ampia tendenza dentro Rifondazione e poi un’organizzazione indipendente. Si è riusciti cioè ad attraversare una fase di scomposizione della sinistra storica e del movimento operaio, ricomponendo un progetto comunista e rivoluzionario in questo paese. Il PCL infatti è riuscito non solo a darsi una struttura ed una presenza diffusa in tutto il territorio nazionale (sebbene a macchia di leopardo e con una certa debolezza nei contesti metropolitani), ma anche a costruire sulla base di questa strategia una minima presenza politica e anche elettorale, riconosciuta e riconoscibile (in particolare tra il 2006 ed il 2010). È riuscito cioè a coagulare una resistenza, un punto di riferimento alternativo (seppur ridotto e parziale), ai tentativi di egemonia delle nuove direzioni neo-riformiste (movimentiste e non, da Bertinotti a Vendola) e antagoniste multiduninarie (che in un’ottica di auto-valorizzazione, micropotere e biopolitica di impianto foucaltiano-negriano, hanno cancellato l’obbiettivo della conquista del potere politico come strumento di trasformazione sociale). È riuscito quindi a darsi proiezioni di intervento nella classe e nei movimenti sociali (sebbene talvolta in nuce e spesso limitate), dalle lotte studentesche al sindacalismo conflittuale (settori classisti della CGIL e nei sindacati di base). È riuscito a costruire una presenza, talvolta unica e in alcune occasioni anche capace di una sua influenza, in alcuni dei momenti di innesco di possibili esplosioni del conflitto di classe in questo paese (dai 21 giorni di Melfi agli scioperi Alitalia del 2008; dalle lotte contro Marchionne negli stabilimenti FCA allo sciopero prolungato degli autoferrotranvieri di Genova nel 2013), seppur meno presente in altre occasioni (dal ciclo di lotta della logistica a movimenti studenteschi o nonunadimeno).
Nel contempo, è necessario registrare non solo che in questa lunga transizione la prateria non si è incendiata; non solo che dopo il 2010-12, nella lunga depressione italiana, si è sviluppato un evidente ripiegamento del conflitto, dell’organizzazione e della coscienza di classe (il carburante è progressivamente evaporato e le fascine si sono sempre più inumidite, sino a infradiciarsi); ma anche che il perseverare in questa strategia ha logorato le energie accumulate. Il cambio di fase che è emerso con evidenza nelle elezioni del 4 marzo 2018, aprendo una nuova fase nella dinamica dello scontro di classe di questo paese, come una nottola di Minerva ha rivelato cioè limiti e contraddizioni della strategia attraverso cui si era costruito il PCL. Debolezze e problemi non solo soggettivi (che pure ci sono stati), ma anche di analisi e strategia, che devono quindi esser affrontati e risolti, per rilanciare l’iniziativa ed il progetto in questo nuovo contesto storico e sociale. Cinque, in particolare, i limiti e le contraddizioni che sono emersi con sempre maggior evidenza negli ultimi anni.
- Primo: ci si è focalizzati sui mille fuochi e l’incendio della prateria, senza curarsi della direzione del vento e dell’organizzazione dell’innesco. Fuor di metafora, contando sulla diffusione delle contraddizioni e su un’avanguardia diffusa in grado di innescare esplosioni, ci si è concentrati nel porsi come punto di riferimento politico, per generalizzare e radicalizzare il conflitto. Così si è sottovalutato l’effetto inerziale delle direzioni egemoni e l’importanza di strutturare un proprio radicamento, con la definizione di relative tattiche e metodologie di intervento. In questi anni, cioè, si è pensato che la polemica politica, a partire da una coerenza di posizionamento e di metodo, fosse decisiva nei momenti decisivi per permettere un cambio di orientamento nell’avanguardia. In particolare, di fronte a direzioni che si sarebbero squalificate nelle loro pratiche opportuniste o di semplice contestazione dell’esistente. In realtà, se a livello di massa i soggetti neoriformisti e antagonisti hanno subito nell’ultimo decennio una sostanziale perdita di influenza (a partire dalla collaborazione di governo e dalle loro pratiche ambigue), proprio nelle avanguardie le impostazioni confuse ed eterogenee di questi ultimi decenni hanno rivelato una certa persistenza. In questi anni, inoltre, non si è posta sufficiente attenzione al consolidamento nei territori e nelle lotte: si è cioè troppo poco investito (politicamente e finanziariamente) nelle sedi, nei quadri (formazione), nell’implementazione di un metodo di costruzione (pur teoricamente affermato come “progetto e bilancio di sezione”). Si è cioè tralasciato uno sviluppo organizzativo sistematico, su obbiettivi e verifiche, puntando sulla propaganda e sulla dinamica inerziale dei conflitti. Così, come in Alitalia nel 2008 o tra gli autoferro di Genova nel 2013, anche quando si è incrociato l’innesco di esplosioni sociali (in cui le altre direzioni si erano squalificate ed avevano perso ogni influenza), anche quando le posizioni del PCL hanno trovato consenso (riuscendo in entrambi i casi ad esser gli unici esterni ammessi alle assemblee, con interventi che raccoglievano il sostegno di una larga maggioranza), non si è riusciti a organizzare e condurre il conflitto, che rapidamente è collassato.
- Secondo: la crisi ha accelerato l’accumulazione delle fascine, ma il vuoto di direzione e l’involuzione della classe le ha prima inumidite e poi bagnate. Con la crisi nel 2007-08, non ci si attendeva certo un’automatica esplosione delle lotte (come invece altri ritenevano inevitabile di fronte al crollo capitalista). Infatti, si registrava un sostanziale cambio di stagione politica, con la caduta del secondo governo Prodi: la nascita del PD, la vittoria del centrodestra, il tracollo dell’Arcobaleno, la formazione di Sinistra critica (presente alle elezioni, con un risultato poco inferiore a quello del PCL), la sopravvivenza del PRC come forza extraparlamentare. Era evidente la debolezza dei nuovi cicli di lotta e l’assenza di settori di classe in grado di trainare una ripresa generalizzata delle lotte: i conflitti conseguenti alla crisi e alle chiusure erano dispersi (Fiat, Alitalia, Ilva, Piombino, le tante fabbriche e aziende nei territori), le lotte della logistica isolate (per caratteristiche contrattuali e composizione di classe). Tutto questo chiudeva quindi la stagione del raggruppamento, senza aprire nessun percorso né sul terreno politico, né su quello dei conflitti sociali. Però l’esplosione della crisi mondiale sembrava dischiudere tempi nuovi, con la caduta verticale dell’egemonia delle classi dominanti e grandi movimenti di massa, sia in paesi a capitalismo avanzato che in semiperiferie (da Occupy Wall Street agli Indignados, da Piazza Taksim alle primavere arabe). Ci si aspettava allora che la crisi, senza implicare meccanicamente l’esplosione del conflitto, stimolasse l’accumulazione di nuove fascine, lo spargimento di ulteriore carburante e quindi la moltiplicazione delle occasioni di innesco. Ci si aspettava allora la conferma, anzi l’approfondimento, delle dinamiche che si stava perseguendo. Anche senza ulteriori scomposizioni nella sinistra, anche senza il traino di particolari settori di classe, si riteneva cioè possibile che singole lotte potessero innescare un incendio diffuso. E quindi uno sviluppo, anche per salti, del percorso rivoluzionario intrapreso.
Gli anni successivi hanno reso sempre più evidente una dinamica diversa. Da una parte la grave e storica sconfitta del movimento operaio in FIAT: la lotta più significativa di tutta questa stagione è segnata non solo dalla progressiva implementazione tra il 2010 ed il 2012 del modello Marchionne (prima a Pomigliano, poi a Mirafiori, quindi a Grugliasco ed infine a tutto il gruppo), ma soprattutto dalla rinuncia della FIOM al contrasto in fabbrica (limitandosi prima alla via giudiziaria, poi cercando di spostare il conflitto sul terreno politico con la “coalizione sociale” e infine, visto il suo fallimento, capitolando col CCNL del 2016). Dall’altra la sostanziale estemporaneità dei movimenti (dal jobsact a nonunadimeno), eccetto quello contro la Buonascuola nella tarda primavera del 2015, che ha cambiato il clima sociale e politico nei confronti di Renzi (sebbene schiacciato sull’estate, disperso e poi sconfitto l’anno successivo anche per responsabilità delle direzioni sindacali). Come abbiamo visto, la scomposizione del lavoro e queste sconfitte, insieme al vuoto di direzione della CGIL, hanno determinato un’involuzione sostanziale della coscienza e dell’identità di classe. Hanno permesso la penetrazione delle rappresentazioni reazionarie e comunitariste di Lega e 5stelle, la loro egemonia politico-culturale sulle classi subalterne e quindi la loro progressiva saldatura in un nuovo blocco. La crisi, invece di favorire generalizzazione e radicalizzazione delle lotte, ha impregnato le fascine delle contraddizioni sociali dell’acqua dell’identità etnica e nazionale, invece che del carburante dell’antagonismo tra capitale e lavoro. E così, ha cambiato le condizioni e la dinamica dello scontro di classe.
- Terzo: il PCL ha colto questa involuzione, ma non ne ha tratto tutte le conseguenze. Diversamente da altri, nei suoi documenti e nelle sue analisi il partito ha visto non solo le sconfitte di questa stagione, ma anche i processi di sfaldamento dell’organizzazione e dell’identità di classe. Ha riconosciuto, fenomenicamente, l’involuzione in corso. Non ne ha però colto pienamente dimensione e profondità. Non ha quindi colto la necessità, e l’urgenza, di darsi nuovi strumenti e nuovi metodi di intervento. Non ha colto, in sostanza, la messa in discussione della sua strategia di sviluppo sottesa a questi arretramenti.
Non ha colto, in particolare, la velocità e la forza del ripiegamento del popolo della sinistra. Non tanto la sua riduzione numerica, lo svuotamento delle piazze e la desertificazione dei consensi, quanto la rapida trasformazione del senso comune nelle fabbriche e nei quartieri popolari. Quel processo di trasformazione sociale che ha attraversato periferie e “zone rosse”, deflagrato su percezione dei migranti e domanda di sicurezza nelle elezioni 2018 (non solo le politiche, ma anche le successive amministrative). Il popolo di sinistra si è cioè progressivamente scomposto. Il suo nucleo identitario, infatti, per quanto confusamente e contraddittoriamente, era saldamente impiantato sui due elementi che hanno caratterizzato il movimento operaio novecentesco (in tutte le sue articolazioni: anarchiche, consiliariste, comuniste rivoluzionarie, staliniste, socialdemocratiche, socialiste e riformiste): da una parte il riconoscimento di un antagonismo di interessi tra capitale e lavoro; dall’altra la propensione ad una trasformazione dello stato di cose esistenti. Nelle sconfitte e nella crisi, nell’involuzione della coscienza di classe, a svanire sono state queste convinzioni diffuse.
Così, in mancanza della percezione di un interesse comune e di un avversario comune, ad emergere sono le differenze (di categoria, professionalità, territorio, stabilimento, genere, etnia, età, condizione, ecc). Così, ad emergere è una certa estemporaneità dei movimenti di massa: “i movimenti si definiscono…in una fluidità e molteplicità di soggetti, convocazioni, identificazioni e rivendicazioni. Si sono costituiti a partire da singoli personaggi o strutture con un forte ruolo simbolico (FIOM, attori e intellettuali, comunità locali), che hanno potuto catalizzare l’attenzione e hanno amplificato la loro influenza attraverso molteplici mass media (social network, rete internet, televisione, radio, ecc), rappresentandosi attraverso identificativi il più possibile comprensivi e raffigurativi (Onda, Occupy Wall street, Indignados, Senonoraquando, Notav, ecc). Nel contempo, nella loro moltitudinarietà fluida, questi movimenti si sono rivelati spesso estemporanei, senza una loro definizione territoriale, di interessi, di piattaforme, di obbiettivi, di linee politiche…Movimenti che in questa fluidità e molteplicità, nel concentrarsi su pochi simboli ed eventi, facilmente si disperdono e si isolano tra loro”. Il PCL legge queste dinamiche (quello sopra è un passaggio del documento organizzativo del terzo congresso, 2014), ma appunto solo da un punto di vista fenomenico. Non arriva a cogliere che il popolo di sinistra (che per quanto confusamente e contraddittoriamente si costituiva su due elementi prima richiamati, basilari per lo sviluppo di una coscienza politica di massa di carattere rivoluzionario) si è gradualmente trasformato in popolo dei diritti: una moltitudine composita che rivendica diritti inalienabili di singoli o comunità (dalla libertà di orientamento sessuale alla dignità umana), fuori dai rapporti di lavoro e dai suoi conflitti, senza propensione a cambiare questo modo di produzione. Non arriva a cogliere che proprio le classi subalterne (spesso anche le sue avanguardie più attive, i suoi settori più organizzati), si stanno estraniando sempre più da questo popolo, estraneo a sua volta dalla concretezza delle loro vite e delle loro miserie. E non ha colto quindi la necessità, e l’urgenza, di cambiare le proprie tattiche, le proprie parole d’ordine e le proprie modalità di intervento nei contesti di massa, che sono altri e diversi da quelli che ha praticato nelle stagioni precedenti. Come, non casualmente, proprio in questi ultimi anni si sono aperte differenziazioni, polemiche e persino fratture sui metodi di intervento in questi movimenti e nelle strutture di massa (dagli studenti all’OpposizioneCGIL, da nonunadimeno ai sindacati di base). Confronti talvolta acuti, che spesso si sono ripiegati su sé stessi, senza cogliere il quadro complessivo, politico ed analitico. Non ci si è reso conto, cioè, che queste trasformazioni nella classe e nei movimenti si pongono in contraddizione con una strategia focalizzata sull’accumulazione di fascine e le esplosioni sociali, chiedendo un cambiamento di fase nella costruzione del partito e del suo percorso rivoluzionario.
- Quarto: il terreno elettorale si è posto sempre più come il principale intervento di massa, ma si è rivelato sempre più impervio. In questi anni le elezioni (sia quelle politiche, sia quelle amministrative) hanno assunto un ruolo sempre più determinante, sia nello sviluppo di un intervento di massa, sia negli stessi processi sociali di questo paese. Da una parte, il ripiegamento delle lotte, la dispersione del conflitto, l’estemporaneità dei movimenti di massa hanno determinato che per il PCL (come per le altre organizzazioni della sinistra) il terreno elettorale ha sempre più rappresentato l’occasione principale, se non l’unica, per raggiungere e interloquire con larghe masse (i milioni di persone e non le decine di migliaia). Dall’altra parte, i processi di scomposizione delle identità hanno comportato che le campagne elettorali sono diventati uno dei principali luoghi di formazione della coscienza politica, di propagazione e cristallizzazione delle rappresentazioni collettive. Anche gli stessi risultati elettorali hanno assunto questo ruolo, diventando sia un effetto sia un motore dei cambiamenti delle percezioni e degli immaginari collettivi. In questo quadro, la presenza di liste e candidati non è semplicemente un’occasione di propaganda (la classica tribuna del programma) o di costruzione di una rappresentanza di classe (in grado di dar voce e corpo, anche nelle istituzioni, a resistenze ed antagonismi), ma sempre più anche il luogo in cui si combatte una battaglia ideologica. Un momento importante, cioè, per poter tornare a dare una rappresentazione (non solo una rappresentanza) al conflitto di classe e alla propensione alla trasformazione sociale (i due cardini in discussione nella decomposizione in corso del popolo di sinistra). Per questo in questi anni è stato particolarmente negativo (una componente non irrilevante dell’involuzione in corso) che tutte le altre sinistre abbiano calcato lo spazio elettorale rimuovendo ogni riferimento alla classe o alla trasformazione sociale (o ad entrambi: da Rivoluzione Civile alla lista Tsipras, da Liberi e uguali e Potere al popolo). Per questo, in questi anni, le elezioni sono diventate un terreno sempre più rilevante per un partito comunista e rivoluzionario.
Allo stesso tempo, però, il campo elettorale è diventato sempre più difficile da calcare. Per l’irrigidimento delle procedure e la complicazione delle leggi (moltiplicazione di collegi e firme, una delle normative più restrittive del continente). Per la frammentazione della comunicazione, la moltiplicazione delle liste (in particolare nelle amministrative) e quindi la difficoltà ad esser riconoscibili e riconosciuti. Lo sforzo negli ultimi anni è stato logorante ed i risultati sempre più limitati (al di là del risultato particolarmente negativo di “Per una sinistra rivoluzionaria”, con meno di 30mila voti raccolti). Si pone quindi un’evidente contraddizione, sempre più acuta, tra l’importanza del terreno e la crescente difficoltà a reggerne l’impegno. In questo quadro, oltre che in relazione alle precedenti considerazioni sui movimenti, si è posta la necessità di sviluppare una propaganda ed un intervento di massa in grado di prescindere dal terreno elettorale. Uno sviluppo che è stato spesso sacrificato, proprio per la focalizzazione delle energie e delle risorse quel terreno. Da una parte si è iniziato a discutere e sperimentare nuove modalità di comunicazione (materiali per social, meme, volantini con immagini, ecc), anche se ancora troppo timidamente e con una certa improvvisazione. Dall’altra, alcune campagne, che pure sono state impostate sul piano politico e organizzativo, sono state fermate, o condotte in tono minore, anche con la dispersione dell’impegno e dei materiali realizzati (pensiamo a quella sui 5 stelle come movimento reazionario di massa o a quella sulla centralità del lavoro nei conflitti sociali). Altre ancora, che pure erano e sono necessarie, sono state proposte e invocate, ma non si sono mai neanche seriamente elaborate: da quella contro lo sviluppo di un neocampismo di ritorno (a partire dal conflitto siriano e dal Rojava), a quelle contro la nuova destra sociale, fascista e militante (da Casapound a Lealtàeazione).
- Quinto: proprio quando esplode la crisi, proprio quando precipitano le contraddizioni (competizioni interimperialistiche, spinte centrifughe nella UE, primavere arabe), prima si blocca e poi si rompe il raggruppamento internazionale nel CRQI. Come ricordano i testi congressuali del 2017, “il PCL si è impegnato, sin dalla sua fondazione, nel tentativo di [proseguire]..il processo di raggruppamento intrapreso nel 1997, in controtendenza con la dissoluzione programmatica e la scomposizione in Internazionali-frazione che caratterizzano il movimento trotzkista. Un processo costruito su due assi: il bilancio critico dell’esperienza della Quarta Internazionale (dalla deriva pablista a quelle settarie o opportuniste); la definizione di punti programmatici discriminanti, che segnano lo spartiacque del comunismo rivoluzionario..Il PCL ha quindi contribuito a questo primo di raggruppamento, sostenendo il radicamento delle sue sezioni, cercando di estendere la sua azione internazionale, impegnandosi nella progressiva costruzione di un centralismo democratico del CRQI..A partire dalla stabilizzazione nel corso degli anni di un fronte elettorale in Argentina tra PO e PTS (il FIT, che ha sviluppato una dimensione di massa eleggendo anche propri deputati), ha avviato normali contatti con la FT in Europa, invitandola a proprie iniziative pubbliche o partecipando alle loro”. Il CRQI è però entrato, proprio con l’esplosione della crisi, in un’impasse politica e organizzativa. Nonostante la nostra insistenza per riattivare una prospettiva, rilanciando il confronto con altri soggetti del comunismo rivoluzionario (a partire da quelli che hanno mantenuto un’indipendenza e una linea di classe), a questa impasse è seguita una rottura verticistica e amministrativa. Proprio quando il partito si è costruito come forza indipendente, proprio quando il PO (nell’ambito del FIT) ha conquistato un ruolo di massa in Argentina, ci si è ritrovati di fatto privi di un sostengo ed un quadro organizzativo internazionale. Un elemento che ha indebolito non solo l’azione, ma anche la capacità di lettura e di tenuta in una stagione così complessa, ricca di grandi trasformazioni, di prospettive ma anche di involuzioni.
In questi mesi, a partire dai rapporti con altre organizzazioni comuniste e rivoluzionarie, a partire dall’approfondimento del confronto nel PCL in una prossima Conferenza congressuale, ricostruiremo un nostro percorso e quadro organizzativo internazionale. La protratta scarsezza di rapporti internazionali ha però pesato, e pesa, nel percorso di costruzione del partito e del suo percorso rivoluzionario.
SCORCI
Le dinamiche ineguali e combinate della crisi
- I conti ci dicono che non solo si è chiusa una fase della storia politica italiana, ma si è chiusa anche una fase di costruzione di un percorso comunista e rivoluzionario. A questo punto, per provare a indicare una nuova strategia e aprire una nuova fase, diventa utile capire non solo le dinamiche in corso, ma anche le prospettive. Al centro, inevitabilmente, la crisi scoppiata nel 2007-08, con lo stravolgimento della precedente stagione neoliberista e il protrarsi di una instabilità mondiale.
- Diversi punti di vista sulla crisi. Sulla crisi del 2007-08 si sono prodotte molte letture, tra gli economisti e nella sinistra (in particolare, quella con una matrice marxista).
Molti l’hanno vista come una crisi determinata dall’espansione esuberante ed incontrollata dei mercati finanziari, con le sue relative bolle. Per alcuni è stato un effetto collaterale delle politiche neoliberiste che hanno globalizzato i mercati, smantellato i sistemi di regolazione e ridotto il governo dei processi economici, in particolare su moneta e finanza. Per altri è stato un Minsky moment, un effetto ciclico della fragilità finanziaria endogena: cioè la tendenza strutturale, nei mercati capitalistici, allo sviluppo di politiche di investimento basate sull’esperienza percepita e quindi, nella fase espansive, a moltiplicare le posizioni speculative e quelle iperspeculative (alla “Ponzi”), fino al crollo rovinoso del castello di carte.
Molti l’hanno vista come una crisi da realizzazione, ovvero da insufficienza della domanda: cioè le politiche neoliberiste degli ultimi decenni, con la riduzione dei salari (in particolare nei paesi a capitalismo avanzato), hanno determinato nel tempo una crescente incapacità di realizzare il plusvalore potenziale. Il capitale, gonfiato dagli alti tassi di profitto, nonostante la valvola di sfogo dell’espansione finanziaria a un certo punto non ha più trovato sbocchi (a secondo da come la si vede, cioè, una crisi da sottoconsumo o sovrapproduzione di capitale). Per una stagione la domanda aggregata è stata rilanciata con i debiti, in particolare privati: alla fine però, non avendo basi materiali, questo sostegno artificiale del consumo è crollato, aprendo la crisi dal lato finanziario (subprime). Nel mondo marxista, in particolare, due sono le articolazioni di queste letture. Alcuni (a partire da Hilferding) sottolineano il ruolo delle ‘sproporzioni’, cioè gli squilibri tra domanda e offerta nei diversi settori e nei diversi mercati, nel quadro della dinamica ineguale, caotica ed anarchica che caratterizza il modo di produzione capitalista. Così, viene rimarcato soprattutto il ruolo delle differenze tra le diverse sezioni dell’economia, gli sbilanci commerciali, le disuguaglianze crescenti di un mercato mondiale disordinato (se vogliamo, è anche un modo per sottolineare la contraddizione tra dimensione locale delle istituzioni politiche e estensione mondiale dei mercati). Altri (a partire dalla Luxemburg) sottolineano che la riduzione del consumo (determinata dalla riduzione dei salari) non può esser controbilanciata dagli investimenti per la crescente incertezza sulla loro realizzabilità (a causa cioè di equilibri settoriali sempre più casuali, precari e instabili). Come ricorda Bellofiore, in quest’ottica la sovrapproduzione si innesta su sproporzioni causate dallo sfruttamento: quando il mercato mondiale è interamente sussunto dal capitale (e non si può quindi contare sul consumo di realtà extra-capitaliste), nonostante la possibilità di ulteriori esportazioni ‘interne’ (alla Kalecki, con il debito, o attraverso l’espansione di rendita e lavoro improduttivo), la possibilità di una crisi generale si tramuta in sua probabilità.
- Crisi e caduta tendenziale del saggio di profitto. L’analisi marxista, però, rimarca in particolare il ruolo di questa componente, intrinseca al modo di produzione capitalista. In sostanza, vengono qui considerati i processi innescati dalla propensione delle diverse imprese a introdurre nella produzione metodi a più elevata ‘intensità di capitale’, al fine di abbassare i costi per unità di prodotto (guadagnando così un sovra-profitto o evitando di essere espulsi dal mercato). La conseguenza crescita della quota di capitale costante (il valore degli investimenti tecnologici) diminuisce quindi la quota di capitale variabile (cioè il lavoro) nella composizione complessiva del capitale. Essendo che il plusvalore (cioè il nuovo valore su cui si costruisce l’accumulazione e quindi l’espansione del sistema capitalista) è prodotto dal lavoro vivo, la riduzione del peso di quest’ultimo sul capitale complessivo determina nel tempo una pressione a ridurre la quota di plusvalore (cioè, il saggio medio di profitto). Mettendo così sempre più in tensione il circuito di riproduzione e accumulazione del capitale, che regge l’equilibrio espansivo e quindi strutturalmente instabile di questo modo di produzione, sino a quando le masse di capitale non trovano più sbocchi sufficientemente remunerativi e determinano la crisi generale del sistema.
Questa tendenza di lungo periodo presenta però delle contro-tendenze. Ad esempio, l’abbassamento dei costi conseguente agli investimenti (svalorizzazione) riguarda anche i mezzi di produzione (le stesse macchine e tecnologie): di conseguenza, si riduce anche il valore del capitale costante. Nel contempo, si determina una svalorizzazione del capitale variabile (il costo della forza lavoro si riduce, essendo in rapporto con il costo delle merci che ne consente la riproduzione sociale) e così può aumentare il saggio di sfruttamento (cioè, la quantità di plusvalore che viene trattenuto dal capitale). Questi processi possono quindi contrastare automaticamente la diminuzione del saggio di profitto.
Il capitale può anche innescare processi attivi di rilancio del saggio medio di profitto. Ad esempio, può inglobare nuovi mercati (paesi sganciati dal sistema capitalista) o costruirli ex-novo, proprio grazie allo sviluppo tecnologico, come per l’intrattenimento (cinema, radio, tv, ecc), le comunicazioni (telefoni, cellulari, internet) o più recentemente le biotecnologie. Oppure, può conquistare settori sociali extra-capitalisti, sussumendo in circuiti di produzione del valore realtà contadine o dei servizi (formalmente, con la commercializzazione, o realmente, con il controllo dei processi di lavoro). Inoltre, può migrare verso settori non produttivi (commerciali, finanziari e speculativi) dove si possono temporaneamente realizzare più alti tassi di profitto (sino all’inevitabile esplosione delle bolle che spesso innescano poi le crisi generali). Infine, può aumentare il tasso di sfruttamento (aumentando l’orario di lavoro, intensificandone il ritmo o diminuendo i salari), e quindi così contrastare la caduta del saggio di profitto attraverso un’acutizzazione dello scontro di classe.
Tutte queste controtendenze hanno però effetti limitati (nel tempo o nella forza) e possono a loro volta determinare nuovi processi che tornano ad aggravare la crisi stessa. In sostanza, la tendenza alla riduzione del saggio medio di profitto agisce sempre, essendo intrinseca alla competizione del sistema capitalista (alla ricerca da parte del singolo imprenditore di posizioni di vantaggio, in grado di permettergli l’acquisizione di un sovra-profitto). Nello sviluppo storico, però, si possono imporre diverse curvature al ciclo economico, a seconda della forza e della combinazione delle controtendenze, che dipendono anche dalla lotta di classe (saggio di sfruttamento), da dinamiche politiche anche internazionali (configurazione dei sistemi e dei mercati mondiali, a partire da quelli finanziari e commerciali), oltre che da processi sociali più complessivi (nuovi consumi e relativi prodotti).
- La crisi e la Grande Crisi. La crisi in corso è non solo mondiale, ma è una Grande Crisi. Secondo diversi punti di vista (Kondriateff, Trotsky, Kuznets, Mandel, Screpanti, Husson) nel modo di produzione capitalista si sviluppano onde lunghe di espansione e contrazione economica. Il classico ciclo economico (prosperità, recessione, depressione, ripresa) si ripete cioè a dimensioni diverse: nel breve periodo (il ciclo Kitchin, da 2 a 4 anni, sostanzialmente legato al ciclo delle scorte), nel medio periodo (il “classico” ciclo Juglar, da 4 a 10 anni, come ad esempio le ultime grandi recessioni mondiali dei primi anni ottanta, novanta e duemila) e nel lungo periodo (le onde lunghe, da 50 a 70 anni). Ogni ciclo (breve, medio e lungo) ha proprie caratteristiche particolari (giocando nella loro dinamica componenti preponderanti diverse). I cicli di durata più breve, ovviamente, si inseriscono nel quadro di quelli più ampi, intensificando e prolungando le fasi espansive o quelle recessive, a seconda del contesto. Secondo Trotsky ed i seguenti filoni comunisti rivoluzionari, nei cicli intermedi e soprattutto nelle onde lunghe l’interazione tra tendenza alla caduta del saggio di profitto e controtendenze è complessa: a giocare un ruolo non sono tanto le controtendenze intrinseche (o quelle legate a dominanti tecnologiche e sistemi di regolazione, come sostenuto da alcuni), ma soprattutto quelle legate agli antagonismi nel lavoro.
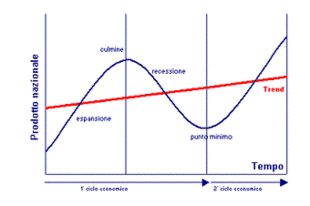
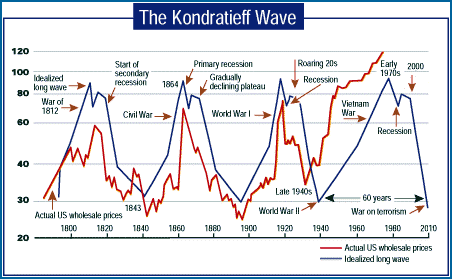
In ultima analisi, infatti, è la lotta di classe nella produzione e nella politica (da entrambi i versanti del conflitto, il capitale ed il lavoro) che imprime la sua curvatura al ciclo di lungo periodo. Inoltre, ed in particolare, il passaggio di fase dal momento espansivo a quella recessivo è sostanzialmente endogeno (influenzato in particolare dai processi economici), mentre il passaggio dalla fase recessiva a quella espansiva è, viceversa, sostanzialmente esogeno. La ripresa da una Grande Crisi, cioè, presuppone una riconfigurazione complessiva del contesto sociale e istituzionale, in genere basata su un’ampia distruzione del capitale globale. Quindi non solo di quello finanziario, non solo di quello fisso, ma anche di quello variabile (la forza lavoro). Presuppone quindi una barbarie come elemento determinante su cui è quindi possibile elevare un nuovo ordine produttivo.
La Grande Crisi del 2007-08. In questa dinamica di crisi e Grandi Crisi, allora, è importante tener presente come le diverse letture che abbiamo qui ricordato (dinamiche finanziarie, sproporzione, sottoconsumo, sovrapproduzione) colgono solo un aspetto della realtà. Sono cioè letture parziali della crisi. Le crisi, e le Grandi Crisi in particolare, sono infatti generali. Anche la caduta tendenziale del saggio di profitto può allora esser considerata nel quadro di una sua lettura teorica particolare, capace di includere le diverse componenti della crisi (vedi Bellofiore, 2010, a cui si rimanda per un’analisi delle dinamiche dell’ultimo secolo).
Come abbiamo visto, quindi, la Grande Crisi si colloca al termine dell’onda lunga sviluppatasi sulle distruzioni del secondo conflitto mondiale, nel quadro però di una stagione di ripresa iniziata nella seconda metà degli anni ottanta. Carchedi (2011), in particolare, ha mostrato come le politiche neoliberiste abbiano permesso un recupero del saggio medio di profitto. Proprio negli anni ottanta, infatti, si registra un salto negli investimenti, che assume una dinamica esponenziale dopo gli anni duemila: una rivoluzione tecnologica, conseguente a massicce ristrutturazioni, all’introduzione della ICT ed alla diffusione dell’automazione, anche come risposta all’insorgenza operaia degli anni precedenti. Una crescita della composizione organica del capitale, a cui però non è conseguita immediatamente una diminuzione del tasso di profitto, per il parallelo e significativo aumento del tasso di sfruttamento.
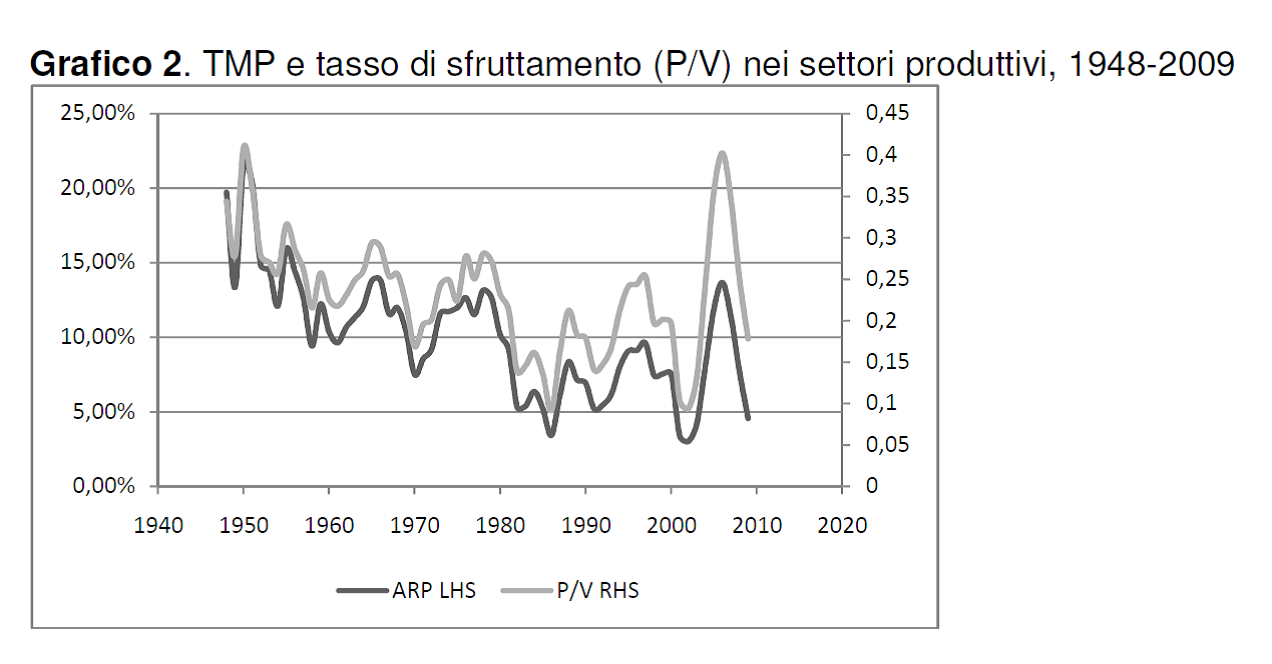
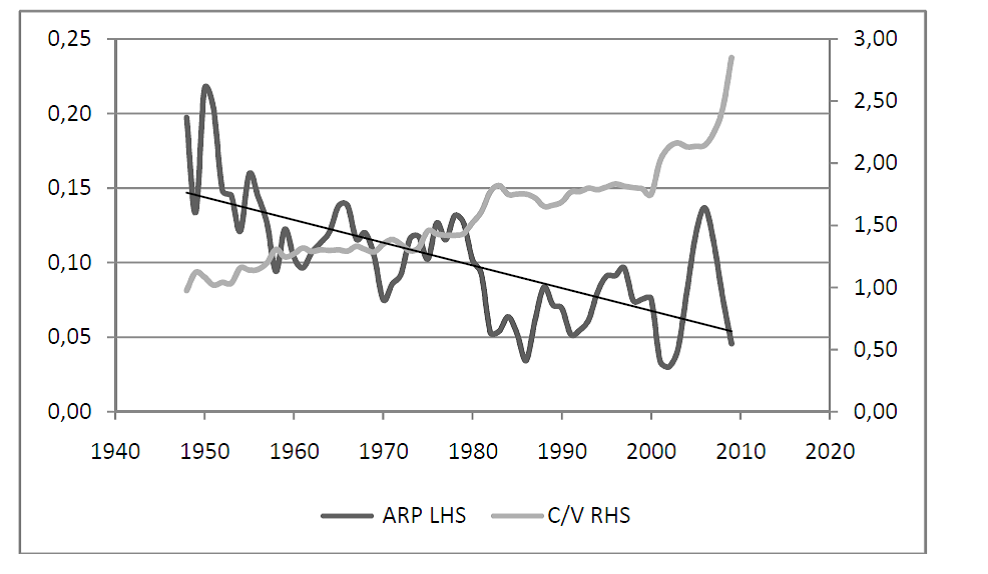
Non a caso, come è stato ricordato dallo stesso Carchedi, J.P.Morgan (una delle maggiori banche mondiali) ha scritto su quel periodo che i margini di profitto raggiunsero “livelli mai visti da decenni” e che “la riduzione dei salari e sussidi spiega la maggior parte” di quell’aumento. Bellofiore (2010), inoltre, ha sottolineato come una delle controtendenze più rilevanti in questa stagione abbia riguardato il mondo finanziario. Non solo con la generale esuberanza dei mercati azionari e delle transazioni internazionali, ma in particolare con un’espansione quantitativa e qualitativa del debito (attraverso la sua trasformazione, ad esempio con le cartolarizzazioni). Un debito che ha direttamente coinvolto anche lavoratori e lavoratrici, per sostenere i consumi e quindi gli spazi di investimento del capitale. La sovrapproduzione, infatti è stata rimandata nel tempo anche attraverso l’enorme espansione di capitale fittizio. Questa espansione del debito privato, in particolare nei paesi a capitalismo avanzato, ha portato ad un’inclusione subalterna delle famiglie dentro il capitale (dai mutui ai fondi pensione): una “sussunzione del lavoro alla finanza e al debito” che ha contribuito per qualche tempo ad invertire la tendenza, ma poi ha determinato l’esplosione della crisi generale anche per le sue stesse contraddizioni.
Husson (2013), infine, in un’analisi della crisi nel quadro della teoria delle onde lunghe, ha sottolineato come la ripresa del tasso medio di profitto degli ultimi vent’anni, determinata in particolare dall’aumento del saggio di sfruttamento, sia stata in qualche modo particolare. Diversamente dal solito, infatti, la fase neoliberista ha registrato una sconnessione tra profitti, accumulazione e produttività. Mentre nelle precedenti stagioni il tasso di profitto si è sostanzialmente mosso di concerto con l’espansione del capitale e con lo sviluppo della produttività, in questi due decenni le dinamiche sono cambiate. In particolare, il tasso di profitto ha conosciuto una sua progressiva ascesa (interrotta temporaneamente dalle crisi dei primi anni novanta e duemila), ma non è stata comunque garantita una riproduzione stabile del sistema per la difficoltà a un reinvestimento produttivo dei capitali dopo i primi anni novanta e per la caduta, sin da subito, della produttività del lavoro. Il ciclo lungo, cioè, non è ancora sfociato in una muova fase espansiva: da una parte ha accumulato poco (di meno in meno) e dall’altro ha evidenziato una tendenza al rallentamento della produttività reale dei fattori (nonostante le nuove tecnologie). Le contraddizioni strutturali di un’onda lunga depressiva, quindi, hanno operato anche durante l’ultima stagione (nonostante la ripresa del tasso di profitto) e sono poi esplose nella Grande Crisi del 2007-08.
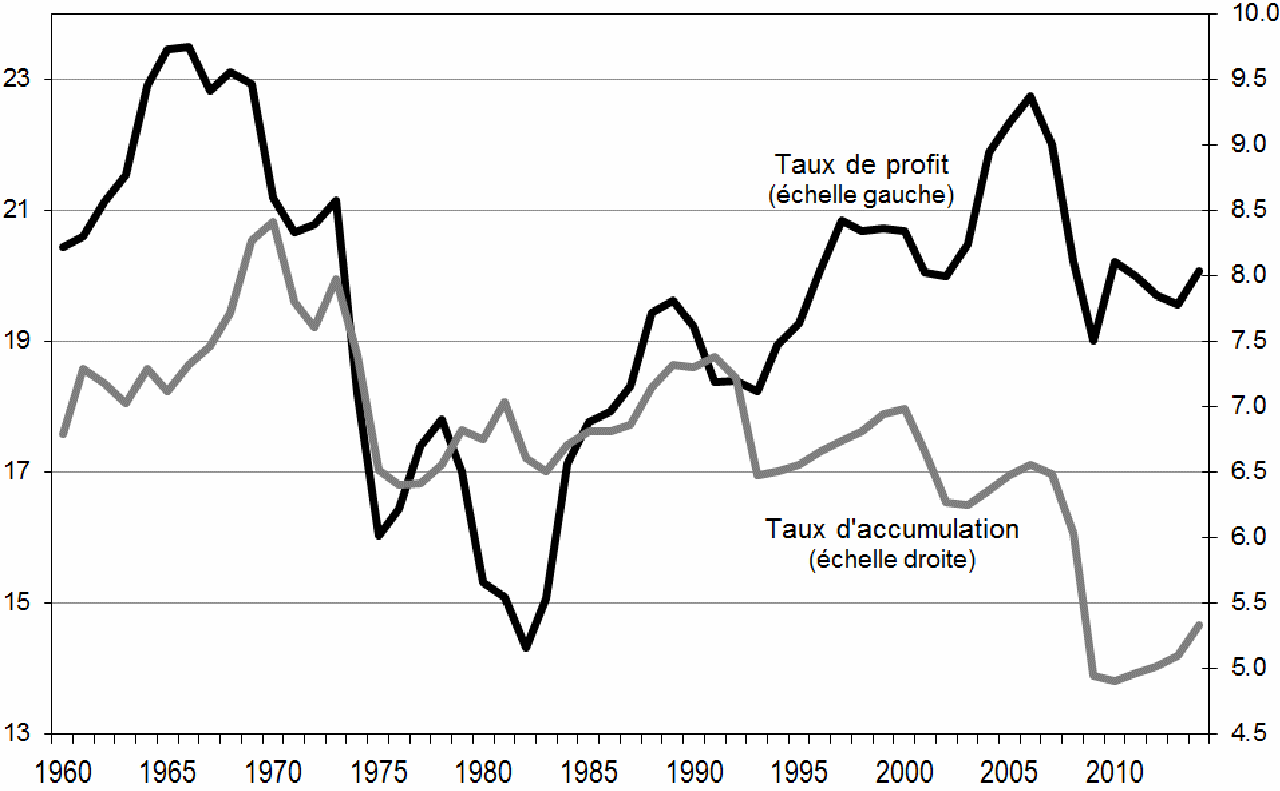
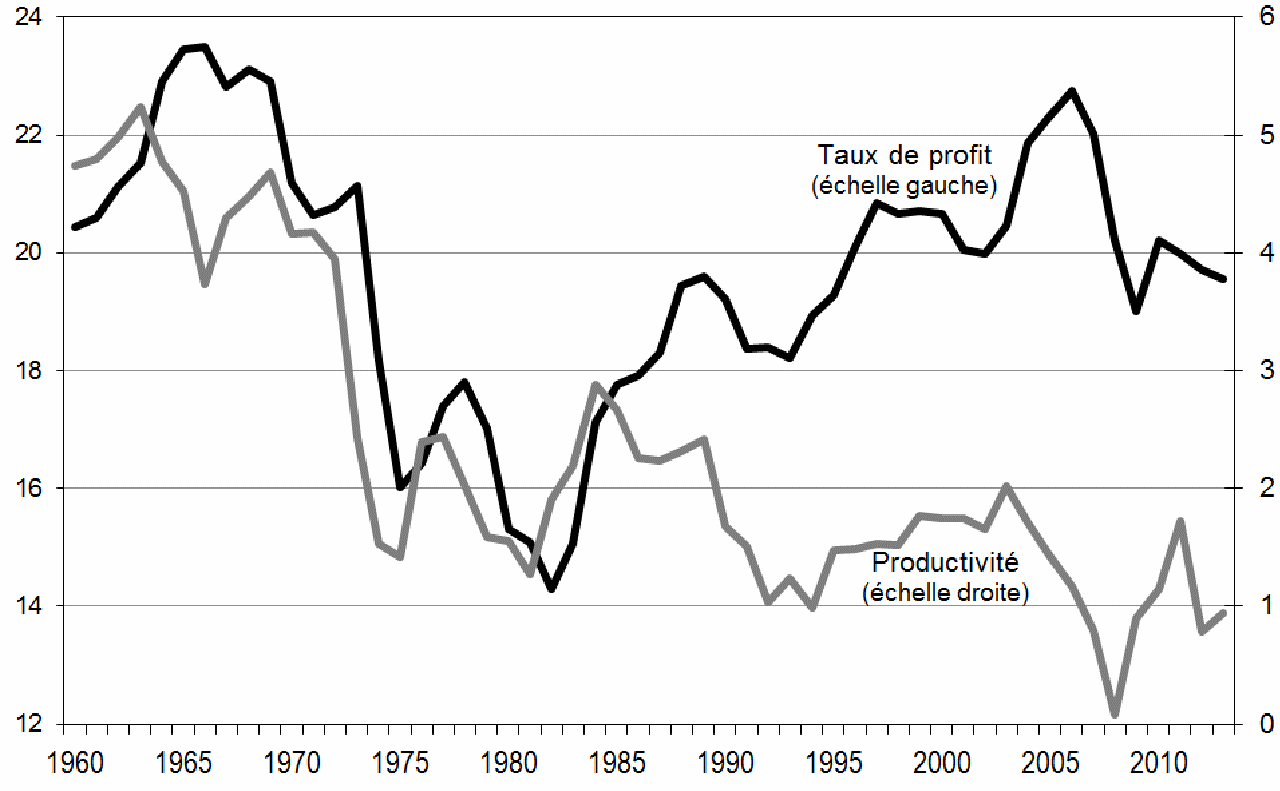
Come ricorda Husson, riprendendo Mandel, a determinare l’inversione di un’onda lunga in fase depressiva è sostanzialmente la dialettica tra i fattori oggettivi (i processi economici) e quelli soggettivi (la lotta di classe), con una relativa autonomia dei processi storici e sociali dalle dinamiche economiche. Le barbarie, inoltre, non consistono tanto in un tracollo finale, quanto nel protrarsi di un’instabilità violenta e regressiva (guerra, fascismo, ecc).
- Dinamiche ineguali e combinate del capitalismo. La crisi, infine, è utile che sia letta anche dal punto di vista dello sviluppo ineguale e combinato. Come sottolineato nei documenti dell’ultimo congresso del PCL, l’accumulazione del capitale si struttura non solo sulla polarizzazione in una data formazione sociale, ma anche sulla divisione internazionale del lavoro. Nei diversi paesi (poli ad alto e medio sviluppo, emergenti, semiperiferie e periferie), il capitale si muove alla ricerca dei più alti tassi di profitto, sussumendo anche precedenti sistemi produttivi e amplificando le diseguaglianze tra territori, anche attraverso la proiezione delle principali potenza (imperialismo). Questo processo è scandito dalle crisi. I cicli periodici di distruzione creativa, come le lunghe fasi di Grande Crisi con il loro annichilimento di grandi quantità di capitali ed il conseguente sconvolgimento delle relazioni sociali, determinano cioè scombussolamenti anche nelle gerarchie internazionali. La dinamica capitalista impedisce quindi la costruzione di un sistema stabile di regolazione, di un superimperialismo, perché il suo stesso movimento mette ciclicamente in discussione ogni equilibrio. La dinamica è cioè sempre ineguale: da una parte il capitale subordina nuovi mercati alla sua accumulazione attraverso politiche imperialiste; dall’altra avvia processi involutivi, degrado sociale, il deterioramento dei tessuti e dei rapporti produttivi di aree prima economicamente sviluppate. Nel contempo, la subordinazione di alcune formazioni sociali (controllo monetario e commerciale, regolazione del trasferimento di tecnologie e modelli produttivi, sostegno di borghesie compradore e imposizione di sistemi politici di riferimento), talvolta sospinge processi di accumulazione avanzati, consolidandone la struttura economica e anche quella di classe. La dinamica allora è non solo diseguale, ma anche combinata: ogni paese è integrato nei mercati mondiali subendo le contaminazioni, le influenze ed i cicli delle altre formazioni sociali, come del movimento complessivo del disequilibrio capitalista mondiale. Non esistono quindi percorsi e tappe di sviluppo predestinate: la realtà è articolata in formazioni sociali diverse, nel quadro di regimi politici bastardi (democrazie liberali o claniche, dittature civili o militari, monarchie costituzionali o assolute), sorretti da conflitti interimperialistici, da tendenze e controtendenze, dalla divisione internazionale del lavoro e della lotta di classe nel mondo.
- La Grande Crisi del 2007-08, e la stagione di crescita che l’ha immediatamente preceduta, allora deve tener conto anche del quadro ineguale e combinato delle dinamiche capitaliste. In particolare, il recupero del tasso medio di profitto dalla seconda metà degli anni ottanta, l’aumento del tasso di sfruttamento determinato dalle politiche neoliberiste, non ha avuto solo un riflesso interno ai paesi a capitalismo avanzato (austerità, privatizzazioni e sconfitte sindacali, come esemplificato dai governi Reagan e Thatcher), ma si è sviluppato in questo quadro ineguale e combinato. La riconversione industriale dei paesi a capitalismo avanzato, con una prolungata subordinazione del lavoro anche grazie a processi di sua scomposizione, ha potuto contare sull’estensione dell’accumulazione capitalista, in primis nell’area asiatica. In particolare, ha potuto contare sul dispiegarsi di una vera e propria rivoluzione passiva nella Repubblica Popolare Cinese, condotta dall’ala più moderata del PCC dopo la morte di Mao e il collasso della rivoluzione culturale, sotto la spinta delle sue stesse contraddizioni e della repressione maoista. Una rivoluzione passiva che ha permesso un sorprendente e smisurato sviluppo capitalista cinese, nel quadro di un regime politico di matrice stalinista che non solo si è protratto, ma si è rafforzato e stabilizzato. Un processo che è stato consolidato e rilanciato dal collasso del blocco sovietico e dall’inglobamento del suo spazio economico nel quadro del capitalismo mondiale nei primi anni novanta. Le riconversioni nei paesi a capitalismo avanzato e lo sviluppo capitalista cinese sono quindi avvenute nel quadro di una globalizzazione neoliberista, con la sussunzione di tutti i mercati nazionali e locali nei circuiti di valorizzazione capitalista, sotto il controllo della finanza internazionale e delle sue principali istituzioni (private o interstatali).
La Grande Crisi ha infine colpito in particolare i paesi a capitalismo avanzato, mentre la sua gestione capitalistica si è in larga parte basata sulla forza (e sul sostegno) del capitalismo cinese. Da una parte, infatti, proprio durante la Grande Crisi la Cina è passata da un capitalismo emergente ad uno emerso: da settima potenza mondiale (con un PIL inferiore ai 3mila mld di dollari nel 2006) a seconda (con un Pil intorno ai 12mila mld USA, a fronte dei 19mila USA, quasi 5mila del Giappone, 3mila600 della Germania, 18mila500 della UE e 16mila dell’Eurozona). Sono i mercati cinesi e la loro crescita sostenuta (dal 9,6% del 2008 al 10,6% del 2010, sino al 6-7% degli ultimi anni) che hanno permesso di mantenere, anche la crescita mondiale (con l’eccezione 2009, -0,1%). In quegli anni cruciali, in particolare, sono stati gli enormi investimenti pubblici cinesi (centinaia di miliardi di dollari), oltre all’enorme liquidità delle banche centrali, che hanno evitato il collasso.
È allora utile tenere in considerazione alcune particolari dinamiche di questo quadro ineguale e combinato: la competizione tra poli imperialisti (ed in particolare tra quelli tramontanti e quelli emergenti), le differenti dinamiche di classe nei diversi contesti.
- La competizione tra poli imperialisti. Al termine della prima globalizzazione del ‘900, nel corso della Grande Guerra, Lenin analizzò la dinamica imperialista. Una politica sviluppata nel corso della precedente onda lunga recessiva e che aveva accompagnato l’espansione della “belle epoque”. Cinque, in particolare, le caratteristiche individuate: la concentrazione del capitale nelle grandi imprese (monopoli), la fusione tra capitale bancario e capitale industriale in un blocco finanziario, l’esportazione di capitali come motore dell’espansione, lo sviluppo di associazioni monopolistiche internazionali e la tendenza delle grandi potenze a costruire (anche militarmente) proprie aree di influenza (aree commerciali e monetarie).
Nelle fasi di crisi questa dinamica del tardo capitalismo accelera e quindi tende a far precipitare le contraddizioni. In particolare, nelle Grandi Crisi la riduzione dei margini di profitto, la distruzione di capitale ed il degrado dei rapporti sociali esasperano gli spiriti e sospingono i conflitti. Determinano cioè un tempo di ferro più che di speranza.
Oggi emergono tre grandi poli nel mondo: gli Usa, l’Unione Europea e la Cina. L’espansione capitalista, nel corso del suo svolgersi ciclico, ha infatti sviluppato formazioni sociali sempre più ampie, sino a raggiungere dimensioni continentali. Ognuno di questi tre poli ha mercati maturi di oltre i 500 milioni di persone e un prodotto lordo che si misura nell’ordine delle decine di migliaia di miliardi di dollari (USA 19mila, Ue 18mila, Cina 12mila). Subito dopo viene il Giappone (126 milioni di abitanti e 5mila miliardi di dollari di Pil); poi Brasile e India (più di 200 milioni e 1,3 miliardi di abitanti, circa 2mila mild di Pil); quindi Canada, Corea del Sud e Russia (36, 50 e 146 milioni di abitanti, un Pil di circa 1500 miliardi di dollari).
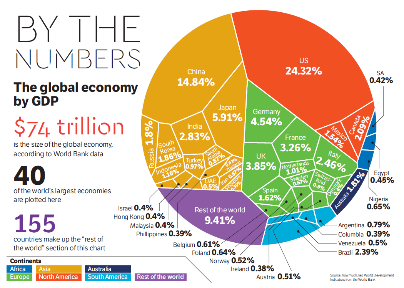
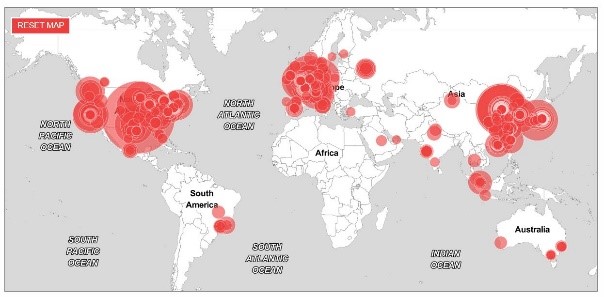
Ognuno di questi tre poli ha caratteristiche particolari.
- Gli Stati Uniti sono stati il paese dominante dell’onda lunga che si sta chiudendo. Dopo aver avviato un’industrializzazione accelerata a cavallo del secolo scorso, dopo aver consolidato un rilevante ruolo economico e finanziario nella fase calante della scorsa onda lunga (anni venti e trenta, pur colpiti da una significativa depressione), hanno acquisito una vera e propria supremazia con il secondo conflitto mondiale. Dal punto di vista economico, finanziario, politico e militare. Economico, perché per lungo tempo qui si è concentrato il cuore del sistema capitalista (la quota più ampia della produzione di merci e valore aggiunto): ancora oggi è americana una parte significativa dei grandi colossi (da Exxonmobil a Apple, da Amazon a ATT, circa 130 sulle 500 maggiori secondo Fortune). Qui hanno avuto ed hanno sedi i principali centri finanziari (dalla borsa di New York a quella sui futures di Chicago, dalla Goldman Sachs a JP Morgan Chase) e non a caso anche le principali istituzioni di regolazione politico-economica (dalla Banca Mondiale al FMI): il dollaro è stato ed ancora è la moneta di riferimento nel mondo, ed il suo controllo è stato usato dagli Stati Uniti per esternalizzare costi e disequilibri delle sue politiche economiche. La sua egemonia politica è stata evidente nel corso di tutta la guerra fredda (1946-1989) e, dopo la vittoria con la crisi ed il crollo del sistema sovietico, è stata la principale protagonista della nuova fase di globalizzazione (Washington consensus). La sua supremazia politica ed economica ha determinato anche un predomino culturale che ha influenzato tutte le società (immaginari e modelli di riferimento: cinema, tv, letteratura, ecc). Il suo dominio militare è altrettanto palese: dalla storica presenza di circa 700 basi in più di 70 paesi al controllo di una rete di alleanze (dalla NATO alla SEATO), sino al rilancio della spesa militare negli ultimi decenni (metà di quella mondiale, più di 600 mld di dollari annui) che le ha permesso un’evidente predominio in tutti i principali scenari (aria, acqua, terra, cielo e spazio).
Questa supremazia globale degli Stati Uniti si è però incrinata da tempo. L’inversione dell’onda lunga nei primi anni settanta ha avviato un progressivo declino economico e produttivo, con riflessi immediati nella sua capacità egemoniche (fine della convertibilità del dollaro e successiva liberalizzazione dei cambi). Questo declino è stato contrastato, anche con significativi successi, dalle politiche neoliberiste reaganiane: aumento dello sfruttamento e delocalizzazione interne; grandi investimenti pubblici in tecnologia (incubatori del successivo dominio USA sulle ICT), liberalizzazione del commercio internazionale. Politiche che sono state poi rilanciate dalla vittoria nella guerra fredda e la successiva globalizzazione sotto controllo americano. Questa azione di contrasto, se pure ha mantenuto l’egemonia americana, non ha però invertito il suo regresso economico (l’esplosione del debito estero americano né è l’indicatore più evidente). Anzi, la crescita del peso e dell’influenza economica di altri soggetti ha fatto crescere, negli ultimi decenni, il ruolo della sua proiezione militare, unico strumento in grado di concretizzare la sua egemonia politica. Una proiezione militare, però, che è sempre più contrastata e difficile da sostenere (dall’Afghanistan all’Irak) e che sta diventando a sua volta indicatore del declino americano.
- L’Unione Europea si caratterizza per la pluralità dei suoi imperialismi: il loro antagonismo latente o manifesto, il tentativo di coordinamento e integrazione rilanciato dopo i primi anni novanta, la perdurante assenza di un sistema federale e le contraddizioni che ne conseguono. Il modo di produzione capitalista nasce e si sviluppa in Europa (a partire dai Paesi Bassi prima e l’Inghilterra poi), espandendosi nel corso dell’ottocento sul continente. In questo quadro, l’economia europea ha a lungo primeggiato nel mondo (basti considerare il grafico precedente), ma per lungo tempo la dinamica capitalista è stata dominata proprio dalle competizioni tra gli imperialismi europei, che hanno segnato anche il lungo conflitto del 900 (grande guerra e seconda guerra mondiale). Il dispiegarsi del dominio USA nel dopoguerra, in un continente per di più diviso dalla guerra fredda e dalla contrapposizione USA-URSS, ha accompagnato il rapido declino degli imperialismi europei, sia nelle dinamiche economiche sia nelle loro proiezioni di potenza (lo spartiacque fu la crisi di Suez nel 1956). L’inversione dell’onda lunga negli anni settanta, la caduta del saggio di profitto e l’esacerbarsi della competizione mondiale, hanno spinto prima ad un maggior coordinamento (sotto guida francese) e poi ad avviare un processo di integrazione (sotto guida tedesca), che si è consolidato con la fine della guerra fredda (riunificazione e integrazione dei paesi centro-orientali). L’Unione Europea ha quindi provato a costruire contraddittoriamente un mercato unico delle merci (compreso il lavoro) e poi una moneta di riferimento, senza integrare realmente i capitali e le sue moderne politiche di gestione (a partire da un bilancio federale e sistemi fiscali coordinati). Ha provato cioè a sfruttare i vantaggi delle sue dimensioni continentali nella competizione mondiale (avviando anche alcune centralizzazioni, sia a livello finanziario sia in alcuni settori strategici come acciaio e aerospazio), cercando di mantenere ampi spazi di autonomia ai capitali nazionali. La Grande Crisi del 2007-08 ha però acutizzato le contraddizioni di questo percorso. Da una parte si è ipotizzato l’avvio di un lento processo federalista: cioè la costruzione di infrastrutture continentali a livello politico (un qualche tipo di governo per la gestione dei conflitti, esterni e interni), economico (un vero mercato unico dei capitali, delle banche e dei mercati finanziari, per costruire campioni continentali) e militare (uscita dalla subordinazione agli USA nella NATO; integrazione dei diversi eserciti anche per ragioni di costi). Dall’altra le inevitabili polarizzazioni determinate dalla lunga crisi hanno invece rinvigorito le tendenze centrifughe insiste nel processo: è cresciuta in questi anni la disuguaglianza tra il nucleo produttivo e la sua periferia, sono progressivamente evaporate istituzioni fragili (Commissione, Parlamento e Consiglio d’Europa), si sono sviluppati populismi e nazionalismi sia nella mitteleuropa di influenza tedesca (Polonia, Ungheria e Slovacchia), sia nel cuore imperialista del continente (UKIP in Gran Bretagna, FN in Francia, AfD in Germania, Lega e M5S in Italia), sia nella sua buccia (Belgio, Svezia e Danimarca).
- La Cina è oramai emersa come potenza capitalista e sta sviluppando una sua proiezione imperialista. Nei primi anni ottanta, la nuova direzione denghista del PCC ha avviato una vera e propria rivoluzione passiva: la Cina, infatti, pur mantenendo il suo particolare regime stalinista (anzi stabilizzandolo dopo i tumulti della rivoluzione culturale) ha conosciuto un’imponente sviluppo capitalista. Prima con timidi esperimenti nelle campagne e nell’industria (Zone economiche speciali), poi con l’estensione progressiva di una produzione per il mercato (privatizzazioni e riconversione delle aziende pubbliche), infine con il dilagare delle logiche di valorizzazione ed un’estesa finanziarizzazione del sistema, sino all’entrata nel WTO e l’integrazione nel sistema capitalistico mondiale. Il tutto imprimendo un tasso di sviluppo impressionante, per durata e misura, mai visto neanche nella prodigiosa ascesa statunitense. Il PIL nel 1981 era di circa 290 miliardi di dollari, il nono del mondo. Nei successivi 38 anni ha conosciuto un’espansione ininterrotta, solo una volta inferiore al 5% (1989-90) e superiore al 10% in tre momenti prolungati (primi anni ottanta, primi novanta e primi duemila). Sino a diventare la seconda potenza economica (a grande distanza dalla terza, come abbiamo visto) e la prima industriale (29,5% del valore aggiunto manifatturiero mondiale, contro il 19% USA, l’8% giapponese, il 6% tedesco, intorno al 2,5 per SudCorea, India e Italia). In Cina ci sono infatti delle principali imprese al mondo, tra cui 3 delle prime 5 (Stategrid, Sinopec e China petroleum, con fatturati di oltre 300 mld di dollari) e oltre 100 tra le prime 500 (tra cui China Mobile, Bank of China, Hon Hai Precision Industry-Foxconn, Chemchina, China Railway Engineering, Ping An Insurance e altre). Colossi privati come Huawei (53 mld di euro di fatturato), Weiqiao (tessile, 45 mld), Lenovo (elettronica, 42 mld), Amer (rame, 40 mld), Alibaba (commercio online, 40 mld), CEFC (petrolchimico, 35 mld), Tencent (intrattenimento, 30 mld), Hengli (tessile, 29 mld), Shagang (siderurgico, 28 mld).
L’ascesa del capitalismo cinese convive però con forti contraddizioni, potenzialmente esplosive. Larga parte del paese è ancora povero: il PIL pro capite è intorno agli 8mila dollari (contro i 30mila dell’Italia ed i 60mila degli Stati Uniti), con forti squilibri (andando dai 14-15mila delle zone costiere ai 2-3mila di quelle meridionali) e grandi diseguaglianze anche nelle aree più sviluppate. La Grande Crisi del 2007-08 non ha determinato alcuna recessione, ma solo un progressivo rallentamento (con una flessione della crescita del PIL, dal 14% del 2007 a circa il 6,5% del 2018). Un rallentamento che però ha acutizzato questi squilibri (demografici, geografici e sociali) e che, assieme alla significativa espansione del debito pubblico e privato, mette a rischio il modello cinese. Questo modello, infatti, si è retto non tanto sulle esportazioni o sulla crescita dei consumi (come talvolta rappresentato), quanto sugli investimenti (in particolare dopo la crisi, raggiungendo anche il 50% del PIL, a fronte del 20% e anche meno degli altri paesi capitalisti: dall’espansione immobiliare a un impressionante rete infrastrutturale, come l’alta velocità che oramai è più estesa che in tutto il resto del mondo). In questo quadro, non può essere ovviamente esclusa una crisi. Un’eventualità che non cambia quanto detto sinora: anche gli emergenti Stati Uniti conobbero una depressione, senza che questo mettesse in discussione la loro ascesa.
Un’ultima considerazione: le contraddizioni viste (dalla sovrapproduzione agli squilibri del settore infrastrutturale) stanno sospingendo una proiezione imperialista della Cina, spronata dalla necessità di trovare nuove occasioni di profitto competendo con gli altri poli imperialisti. Così è cresciuta esponenzialmente l’esportazione di capitali (moltiplicandosi di 15 volte dal 2000), sono stati tracciati diversi assi di espansione (Sudamerica, Africa, vie della seta marittime e terrestri con la Belt and Road Initiative), si sono forgiati gli strumenti per la costruzione di un’area di riferimento monetaria e commerciale (entrata dello yuan tra le monete di riserva, costituzione della Banca Asiatica d’Investimento, accordi di Shangai), si protendono i primi timidi tentacoli militari (Mar Cinese Meridionale; sviluppo della flotta con portaerei e sommergibili nucleari tattici; costruzione di una base portuale a Gibuti).
- La centralità del lavoro nel modo di produzione capitalista e le dinamiche di classe nei diversi contesti. In questo quadro diseguale e combinato, in questa stagione di rilancio tecnologico e di Grande Crisi, il lavoro è comunque rimasto il fattore principale della produzione (insieme al capitale). La produzione in una società capitalista, infatti, è produzione di valore attraverso un rapporto sociale: cioè è estrazione di valore dal lavoro vivo, attraverso lo sfruttamento, al di là di cosa quel lavoro crea (un oggetto o un servizio) e di come quel lavoro si determina specificamente (se con le mani o con la mente). Proprio la Grande Crisi ha ribadito in maniera evidente il ruolo dello sfruttamento in questo modo di produzione: è sulla sussunzione ed il controllo dei processi lavorativi, sul salario e sull’orario, che si riproduce questa società e la sua struttura di potere. E proprio per questo, sul lavoro si sta sviluppando un enorme pressione: per intensificarne i ritmi, dilatarne i tempi e ridurne la paga; per controllarlo, scomporlo e disciplinarlo; per contenerne la coscienza sociale e politica.
Nei processi produttivi, perciò, si tende a comprimere l’autonomia della classe. Si cerca cioè di considerare lavoratori e lavoratrici come semplice forza lavoro, riducendoli ad una variabile dipendente dalla produzione. Si schiaccia la loro identità su quella dell’azienda, con i modelli di qualità totale. Si incapsula i processi di lavoro in un flusso regolato e sovradeterminato dall’automazione. Si disciplina i comportamenti sindacali, sia con l’involgimento partecipativo di organizzazioni e rappresentanze, sia con lo smantellamento di contratti e diritti.
Nei processi sociali, invece, si tende a inglobare le classi subalterne, al fine di scomporne l’azione e ridurne il ruolo. Da una parte, si sottolinea e rimarca le dinamiche competitive delle contrapposizioni internazionali, in particolare nei poli imperialisti ma non solo, dalla retorica sul sistema paese alle narrazioni nazionaliste o sovraniste. Dall’altra, nei processi politici ed anche istituzionali, si fa assumere salienza a identità comunitarie socialmente trasversali, di carattere territoriale, etnico o religioso (federalismi, integralismi e tribalismi della modernità).
Questi processi e queste dinamiche hanno sempre caratterizzato il modo di produzione capitalista. Con l’egemonia o la repressione, si è sempre cercato di controllare, subordinare e disciplinare il lavoro, a partire dalla sua organizzazione: ora la sua concentrazione e ora con la sua dispersione; ora con il controllo esterno dei flussi (catena di montaggio) ed ora con la competizione tra squadre (isole produttive). Come il proletariato si è sempre cercato di dividerlo per professione e professionalità, per lingua o dialetto, per genere o etnia. Basti pensare all’Inghilterra dell’800 ed alle divisioni tra cattolici e protestanti, tra inglesi e irlandesi, tra tessitori e meccanici, operai specializzati e manovali, uomini (con diritto di voto e salario pieno) e donne (politicamente marginali e relegate in alcuni settori o mansioni). O basta pensare all’Italia degli anni ‘50 e ‘60, a partire dal suo triangolo industriale, ed alle divisioni tra autoctoni (lombardi, piemontesi, liguri) e migranti (meridionali, veneti, bergamaschi), tra residenti (con libretto di lavoro) e clandestini (che non ne avevano diritto), tra operai professionali e operai massa, tra uomini (capi famiglia a tempo indeterminato) e donne (precarie e relegate nei ruoli famigliari). Oggi, semplicemente, questi processi si rinnovano nel quadro della globalizzazione e della sua crisi. Come è stato sottolineato nei documenti dell’ultimo congresso del PCL, in questo quadro ineguale e combinato anche la dinamica dell’organizzazione e del conflitto di classe ha visto processi differenziati, se non divergenti.
- Nei paesi ad alto sviluppo capitalista (USA, Europa, Giappone) la crisi economica si è accompagnata ad una crisi del movimento operaio. Come abbiamo visto per il caso italiano, in tutti i paesi avanzati l’onda lunga depressiva che è seguita all’assalto al cielo degli anni ‘60/’70 è stata segnata da ristrutturazioni, dispersione e deindustrializzazione, sussunzione ed espansione del terziario. Questi processi hanno ovunque inciso sulla forza e l’organizzazione di classe. Hanno cioè determinato un sostanziale arretramento, oltre che un’involuzione della coscienza politica, intrecciandosi con ripetute sconfitte, una diffusa desindacalizzazione ed un’estensione della precarizzazione. Tuttavia, sarebbe sbagliato pensare ad una dinamica di ripiegamento rettilinea e incontrastata. Nella scomposizione, alcuni settori hanno mantenuto una propria organizzazione e combattività; mentre altri, completamente destrutturati e con una composizione completamente nuova, hanno avviato nuovi processi antagonistici, con cicli di lotta e processi di riorganizzazione soggettiva della classe. E, in ogni caso, ci sono state diffuse resistenze e persino controtendenze: talvolta con la tenuta di una sindacalizzazione significativa (Italia), talaltra con grandi movimenti di massa del lavoro (Francia) o ancora con processi molecolari di opposizione (Stati Uniti). Nel corso di questa lunga stagione, cioè, è emersa qui e là una tenuta dell’organizzazione di classe, una riproduzione di tradizioni politiche e sociali, una capacità di tenere il punto nei rapporti di lavoro. Nei paesi a capitalismo avanzato, quindi, c’è una classe lavoratrice spesso scomposta, sovente poco determinata e qualche volta esausta, ma anche con una lunga storia, nuclei che hanno mantenuto una tradizione conflittuale, settori con una certa consapevolezza anticapitalista. Con la crisi del 2007-08, questi processi si sono polarizzati. Da una parte, si è registrata un’evidente perdita di egemonia delle classi dominanti. Dall’altra, si è accelerata la scomposizione e l’involuzione della coscienza politica di massa, che in tutte le realtà ha fatto delle classi subalterne non solo un bacino di riferimento, ma anche un soggetto determinante dell’avanzata reazionaria in corso (Usa di Trump, Francia di Lepen, Gran Bretagna della Brexit, Italia della Lega e 5S).
- In Italia, in particolare, negli ultimi anni si sono moltiplicate le linee di frattura della classe, che rischiano di allargarsi ulteriormente nel futuro. La lunga transizione neoliberale, e poi la lunga depressione nelle Grande Crisi, le ripetute sconfitte e la rarefazione dei movimenti di massa hanno particolarmente segnato la dinamica di classe di questo paese. Sino al 2012-14, però, si sono periodicamente ripetute grandi lotte generali, che hanno saputo dare salienza ai conflitti del lavoro sul piano politico, nel senso comune e nelle rappresentazioni collettive: nel 92-94 l’autunno dei bulloni e resistenze operaie; nel 98-02 il movimento noglobal e la ripresa metalmeccanica (Melfi e precontratti); nello 02-04, l’articolo 18; nel 06-08 il movimento contro la precarizzazione e uniti contro la crisi; nel 10-12 l’opposizione al modello Marchionne. Dopo l’estemporanea stagione della lotta al jobsact (un corteo ed uno sciopero generale), questa dinamica si è sostanzialmente spenta. Nel frattempo, sin dai primi anni duemila (esaurimento della concertazione), la pratica sindacale si è verticalizzata, con dinamiche contrattuali differenti nelle diverse categorie. Dividendo non solo sul salario ma anche nelle scadenze, nei diritti, nella struttura contrattuale i diversi settori del lavoro. Questa dinamica si è confermata, se non accentuata, nell’ultima stagione (15-18). Nel quadro di un’egemonia politica dei movimenti reazionari, la classe lavoratrice si è quindi frastagliata tra impiegati pubblici (esterni alla valorizzazione), dipendenti di servizi a recente valorizzazione capitalistica (privati e pubblici), classe operaia centrale e diffusa, proletariato urbano generico e professionale, manovalanza migrante, disoccupati e sotto-occupati (giovani, donne, aree produttive marginali). Una divisione rimarcata dalla disarticolazione territoriale: una piccola e media industria manifatturiera al nord, le grandi fabbriche sparse e isolate al sud (Ilva di Taranto; FCA di Pomigliano, Melfi, Termoli e Cassino; petrolchimici); la logistica su alcuni poli del centro-nord (Torino, Milano, Vicenza-Padova, Piacenza, Bologna, Roma); un bracciantato ipersfruttato in alcune aree, al sud e non solo (ragusano, piana di Goia Tauro, tavoliere, ciociaria, come le valli trentine o la veronese); un precariato professionale nelle grandi città (Milano, Roma, Napoli, ecc); la disoccupazione in particolare al sud e nelle isole. In questo quadro, inoltre, si diffondono i processi di ristrutturazione sospinti dalla Grande Crisi, in particolare con l’automazione e la digitalizzazione di progettazione, produzione e commercializzazione, che permettono una loro stretta integrazione. Una ristrutturazione che determina un continuo monitoraggio e scambio informativo, che consente non solo di controllare il flusso produttivo ma anche di dire ad ogni lavoratore cosa fare e quando farlo. Un processo cioè che aumenta il comando sul lavoro, lo sfruttamento e quindi lo stress di lavoratori e lavoratrici. E che cambia conseguentemente anche la composizione di classe (standardizzazione delle professionalità, nel quadro di un maggior controllo sui processi che richiede una minor formazione specifica), dividendola secondo nuove faglie (ad esempio tra chi possiede competenze e conoscenze generali, dalle abilità informatiche a quelle linguistiche, e una manodopera generica marginalizzata).
- Nei paesi emergenti ed emersi (Cina ed Asia in primo luogo), è affiorata una nuova classe lavoratrice in via di organizzazione. Nella dinamica ineguale e combinata del capitalismo, l’onda lunga depressiva degli ultimi decenni è stata segnata anche dalla grande espansione economica e l’estesa industrializzazione di alcuni paesi, in particolare sulle sponde del pacifico orientale. Uno sviluppo che ha inevitabilmente determinato l’espansione e quindi un’organizzazione di classe. Infatti, l’occupazione nell’industria manifatturiera dopo il 1980 in questi paesi è aumentata di oltre il 120%, mentre nei paesi a capitalismo avanzato è diminuita del 19%. Una dinamica che è stata parallelo all’aumento globale del tasso di salarizzazione (la proporzione di salariati nell’impiego totale), che è passato dal 33% al 42% durante gli ultimi 20 anni (dinamiche che è particolarmente marcata per le donne).
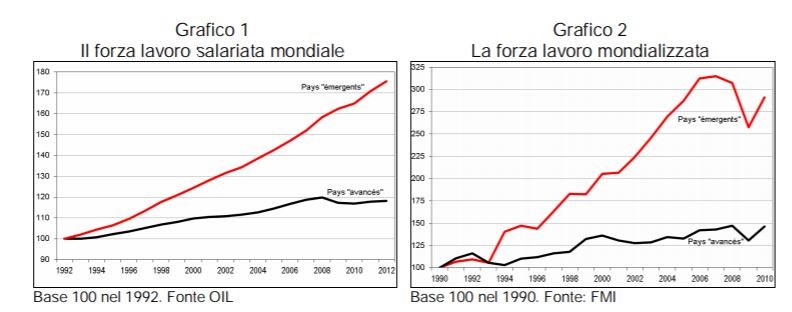
Questa è una classe operaia giovane, di età e soprattutto di tradizione. In larga parte, in Cina come negli altri paesi che hanno conosciuto questo sviluppo, è di recente o recentissima immigrazione dalle campagne (massimo di seconda generazione). Spesso è ancora in condizioni di semi-legalità, con un’alta mobilità ed una professionalità immatura. Una classe poco organizzata socialmente, con un’identità ancora incerta e scarse tradizioni, una coscienza politica debole e spesso direttamente repressa (in particolare nei paesi di matrice stalinista, come la Cina, il Vietnam, la Cambogia, ma non solo). In queste realtà, in ogni caso, lo sviluppo economico e le contraddizioni sociali della fase espansiva hanno sospinto anche un ciclo di lotte, una curva ascendente delle mobilitazioni sociali, a partire da quelle della classe operaia industriale per il salario e per condizioni di lavoro minimamente decenti (salute, ritmi, ecc). La sovrapposizione tra crisi e lotte operaie ne ha favorito la continuità e per alcuni aspetti la radicalizzazione. La triplicazione del salario operaio cinese negli ultimi dieci anni è il portato di questa ascesa, con lo sviluppo parallelo di una minima coscienza dei propri interessi collettivi e la rivendicazione anche di un salario indiretto (sistemi pensionistici) e sociale (scuole, sanità, coperture da infortuni, sostegni in fase di crisi, ecc).
Nei paesi periferici e semiperiferici, si sono sviluppate stridenti ed esplosive contraddizioni sociali. La prolungata fase di globalizzazione, rilanciata dal dissolvimento del campo “socialista” (che era parzialmente sganciato dal mercato), ha portato alla generalizzazione del dominio capitalista. A portato cioè ad estendere in tutte le società i processi di valorizzazione del capitale, sotto la spinta di una tendenza alla caduta del saggio di profitto che ha continuato ad agire sotto la cresta delle controtendenze dominanti. Questa estensione è avvenuta attraverso la sussunzione formale (commercializzazione) o reale (controllo dei processi di lavoro) di settori prima estranei al mercato capitalista, perché sotto controllo collettivo (servizi pubblici o spazi comunitari) o regolati da altre logiche economiche (terziario, servizi personali, piccola produzione contadina). Al centro di questo fenomeno la liberalizzazione dei commerci (che ha sconvolto economie e sistemi produttivi locali, spesso imbastarditi da formazioni sociali composite e dalla dimensione locale dei mercati di riferimento) e in particolare la rivoluzione agricola (con la standardizzazione e l’industrializzazione anche biogenetica delle produzioni), che ha colpito quella larga parte della popolazione ancora legata ad una limitata riproduzione contadina. Questi processi, in parallelo all’ipersviluppo che abbiamo sopra richiamato, hanno determinato un’accelerata urbanizzazione dopo gli anni ottanta (raddoppiandone in trent’anni l’incidenza mondiale). Più di metà della popolazione umana vive oggi in città (per un caso della storia, proprio dal 2007-08). Un dato che storicamente è strettamente connesso allo sviluppo capitalista (le prime società con questo tasso di urbanizzazione sono i Paesi Bassi e l’Inghilterra nella rivoluzione industriale, l’Italia vi arriva solo nel secondo dopoguerra). Questo fenomeno oggi interessa prepotentemente, in forma inedita, anche i paesi semiperiferici e della periferia. Basti considerare l’esplosione delle megalopoli (città con oltre i 10 milioni di abitanti).
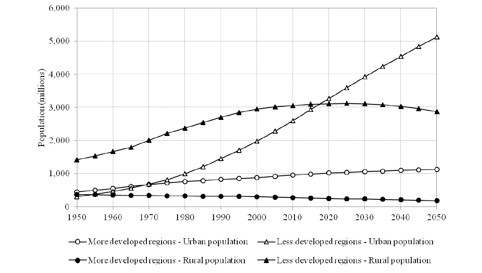
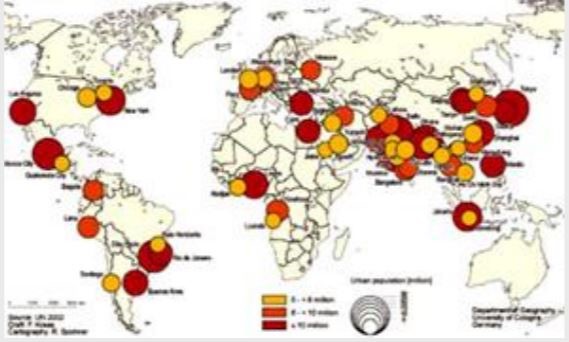
Oggi sono oramai più di una trentina, con circa 500 milioni di abitanti: non solo Tokyo (38 milioni) e Shangai (27 milioni), non solo i poli cinesi (grandi città estese, come Pechino e Tianjin, 21 milioni la prima e 15 la seconda, o Gaungzhou-Foshian-Shenzen-HongKong, per un bacino di oltre 60 milioni), ma anche Delhi (25 milioni), Karachi (23), Lagos (21), Dhâkâ (15), Istanbul (14 milioni), Mumbai (12), San Paolo (11), Giacarta (10) o Lahore (10). In questi contesti urbani si addensa quindi un nuovo popolo dell’abisso: un proletariato sottoccupato o inoccupato, giovane, poco scolarizzato e scarsamente professionalizzato, disorganizzato e sradicato dai contesti di provenienza, che talvolta ha ricostruito nuove identità e comunità di riferimento (talvolta etniche o religiose, altre volte microterritoriali, spesso con un forte antagonismo sociale con le borghesie integrate delle proprie realtà).
Non è questa l’unica dinamica sociale rilevante. A fianco di questo proletariato informe, particolarmente nelle realtà semiperiferiche ed in sviluppo (come Brasile, Turchia, Sudafrica, Iran, paesi Arabi, ecc) si è sviluppata una classe media urbana (impiegati pubblici estranei ai processi di valorizzazione; ceti commerciali legati alle esportazioni, al turismo, alla distribuzione; impiegati e tecnici di multinazionali o monopoli statali). Una piccola borghesia composita, inserita nei circuiti e negli immaginari globali, con aspirazioni ai consumi ed alla vita dei paesi a capitalismo avanzato. Una piccola borghesia però sempre sull’orlo, anche fisicamente prossima agli slums ed ai quartieri proletari, che può in ogni momento cadere per la mancanza di retroterra patrimoniali e stabili protezioni sociali (welfare state). Una componente rilevante di questa piccola borghesia è costituita da diplomati e studenti universitari (per fare un esempio, in Iran sono quasi 5 milioni; 1,7 in un solo Ateneo, l’Islamic Azad University di Theran). Giovani, con un’alta educazione e grandi aspettative, a rischio però di cadere nell’abisso per la difficoltà di assorbire numeri così imponenti con una crescita non più scontata. Una gioventù già socialmente in tensione, in quanto inserita in società tradizionali, spesso patriarcali, con stereotipi e discriminazioni di genere, un ampio controllo dei comportamenti se non una vera e propria repressione sessuale.
Angolazioni, linee di frattura e possibili sviluppi.
- Cerchiamo allora di combinare le componenti strutturali della crisi con le sue dinamiche ineguali e combinate. Se è vero che non serve un meteorologo per sapere dove soffia il vento, prevedere il clima può esser in realtà molto complesso. Fuori di metafora, non solo il futuro è sempre incerto per definizione, ma le complesse interazioni tra dinamiche oggettive e dinamiche soggettive in un contesto di Grande Crisi rendono strutturalmente imprevedibile tempi, modalità e curvature del suo svolgimento. Il quadro analitico illustrato lo esplicita credo chiaramente. Nonostante questo, alcune linee di frattura, alcune angolature e alcune conformazioni di questo complesso panorama sono rilevabili. Non abbiamo un percorso, ma forse un quadro delle possibili vie di fuga che si dispiegano davanti a noi lo possiamo tracciare. Le caratteristiche strutturali e le dinamiche della Grandi crisi, la loro articolazione ineguale e combinata, ci aiutano cioè a indicare alcuni tratti sulla stagione che sia apre. Ne sottolineo sedici: 8 sul quadro generale e 8 sulla nostra specifica realtà.
- È improbabile una stabilizzazione di lungo periodo, senza una nuova prolungata stagione di barbarie. L’inversione di un’onda lunga depressiva, la ripresa da una Grande Crisi, è complicata. Il saggio medio di profitto è troppo compresso, nel sistema c’è ancora troppo capitale, mancano occasioni e spazi per una sua ulteriore valorizzazione (in estensione o profondità). Per invertire la tendenza di fondo, cioè, è necessario che la cosiddetta “distruzione creatrice” faccia il suo corso, annientando capitale finanziario, capacità produttive, forza lavoro in eccesso. È cioè necessario che si dispieghi pienamente, e più profondamente, una stagione di barbarie, incremento della miseria e disuguaglianze, con o senza una guerra generalizzata, per ricostruire le condizioni di una nuova lunga espansione. O che, in alternativa, nella crisi si imponga politicamente un diverso modo di produzione, abbattendo le attuali classi dominanti ed il loro sistema di potere.
In questo quadro, la dinamica della Grande Crisi è probabile sviluppi e acutizzi nel prossimo futuro le tensioni internazionali (competizione tra potenze e poli imperialisti), come in ogni formazione sociale (crescita dello sfruttamento, instabilità dei sistemi di regolazione e protezione collettiva, aumento delle disuguaglianze e dei conflitti sociali). Come sottolineava tempo fa Antonio Gramsci, infatti, quando “il vecchio muore ed il nuovo non può nascere: in questo interregno si verificano i fenomeni morbosi più svariati”.
- Nel frattempo, si stanno confrontando diverse gestioni capitalistiche della crisi. La dinamica di una crisi, anche di una Grande Crisi, non prevede in sé un crollo del sistema. Il vuoto, in politica come nelle società, non esiste. In assenza di una proposta alternativa, ad imporsi è la politica delle classi dominanti, che prova a riprodurre il sistema esistente. Una gestione capitalistica della crisi, per l’appunto. Una gestione che prova a dilazionare la depressione, a curvarla, sostenendo un ciclo economico anche se questo è destinato ad implodere. Le gestioni capitalistiche della crisi possono esser diverse, basandosi su diverse frazioni del capitale e impostando differenti sistemi di regolazione. La gestione liberale che ha dominato nell’ultimo decennio, basata sostanzialmente sulla difesa dell’espansione finanziaria e del debito, sul logoramento del salario (in particolare quello sociale) nei paesi a capitalismo avanzato, sullo sviluppo della produttività nei paesi a recente emersione, sulla riproduzione di un sistema liberalizzato di scambi internazionali, è oggi in discussione. Per le sue contraddizioni e per lo scarso consenso (in particolare nei paesi a capitalismo avanzato). In questi anni sta provando ad emergere una diversa gestione, nel quadro anche di una tendenza alla precipitazione dei conflitti e delle contraddizioni: un modello reazionario, volto più direttamente al controllo ed alla repressione, all’aumento dello sfruttamento ma anche alla protezione delle comunità di riferimento. Parafrasando la frase che abbiamo richiamato: se una gestione capitalista della crisi si esaurisce, ma un’altra non ha ancora la forza di imporsi, tanto più in questo interregno si verificano i fenomeni morbosi più svariati.
- I segnali di una nuova precipitazione della crisi, in ogni caso, si stanno moltiplicando. La gestione liberale della crisi ha prodotto una nuova grande espansione del debito, pubblico e privato: dai 162mila miliardi di dollari nel 2007 ai 233mila del 2017, più del triplo del PIL mondiale. Nel contempo, ha moltiplicato gli squilibri tra settori, territori, capacità produttiva e capacità di realizzo. La stessa espansione cinese, che tanto ha pesato come bilanciamento con i suoi mercati, i suoi investimenti e la sua enorme spesa pubblica, si avvicina ad un punto critico: rallenta progressivamente la crescita, si espande il suo debito. Nel contempo, il perno statunitense sembra aver cambiato politica di gestione (dalle guerre commerciali agli interventi militari all’estero). In questo quadro, è possibile che in tempi relativamente brevi, sia per shock di carattere geopolitico, sia per la dinamica del ciclo, si determini un nuovo crollo dei mercati e/o nuove recessioni. Non è solo la previsione di alcuni analisti (come ad esempio quel Nourel Roubini che già intravide la crisi del 2007-08), ma anche la dinamica di alcuni indicatori economici: per esempio il differenziale (spread) tra i tassi d’interesse sui buoni del tesoro USA a breve (due anni) ed a lungo (10 anni). In genere, i tassi di interesse a lungo termine sono più alti, dovendo remunerare un rischio più alto. Non solo: i tassi decennali indicano una richiesta di credito a lungo termine, cioè di investimenti; quelli a breve sono più legati alla domanda, facilitandola quindi quando sono bassi. Tassi bassi a lungo termine sono allora indicatori di un’aspettativa negativa; tassi a breve alti di un aumento del rischio nel breve termine. Di fatto, l’inversione dei tassi (quando lo spread si avvicina a 0 o diventa negativo) è storicamente uno dei principali indicatori di recessione (con un anticipo di 6/8 mesi) ed oggi questo indicatore punta decisamente in quella direzione.
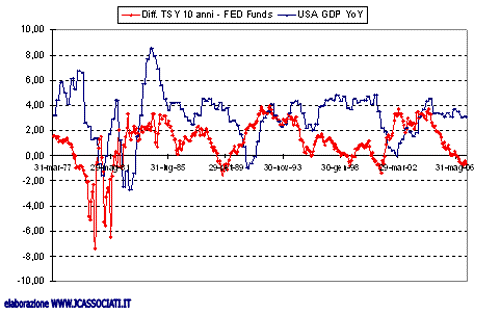
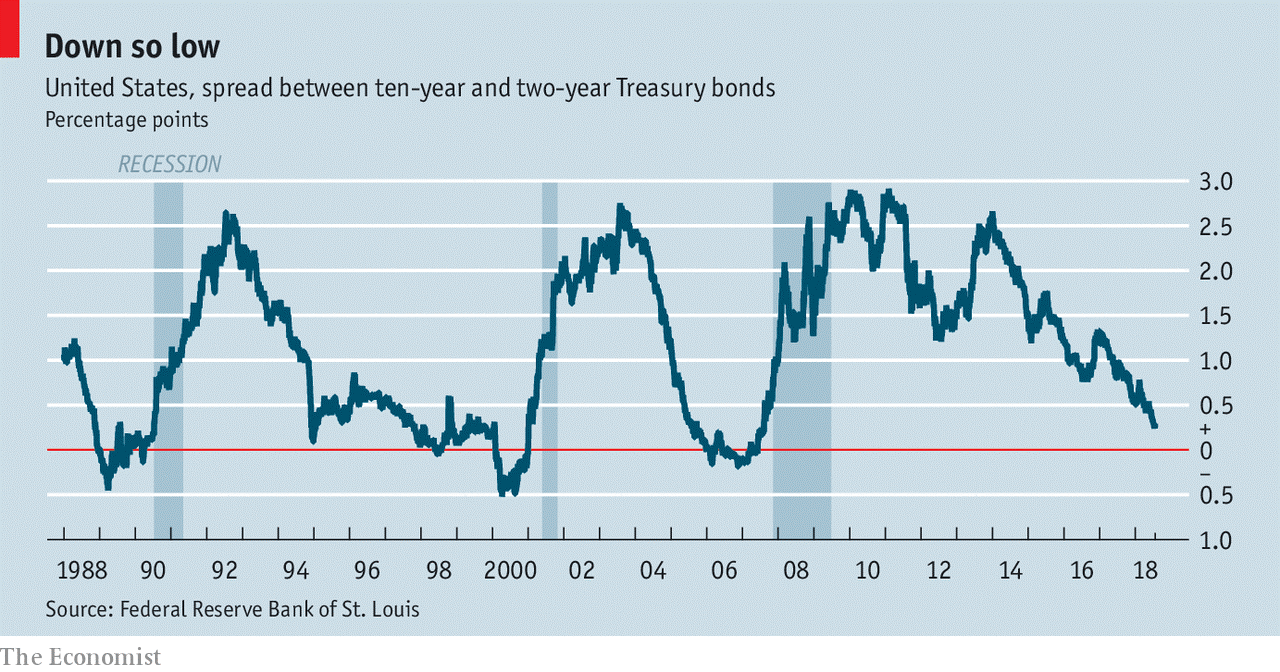

Non a caso l’Economist ha dedicato un numero di ottobre a The next recession (How bad will be?), sottolineando che il prossimo economic downturn è solo questione di tempo. L’ondata di liquidità della FED ha sospinto nel mondo l’emissione da parte delle imprese di enormi quantità di bond in dollari (saliti infatti del 10% ogni anno): sono raddoppiati in Brasile e Messico, triplicati in Sudafrica e Indonesia, quadruplicati in Cile e Argentina, passati da quasi nulla a 450 mld in Cina. Il rafforzamento della divisa USA, parallelo all’esaurimento del QE, rischia allora di aprire pericolosi crinali, essendo i fatturati di queste imprese in moneta locale ed i debiti in dollari. Nel quadro di difficoltà cinesi, instabilità geopolitiche, volatilità delle materie prime, rischio di alcuni debiti pubblici (si segnala proprio l’Italia), questa nuova recessione può allora innescarsi su questi squilibri. E la sua gestione neoliberale sarebbe oggi molto più difficile: non solo per il nuovo clima politico (vedi Trump), ma per diversi problemi di questa stessa gestione, dai tassi prossimi alla zero al debito pubblico intorno al 100% (30 punti sopra la media del 2007).
- Si acuisce quindi la competizione interimperialistica, a partire da un disciplinamento sociale nei diversi poli. Lo sviluppo capitalista si è da tempo organizzato su una dimensione mondiale, non solo con una divisione internazionale della produzione e del lavoro, ma anche con una competizione tra i suoi principali poli. Le tendenze di lungo periodo alla riduzione del saggio di profitto, come alla concentrazione e sovrapproduzione di capitali, sospingono questa competizione. Le crisi e le Grandi Crisi la intensificano, anche in conflitti dispiegati. Questa è la dinamica in corso. Dalla continentalizzazione dei poli imperialisti al disfacimento di una liberalizzazione generalizzata, dalla costruzione di aree di riferimento all’innesco di conflitti commerciali, dalla crescita delle spese militari alla moltiplicazione delle guerre ai confini o negli interstizi delle aree di influenza. Il primo passaggio avviene però nei poli imperialisti: le loro classi dominanti sono infatti spinte a preparare ed organizzare le loro società a questa competizione e ad una sua possibile precipitazione. Viene cioè dispiegato il classico armamentario politico, religioso e culturale per rafforzare le identità collettive, inglobando e inquadrando le proprie diversità interne (a partire, ovviamente, da quelle di classe). Si sviluppano quindi vecchi e nuovi comunitarismi, dallo scontro di civiltà alla retorica dell’uomo qualunque. Primo effetto della precipitazione delle contraddizioni imperialistiche, cioè, è una rinnovata nazionalizzazione delle masse ed una nuova militarizzazione delle società. Nei tre diversi poli questo processo si sviluppa su linee diverse. Negli USA, con una rivendicazione del passato basata anche sulla linea interna del colore (make great America again). In Europa con un rilancio dei diversi sovranismi nazionali, anche per le guerre ai confini (dall’Ucraina alla Libia) e la pressione dei profughi. In Cina con un risveglio dell’orgoglio nazionale sospinto dall’espansione economica, nel quadro di confronti vecchie nuovi nell’area pacifica che sono opportunamente rilanciati dal regime del PCC.
- In ogni caso, non siamo (ancora?) alle soglie di un confitto mondiale. È improbabile che quest’accelerazione precipiti in tempi brevi in un conflitto generalizzato. Nonostante tensioni monetarie e commerciali, nonostante confronti e persino scontri diretti (Balcani, Ucraina e Siria), non c’è ancora una dinamica incipiente di guerra tra poli imperialisti. In primo luogo, le loro proiezioni sono ancora…incerte: gli USA pagano costi e insuccessi del suo complesso militare; la Cina sconta la sua ancora debole sovrastruttura, anche militare; l’Europa le sue divisioni e contrapposizioni (vedi Libia). Poi è ancora in corso la costruzione e la ridefinizione dei diversi blocchi (soprattutto per quanto riguarda una serie di potenze regionali a recente sviluppo, dall’Asia al Sudamerica). Ed infine, c’è il fattore nucleare: il potenziale distruttivo di queste armi è un freno alla generalizzazione dei conflitti, proprio a partire dalla corsa agli armamenti in corso (sono oggi potenze nucleari, oltre a Stati Uniti, Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna e Israele, anche India, Pakistan e Corea del Nord; e potrebbero diventarlo facilmente altre come Arabia Saudita, Corea del Sud, Iran, Giappone, Taiwan, Brasile, Sudafrica, ecc). In questa accelerazione della competizione, è probabile però che si moltiplichino i confronti tra potenze (corsa agli armamenti, anche nucleare; guerre commerciali e monetarie, dispiegamenti militari), in particolare in alcuni quadranti come quello centro-asiatico e pacifico (su cui si affacciano, oltre a Stati Uniti e Cina, diverse altre potenze come India, Russia, Corea del Sud e Giappone). Come è probabile la diffusione di conflitti prolungati nelle aree periferiche ed ai confini delle aree di influenza, anche con un sempre più evidente coinvolgimento delle principali potenze (compresa la Cina). Guerre totali e bastarde (come in Congo, in Libia o in Siria), in cui si intrecciano dinamiche politiche, sociali, religiose, etniche e geopolitiche, con lo schieramento di milizie oltre che di eserciti regolari ed il coinvolgimento diretto di potenze limitrofe, regionali o anche degli stessi imperialismi. In una sorta di Game of thrones di sangue, con fronti e alleanze che si ribaltano continuamente, senza reali baricentri al di là dei precipitanti disequilibri interimperialistici.
- Sono però probabili esplosioni, rivolte e regimi nelle semiperiferie. L’espansione globalizzata della stagione neoliberista ha attraversato prepotentemente le periferie e soprattutto le semiperiferie del mondo, sconvolgendo la loro struttura sociale. Nelle megalopoli che ora costellano questi paesi, un proletariato sradicato e disorganizzato si affianca a ceti medi insicuri e desideranti. Mentre i settori organizzati di classe, con una coscienza più sviluppata e pratiche antagoniste, sono limitati (anche se spesso concentrati). La presenza di questi diversi agglomerati in tensione, per di più spesso senza un baricentro, rende le dinamiche di questi paesi instabili. La Grande Crisi, con i suoi crolli finanziari o produttivi, con le sue fluttuazioni su materie prime e monete, ne ha moltiplicato l’instabilità. La competizione ha spinto settori borghesi verso politiche di sganciamento protezionista (sostenute da movimenti nazionalisti, etnici o religiosi), spesso però non potendo contare su una strategia di accumulazione in grado di sostenerle. Da tutto questo l’innesco di rivolte e movimenti di massa, con il successivo sviluppo di svolte autoritarie, basate proprio sull’organizzazione bonapartista di larghe masse piccolo borghesi e semiproletarie (anche in contrapposizione gli uni con gli altri). È probabile quindi che nella prossima stagione si moltiplichino i grandi movimenti sociali, i movimenti reazionari di massa e anche regimi autoritari, che abbiamo conosciuto in questi anni (Turchia, Pakistan, Egitto, Iran, India, Brasile, ecc). In queste realtà si rinnova quindi un’instabilità rivoluzionaria, difficilmente controllabile anche se spesso tenuta a freno da regimi e movimenti reazionari. Un’instabilità che vede quindi il riprodursi di tensioni ed esplosioni sociali, anche se la scarsa organizzazione di classe (a partire dalla limitatezza dei suoi nuclei operai sino alla confusione del semiproletariato urbano), oltre che la debolezza delle sue direzioni politiche, rende improbabili l’innesco di rotture rivoluzionarie.
- Come sono inevitabili, nel medio periodo, processi di riorganizzazione di classe con il possibile sviluppo di una sua coscienza politica. Nei paesi a capitalismo avanzato, il lavoro sta vivendo l’intensificazione dello sfruttamento, il disciplinamento nei processi produttivi, una scomposizione tecnica e sociale, l’inglobamento in logiche comunitarie. La Grande Crisi ha potenziato questi processi, determinando un arretramento generalizzato ed una marcata involuzione della coscienza di classe. La dinamica in corso non è però un’ineluttabile tendenza progressiva. Certo, questi processi sono reali e profondi. Però possono invertirsi. Anzi, la loro dinamica prevede proprio che nel tempo si invertano. Sia sul piano strutturale, sia su quello soggettivo. In primo luogo, la classe lavoratrice è un prodotto del capitale: quest’ultimo ha necessità non solo di subordinarla, ma anche di riprodurla. Tanto quanto tende a dividerla e scomporla, tende allora anche ad estenderla, ricomporla e riorganizzarla. Ad esempio, la catena di montaggio è stata strumento di controllo e scomposizione dell’organizzazione di classe centrata sugli operai professionali, tanto quanto è stata strumento di amalgama dell’operaio massa. In secondo luogo, la percezione delle diversità di status, i pregiudizi e gli stereotipi socioeconomici, la diffusione di particolari culture di classe, sono processi potenti. Altrettanto potenti di quelli basati sul genere, sull’età o sulla categorizzazione etnica. L’inglobamento comunitario può allora esser contrastato. Le classi subalterne tendono infatti a riconoscersi e differenziarsi, riproponendo nel tempo una consapevolezza diffusa della loro differenza con il padrone, anche se questa differenza può declinarsi in appartenenze politicamente e culturalmente anche molto diverse tra di loro.
- Tutto questo evidenzia problemi nella strategia rivoluzionaria, come la necessità di una prospettiva e di un’organizzazione internazionale. Nel quadro di questa Grande Crisi, nel quadro di un’accelerazione della competizione interimperialistica e di un suo possibile precipitare nella prossima stagione, emerge allora con evidenza la debolezza soggettiva dell’organizzazione di classe e delle sue direzioni rivoluzionarie. In questo contesto, risulta difficile individuare l’anello debole in cui può innescarsi una rottura: in cui l’egemonia delle classi dominanti risulta indebolita dalla crisi, in cui si concentrano nuclei coscienti e combattivi delle classi subalterne, in cui sia presente un soggetto politico in grado di guidare una dinamica rivoluzionaria. In questa fase, infatti, la classe lavoratrice nei paesi a capitalismo avanzato è scomposta e arretrata, in quelli emersi è in formazione e con scarsa coscienza, in quelli della periferia e semiperiferia è spesso limitata e isolata dalle masse (semi)proletarie. Non a caso sono ovunque deboli anche le sue direzioni rivoluzionarie, spesso disorganizzate o marginali sia nel quadro politico del paese, sia nel radicamento nella classe operaia e nel proletariato più diffuso (con pochissime eccezioni). Qui emerge con evidenza la necessità dell’Internazionale. Da una parte, di una prospettiva ed un programma internazionalista, che possa contenere la tendenza a focalizzarsi sulle dinamiche delle proprie formazioni sociali, subendo le curvature di settori di classe per tante ragioni deboli, e quindi a rischio di subire le influenze delle proprie borghesie e dei propri capitali (imperialistici, nei poli di sviluppo; nazionalisti e sovranisti, nelle periferie e nelle semiperiferie). Dall’altra, di un’organizzazione, in grado non solo di analisi e progettazione, ma anche di coordinare strategie ed interventi politici, soprattutto se dovesse nuovamente precipitare la crisi o, anche peggio, dovesse determinarsi un’accelerazione nella contrapposizione tra potenze imperialiste.
- Nell’Unione Europea saranno probabili crisi politiche ed anche istituzionali, difficile una disgregazione, possibili le accelerazioni imperialiste. L’Unione Europea è al centro della Grande Crisi. Non solo ne è stata particolarmente colpita (recessioni e depressioni in diversi paesi, crolli finanziari, insostenibilità debito bancario e per questo problemi su alcuni debiti sovrani), ma ne è stata colpita nel pieno di una lunga e difficile integrazione capitalista.
La dinamica della Grande Crisi è probabile che imprima nuove pressioni sulla UE, con ulteriori crolli finanziari e produttivi, instabilità e conflitti ai confini, possibili guerre in aree fondamentali per le materie prime o il commercio internazionale. In primo luogo, allora, si intensificheranno le tendenze centrifughe, a causa della diversità delle formazioni sociali che compongono l’Unione. Da una parte è debole il capitale continentale, il suo baricentro tedesco è troppo limitato e non si ancora costruito un luogo di composizione tra i diversi capitali nazionali: manca cioè una direzione europea del capitale. Dall’altra sta emergendo una gestione capitalista della crisi neo-nazionalista che salda le classi subalterne, la piccola borghesia e i settori nazionali del capitale in nuovi blocchi reazionari. È allora probabile la riproposizione se non l’estensione di linee di frattura come la Brexit o le sanzioni a Ungheria e Polonia, con governi populisti in diversi stati (anche importanti), conflitti e crisi politico-istituzionali (su bilancio, regole, confini, politiche interne e internazionali), il possibile allentamento o anche smantellamento di alcuni tratti fondati dell’Unione Europea. In questo quadro, rimane molto difficile, se non improbabile, una disgregazione dell’Unione. Proprio la dinamica della Grande Crisi, infatti, intensifica anche la competizione interimperialistica: dalla riproposizione di conflitti commerciali o monetari alla concorrenza tra oligopoli in settori strategici (materie prime; aerospazio; biotecnologie, agricole e sanitarie; ITC; piattaforme commerciali). Con le spinte centrifughe, allora, si intensificano anche le pressioni per sviluppare una protezione continentale in questa competizione: sia dal punto di vista del mercato unico (dazi e regolamenti sulle merci), sia dal punto della moneta unica (con cui segnare, oltre ad un possibile sganciamento dagli altri blocchi, anche una propria area di influenza), sia infine dal punto di vista più strettamente militare (soprattutto a fronte di una corsa agli armamenti non affrontabile separatamente dai diversi imperialismi europei). Nel contempo, la precipitazione di nuove crisi politiche mondiali, la diffusione di esplosioni nelle periferie e nelle semiperiferie, la ripetizione di conflitti ed interventi militari anche più allargati di quelli attuali, potrebbero imprimere improvvise accelerazioni. Potrebbero cioè dare nuovo impulso ai processi di integrazione, con forzature federaliste, l’imposizione di nuovi equilibri o la costruzione di nuovi centri di potere continentali, per confrontarsi con queste crisi e quindi imporre la definizione di un nuovo blocco europeo (anche più ridotto dell’attuale Unione).
- L’Italia è probabile che, nel quadro delle opposte tendenze nella UE, intensifichi le sue contraddizioni territoriali e sociali. Nonostante la retorica politica di questi ultimi anni, nonostante la lunga depressione successiva al 2007-08, l’Italia rimane uno dei principali paesi a capitalismo avanzato. Tra i principali paesi manifatturieri, con esportazioni significative, capitali e imprese di rilevanza mondiale (da Exor a ENI, da Enel a Benetton). La dinamica della Grande Crisi, con le opposte pressioni sull’Unione Europea (centrifughe e federaliste), è probabile che allarghi le linee di faglia del paese. A partire dalle sue differenze territoriali. Il cuore produttivo del paese si concentra nel centro-nord (tra il vecchio triangolo industriale, Mi-To-Ge, e quello nuovo, Mi-Bo-PaTreVe). Mentre il meridione del paese, con qualche limitata eccezione, si conferma periferia sociale del continente. È quindi evidente il rischio di divergenze sempre più accentuate. In questo quadro, appare ad oggi sottovalutata la dinamica sulle autonomie rafforzate avviata da alcune regioni settentrionali, governate dalla Lega e anche dal centrosinistra (referendum in Lombardia e Veneto, a cui sono seguite con percorsi più costituzionali ma eguale determinazione Emilia Romagna, Marche e Toscana). Si rischia infatti di costruire un’impalcatura politico-istituzionale (politiche industriali, fiscali, welfare e mercato del lavoro) in grado non solo di accompagnare ma anche di rilanciare la biforcazione produttiva del paese, nel contesto di possibili crisi politiche ed anche istituzionali dell’Unione Europea determinate proprio dalle pressioni opposte che la crisi determina sulle sue strutture sociali. Allo stesso modo, sembra probabile che nel breve e forse anche nel medio periodo aumentino i processi disgregativi nelle classi subalterne e anche tra i ceti medi, seguendo le linee di frattura che si sono sviluppate in questi anni. Da una parte, tra settori e tipologie di imprese, a seconda della loro connessione (o meno) con le filiere produttive, i circuiti di valorizzazione ed i mercati del continente. Dall’altra, tra le diverse composizioni tecniche e sociali, in relazione alle trasformazioni dei processi lavoratici (età, genere, educazione, professionalità, auto-determinazione e controllo della prestazione, forme contrattuali e quindi anche struttura del salario, compreso le relative protezioni sociali).
- Su queste tensioni si è sviluppata l’egemonia reazionaria di Lega e 5Stelle: una loro intensificazione potrebbe consolidarla anche per una lunga fase. La saldatura tra classi subalterne e movimenti reazionari è cresciuta in questi anni sulla frammentazione dei ceti medi e delle classi subalterne, su una gestione liberale della crisi capitalista che ha divaricato diseguaglianze sociali e territoriali, su politiche economiche e sociali focalizzate sugli interessi del grande capitale europeista. L’insicurezza diffusa e la disorganizzazione di classe hanno infatti favorito la proposta di una diversa gestione della crisi, più centrata sugli interessi e la protezione sociale della comunità nazionale. La stessa dinamica della Grande Crisi, con la radicalizzazione delle sue tensioni e contraddizioni, rischia paradossalmente di stabilizzare questa egemonia reazionaria. Esiste cioè la possibilità che un suo effetto sia quello di favorire lo sviluppo di un regime relativamente stabile, come in altri paesi del centro Europa. Da una parte perché l’instabilità e le insicurezze determinate da nuove precipitazioni (crolli finanziari e produttivi, conflitti commerciali ed estese guerre periferiche), in un quadro di isolamento sociale e divisioni di classe, possono sorreggere soluzioni bonapartiste e autoritarie. Dall’altra perché il potere è anche strumento di costruzione del consenso: anzi, è soprattutto strumento di costruzione del consenso (“il potere logora chi non ce l’ha”). Il governo Lega-5Stelle può quindi realizzare non solo provvedimenti di grande impatto comunicativo (da quota 100 alla legittima difesa, dalla repressione degli zingari al conflitto con la UE sulle politiche di bilancio), ma anche tessere la struttura di un nuovo sistema di regolazione della crisi (autonomie rafforzate e disconnessione morbida dei differenti sistemi produttivi, ricostruzione di una politica protezionista e interventista, compartimentazioni sociali e repressioni per intensificare lo sfruttamento tenendo sotto controllo reazioni e resistenze). Si rischia cioè una lunga stagione in cui il senso comune, ed in particolare il senso comune popolare, prescinda sempre più dai rapporti di classe. Il lavoro rischia cioè di sbiadire, poiché appartenenze e identità collettive, speranze e prospettive di cambiamento, riescono sempre meno a modellarsi nella produzione e nei suoi conflitti, ma sono invece sempre più in-formate nelle nuove contrapposizioni comunitarie promosse dai movimenti reazionari e dal loro governo (popolo contro casta, italiani contro immigrati, Italia contro Ue o contro il resto del mondo).
- Questo governo potrebbe invece esser di breve durata: la saldatura dei movimenti reazionari con le classi subalterne, la loro impronta sul paese, non è però temporanea. Il governo, in ogni caso, non è ancora saldo. Le diversità che esistono tra le due forze ed i due elettorati (in particolare sui diritti civili, la rappresentanza di differenti interessi o territori) potrebbero precipitare la situazione. Come l’inevitabile competizione tra i due soggetti, in particolare in prossimità di appuntamenti elettorali (come le prossime europee), potrebbero spingere a scontri, anche con dinamiche poco controllabili. I rischi per questo governo, però, non sono solo della politica politicante. Da una parte i nodi strutturali che hanno segnato il tentativo bonapartista di Renzi (a partire dalla crisi perdurante ed i limiti delle risorse a disposizione) sono ancora attuali: possono frenare il consolidamento della maggioranza, spingere al conflitto le due forze e in ogni caso logorare il loro consenso di massa (a partire dalla difficoltà di concretizzare le aspettative elettorali e le promesse del contratto di governo). Dall’altra il cambio di gestione capitalista avviene in un clima internazionale ancora incerto, senza un modello compiuto ed in conflitto aperto con l’attuale direzione dell’Unione Europea: la sua implementazione, quindi, oltre che a torsioni e contraddizioni, potrebbe esser soggetta ad uno scontro con Commissione e BCE, senza sufficiente sostegno, che potrebbe portare ad una precipitazione delle cose (a partire dalla legge di bilancio e le sanzioni UE). E, comunque, questa gestione può aprire contraddizioni significative anche nel paese, in particolare con quei settori di grande e medio capitale strettamente connessi al quadro continentale, o focalizzati sulle esportazioni e quindi legati ad un regime di liberalizzazione commerciale. Come, infine, potrebbero diventare ingovernabili le stesse divergenze e frammentazioni che hanno sostenuto la loro crescita, approfondendosi con il procedere della Grande Crisi (soprattutto a fronte di nuove crisi e accelerazioni).
In ogni caso, la stabilizzazione di questi mesi ha lasciato un’impronta profonda. L’assenza di movimenti e di significative resistenze sociali, come il successo nell’affrontare piccole e grandi vicende (dal crollo del Ponte di Genova alla chiusura dell’accordo ILVA), rendono più difficile rompere il senso comune costruito in questi anni (sospinto dalle politiche liberali di Renzi e dall’assenza di lotte di massa). Un senso comune, quindi, che non sarà facile modificare e, soprattutto, che non è linearmente dipendente dalle vicende delle attuali leadership di Lega e 5 Stelle: proprio le evoluzioni che hanno segnato queste forze durante la loro ascesa (da Bossi a Grillo, dalla Raggi a Maroni), hanno mostrato la resilienza della loro penetrazione nelle classi subalterne. Serviranno cioè da una parte lunghi processi di logoramento, in seguito a ripetuti traumi e contraddizioni, dall’altra lo sviluppo di movimenti di massa e cicli di lotta, in grado di rilanciare nuove identificazioni di classe. Una dinamica che rende improbabili immediati cambi di fase, al di là delle vicende del governo (a meno della precipitazione di nuove e improvvisi crolli generali, che possono ovviamente accelerare i processi sociali).
- Negli interstizi dell’egemonia reazionaria e su quel senso comune, nelle tensioni sociali che attraversano il paese, è probabile un consolidamento di forze neofasciste. Lega e 5 Stelle sono due movimenti reazionari di massa che, al di qualche posa retorica e di qualche episodio minore, non sono fascisti. Questi due soggetti politici, cioè, pur avendo un’impostazione comunitarista, la nostalgia di un tempo mai vissuto e mai vivibile (la rappresentazione di una società immaginaria di piccoli produttori), un radicamento sociale in strati diversi della piccola borghesia (urbana o della provincia diffusa, professionale o industriale), una propensione autoritaria di governo, non hanno due elementi fondanti dell’impostazione fascista. Da una parte, non sviluppano un sovversivismo attivo (un processo di aperta contestazione e ribellione contro le istituzioni liberali, la burocrazia e lo Stato), né dal basso né dall’alto (né nella forma popolare della ribellione, né in quella intellettuale dell’arroganza del potere). Dall’altra non hanno un uso organizzato e militante della violenza, contro le istituzioni, gli avversari e le organizzazioni del movimento operaio. Questi movimenti reazionari hanno però diffuso un senso comune autoritario e razzista, legittimando nelle masse e nelle istituzioni idee, comportamenti e atteggiamenti anche direttamente ed esplicitamente fascisti. Di più: in particolare la Lega, ma anche i 5 Stelle, hanno aperto spazi politici ed istituzionali, oltre ad aver offerto sponde se non sostegni diretti, ad organizzazioni e circuiti di matrice esplicitamente fascista. In questa dinamica, parallelamente allo sfondamento politico di questi movimenti reazionari, negli interstizi della loro retorica e del loro potere, si è sviluppata in Italia una destra sociale di carattere esplicitamente neofascista. Casapound, Forza Nuova, Fiamma Tricolore, Lealtà e azione e altri gruppi minori in questi anni si sono radicate in quartieri popolari e classi subalterne, hanno conquistato consiglieri comunali (in particolare Casapound, da Bolzano ad Aosta, da Ostia a Velletri, da Pescia a Vellerano), pur rimanendo complessivamente limitata sul piano politico generale e su quello elettorale (0,95% Casapound; 0,39% FN e Fiamma, per complessivi 437mila voti: in ogni caso un risultato per loro incoraggiante). Una destra sociale che oggi è legittimata ad uscire allo scoperto, organizzarsi, aprire sedi e diffondersi nei territori. Una destra, sovversiva e violenta, una destra neofascista, con una propria base militante organizzata ed inquadrata, che organizza sul territorio ronde e aggressioni, che apre sedi e può ulteriormente crescere sulle polarizzazioni della crisi.
- È probabile si confermi nei prossimi anni il deperimento delle forze riformiste e la frammentazione dei progetti della sinistra politica. Il 4 marzo non ha solo segnato la saldatura tra classi subalterne e movimenti reazionari, ma anche il parallelo sfinimento della sinistra. Le liste in qualche modo a sinistra, dopo la rottura del PD ed il suo profilo renziano, hanno raccolto tutte insieme meno del 5% (circa 1 milione 620mila voti). Solo LeU è entrata in Parlamento e per di più, su 18 parlamentari, solo 5 non sono riconducibili al PD. Non è solo un risultato elettorale. È la conclusione di una parabola, che ha visto la sinistra esser sempre più marginalizzata nella sua rappresentanza, nel suo radicamento e nella sua capacità di iniziativa. In questo quadro, emerge una crescente separazione tra avanguardia politica e dimensione di massa, con l’aggravante che spesso militanti e organizzazioni nemmeno percepiscono questa distanza, né quindi si pongono il problema di colmarla. Avanguardie di sé stesse, qualche decina di migliaia di attivisti non è più in grado di riferirsi ad un proprio popolo, sia dal punto di vista del senso comune, sia dal punto di vista della sua organizzazione. In questo quadro, tendono a collassare tra loro le avanguardie della sinistra storica e quelle dei centri sociali. In questi decenni questi settori si erano frequentati e talvolta intrecciati (autunno 92, Genova 2001, Vicenza 2007), pur mantenendo composizioni diverse (sociali, identitarie e anche anagrafiche), oltre che impianti differenti (i primi centrati su una strategia riformatrice, a partire da un nuovo interventismo pubblico, più o meno in alleanza con la sinistra liberale; i secondi legati a strategie mutualiste e zone temporaneamente autonome dal capitale). Essendo oramai entrambe isolate e sperdute, tendono a intrecciarsi ora più saldamente, aumentando nel contempo la distanza da una dimensione di massa. Non è questo il loro limite principale, quanto la confusione progettuale, che rende qualunque soggetto politico instabile e incapace di darsi una minima prospettiva. Si delineano infatti ipotesi sostanzialmente socialdemocratiche, più o meno richiamantesi alla propria radice laburista o di classe (settori PRC, LeU e SI); tendenze da “nuova sinistra”, legate a nuove soggettività e contraddizioni sociali (di carattere ambientalista o cognitivo, nel PRC ed in SI); percorsi neopopulisti, più o meno centrati sull’ipotesi di riaggregare le classi subalterne intorno alla piccola borghesia professionale proletarizzata e al proletariato urbano disorganizzato, con ipotesi mutualiste o strategie democratiche di ricostruzione del compromesso sociale (settori di pap, benicomunisti, Dema,); strategie di blocco popolare con la piccola borghesia ed il capitale nazionale, in opposizione geopolitica al nucleo capitalista dominante europeo e/o americano (a seconda delle declinazioni, con impostazioni sovraniste o da Alba mediterranea; settori di pap, PC, RdC). E varie declinazioni intermedie tra queste ipotesi (socialdemocratici sovranisti o benicomunisti da nuova sinistra), comunque tutti con una limitata se non nulla base di classe. A lato, sempiterna nella sua azione carsica (con qualche uscita al primo maggio e questo autunno, sorprendentemente, anche dei cortei contro il governo), Lotta comunista. In questo quadro, sembra improbabile non solo che una di queste strategie riesca nel breve termine a coagulare una capacità di intervento o un consenso di massa, ma anche che la loro aggregazione in un “quarto polo” (più o meno a geometrie variabile) sortisca un qualunque effetto (se non quello di aumentare la confusione).
- A sinistra l’unica organizzazione di massa rimasta è la CGIL: è probabile confermi la sua inconcludenza, anche per le tensioni che l’attraversano. Nonostante la lunga stagione neoliberale, nonostante la crisi e gli ultimi anni, il sindacalismo italiano ha una sua forza. In particolare, CGIL CISL e UIL hanno non solo mantenuto, ma incrementato gli iscritti, intrecciando diverse concezioni e funzioni sindacali: contrattazione nei settori (categorie), azione generale sui diritti e la politica economica (concertativa, ma non solo), servizi (CAAF e patronati), pratiche assistenziali di carattere compartecipativo (enti bilaterali, fondi pensione e sanitari, ecc), organizzazione dei pensionati. Le tre confederazioni superano gli undici milioni di iscritti, a cui si affiancano i sindacati autonomi e di destra (Confsal, Cisal, UGL e altri: probabilmente intorno ai 2/3 milioni) e quelli di base (130/150mila, divisi tra i due maggiori USB e CUB, probabilmente dello stesso ordine di grandezza, e la galassia Cobas frammentata in una decina di circuiti). I pensionati sono circa la metà del totale, quindi con un tasso di sindacalizzazione reale intorno al 35% (più forte nel pubblico, dove quasi ovunque ci sono RSU, e nelle imprese medio-grandi, dove in oltre 2/3 ci sono RSU). La CGIL, da sola, rappresenta un terzo di questo universo (intorno ai 5 milioni di iscritti). Due milioni e mezzo sono attivi (oltre 800mila nel commercio e nell’edilizia, dove spesso pesa un rapporto individuale più che l’organizzazione nei posti di lavoro), 18mila i funzionari, oltre 180mila i delegati/e e il gruppo dirigente territoriale.
La CGIL vive da anni una sostanziale inconcludenza strategica, all’inseguimento del grande accordo con il padronato nel quadro della Grande Crisi. Un accordo che non può esser raggiunto e la cui ricerca accompagna continui arretramenti. Da dieci anni assistiamo infatti alla ripetuta ridefinizione delle trincee, che vengono poi abbandonate in una ritirata senza prospettiva. In questo quadro, prima il governo Renzi e poi l’ascesa di un governo reazionario con consenso di massa hanno imballato la CGIL. La rottura del dialogo sociale da parte del governo a guida PD, o la sua attivazione intermittente da parte di quello Lega-5Stelle, ha infatti ulteriormente messo in discussione questa strategia. La Cgil ha reagito provando a mimare il conflitto (dal jobsact ai contratti pubblici), sospendendolo però ogni volta nel vuoto. Poi ha cercato di buttarla in politica, con la Carta dei Diritti ed i Referendum, strada che anch’essa si è interrotta nel vuoto (i referendum per alcune ingenuità CGIL e l’azione del governo, la Carta per l’implausibilità di un suo concreto approdo parlamentare). In questo imballamento, allora, difficilmente la CGIL avrà la volontà e la determinazione sufficiente per innescare una reale dinamica di massa (per paura di perdere), ma nel contempo nessuna subordinazione sarà definitiva (per cercare di mantenere un proprio ruolo, anche solo come burocrazia). In questo imballamento, inoltre, si moltiplicano le pressioni per trasformare la CGIL in sindacato della forza lavoro: cioè il rappresentante di un fattore della produzione che si fa carico non solo della redistribuzione, ma anche della stessa produzione del valore (una concezione “complice” della prassi sindacale la cui forma più cristallina è rappresentata dalla FIM di Bentivogli). Un’impostazione che però confligge con la matrice storica della CGIL: un sindacato generale riformista, con derive burocratiche anche profonde, ma che si propone di rappresentare uomini e donne (il lavoro vivo che è subordinato nei processi di produzione del valore). Un sindacato cioè che si fa carico non solo della redistribuzione, ma anche della difesa dell’autonomia del lavoro e quindi della sua contrapposizione agli interessi del capitale.
L’imballamento strategico e le tensioni fra queste opposte concezioni della prassi sindacale moltiplicano l’incertezza: determinano spinte diverse tra le categorie e nell’organizzazione, contrapposizioni anche nel gruppo dirigente, oscillazioni e strappi, con il rischio anche di strette, svolte e ambiguità, rapidi cambi di impostazione e collocazione. Come la probabilità, in tutto questo movimento contradditorio, di una sostanziale protrarsi di questa immobilità.
16. Nel paese, in ogni caso, proseguono i processi di ristrutturazione produttiva e riorganizzazione di classe. L’Italia ha conosciuto negli ultimi anni processi rilevanti di scomposizione del lavoro e di involuzione della sua coscienza. Una divisione determinata non solo dalle crescenti differenze tra settori, categorie e professionalità, ma anche rilanciata dalle divergenze territoriali del paese. E da scomposizioni e ricomposizioni conseguenti alle ristrutturazioni in corso, a partire dall’automazione e la digitalizzazione. In questo quadro, appare quindi improbabile che nel prossimo periodo si diffondano cicli di lotta e movimenti del lavoro di carattere generale (se non per dinamiche politiche, al momento poco prevedibili). Le lotte cioè tendono, e tenderanno probabilmente ancor di più nei prossimi anni (almeno nel breve periodo), a svilupparsi in forma disarticolata e disparata, con diverse tematiche (salario, orario, sfruttamento), tempistiche, forme di organizzazione, modalità di svolgimento. Anche con identità specifiche e persino territoriali. Nel contempo, è probabile che proprio l’avanzamento delle ristrutturazioni, le riconfigurazioni territoriali dell’apparato produttivo, la formazione di sacche di marginalità circoscritte (di carattere territoriale e/o sociodemografico) determino una nuova organizzazione di classe. Una riorganizzazione in parte già in corso, capace di dare nuovo impulso a nuovi cicli di lotta nella produzione e nei territori. Nei processi produttivi, in particolare, è probabile che i conflitti, al di là delle retoriche sul “nuovo lavoro”, si sviluppino sui tre elementi classici del capitalismo: il salario (non solo la sua quantità, ma la sua struttura: componenti fisse e variabili, dirette e indirette, monetarie e non monetarie), l’orario (non solo la sua durata, ma la sua qualità: giornata di lavoro, straordinari, flessibilità e obbligatorietà), il controllo della prestazione (misurazione, monitoraggio, definizione ed etero-direzione dell’operare e dei suoi ritmi). Nei territori, invece, è probabile che si riconfigurino nuove identità di classe attraverso le identità di luogo (quartieri e zone), in particolare dove questi spazi raccolgono le marginalità sociali strutturali che le riconfigurazioni in corso andranno a produrre. Identità profondamente segnate dalla loro marginalità, dalla loro estraneità sociale e quindi dalla loro diversità rispetto alle classi dominanti, che proprio per il loro definirsi esternamente dalla produzione potranno sviluppare matrici politiche e culturali molto marcate e pervasive, ma non necessariamente antagoniste.
TRACCE: per un cammino comunista e rivoluzionario.
- Tirato qualche conto sul passato e offerto qualche scorcio sulle prospettive, è possibile individuare una strategia per questi tempi nuovi e complicati? Ovviamente, non è da soli che si può rispondere a questa domanda. La definizione di una strategia è infatti frutto di un’esperienza e di un pensiero collettivo. Un percorso politico, infatti, non è determinato semplicemente della capacità teorica di tracciare un quadro e indicare una strada, ma anche della necessità di verificare dinamiche e intuizioni, interagendo quindi con i processi, le persone ed i soggetti sociali che vi sono coinvolti. Allora, la definizione di una strategia politica non può che essere il risultato di una prassi collettiva ed organizzata. A questa definizione, però, ognuno può liberamente contribuire, rilevando i limiti delle strategie precedenti e le dinamiche in corso; provando ad indicare possibili cammini; lasciando quindi delle tracce che possano esser raccolte, rielaborate e infine inserite in un percorso comune.
- Il problema strategico di questa fase storica è la divergenza tra condizioni oggettive e condizioni soggettive di un possibile percorso rivoluzionario. Per condizioni oggettive, si intende qui non solo lo sviluppo di una Grande Crisi (il crollo del consenso delle classi dominanti, la messa in discussione dei loro strumenti di regolazione, la debilitazione della loro egemonia), ma anche la necessità di una transizione ad un nuovo modo di produzione, per evitare la possibile precipitazione in una barbarie dispiegata (una guerra generalizzata o il rapido succedersi di diverse gestioni capitalistiche della crisi, autoritarie e/o repressive). Per condizioni soggettive, si intende qui non solo la diffusa debolezza delle organizzazioni rivoluzionarie (a fronte delle passate egemonie socialdemocratiche, staliniste o nazional-popolari), ma anche la stessa disorganizzazione della classe (che nelle diverse aree del mondo si presenta isolata, scomposta o immatura). La contraddizione tra la necessità, e persino l’urgenza, dell’azione rivoluzionaria e l’impreparazione delle forze politiche e sociali che dovrebbero condurla, diventa quindi sempre più evidente e bruciante.
- Questa divergenza interessa, con forme diverse, l’intero quadro mondiale. Anche per questo è difficile da contrastare e, anzi, facilita esperienze eterogenee e confusive. Per i processi ineguali e combinati che abbiamo visto, ovunque scarseggiano le dinamiche rivoluzionarie in grado di ergersi a punto di riferimento. Mancano cioè nel mondo grandi movimenti di massa o rotture esemplari, in grado di diventare un fattore di riorganizzazione politica della classe e al tempo stesso di accelerazione della dinamica rivoluzionaria. Al contrario, ad emergere negli ultimi anni sono state esperienze eterogenee, che hanno spesso intrecciato confuse aspettative di trasformazione sociale con impostazioni democratiche, nazionaliste o addirittura reazionarie. Pensiamo alle particolari amalgame che si sono sviluppate nel Venezuela di Chavez e Maduro (propensione antimperialista, nazionalismo autoritario, vaghissime idee di socialismo e comunitarismo sociale) o nel Rojava siriano (strategia neo-maoista da zone temporaneamente liberate, impostazioni comunaliste, istanze democratiche, radicalismo femminista, riforma agraria e illusione di un mercato regolato basato sulla piccola impresa); nelle piazze catalane (nazionalismo democratico e resistenza all’austerità europea) o nei movimenti zapatisti (zone temporaneamente liberate, comunitarismo democratico, fronte interetnico dei gruppi marginali); nel governo comunista nepalese (impostazioni maoiste di accerchiamento urbano e strategie togliattiane da riforma di struttura nel quadro di una costituzione democratica) o nelle rivoluzioni magrebine (resistenze operaie, istanze del proletariato urbano spossessato, rivendicazioni democratiche della piccola borghesia urbana, fondamentalismo religioso nazionalista ed antimperialista); nelle resistenze iraniane (propensioni democratico-liberali, lotte economiche della classe operaia petrolifera e dei trasporti, istanze di liberazione di donne e studenti) o nel governo Tsipras (rivolta contro l’austerità e riforma del sistema europeo); nelle piazze brasiliane (resistenza contro le politiche liberiste di Roussef e aspettative sociali della media borghesia urbana) o in quelle turche (istanze democratiche, antifondamentaliste ed ecologiste; nazionalismo kurdo democratico o strategie da zone liberate urbane represse nel sangue; resistenze operaie); nelle lotte sociali in Cina (resistenze e antagonismi economici operai; movimenti di difesa del proprio ambiente o della qualità dei consumi) o in quelle di nonunadimenos in Argentina (rivendicazioni classiste, propensioni altermondialiste, istanze progressiste e differenzialiste). Nei grandi movimenti di questi anni, cioè, non solo si sono sfumate identità e coscienze di classe (in questi paesi come negli immaginari internazionali), ma è spesso anche prevalsa una strategia da fronte popolare (in questi paesi come negli immaginari internazionali): lo sviluppo, talvolta in funzione antiimperialista, di zone liberate o governi democratico-popolari in alleanza con settori di più o meno piccolo capitale. Nel quadro di una Grande Crisi e quindi della possibile prossima precipitazione di conflitti interimperialistici, si è cioè pericolosamente accompagnato se non accelerato l’occultamento della faglia di classe tra lavoro e capitale, rischiando conseguentemente di occultare quella prospettiva internazionalista che proprio oggi è tanto più necessaria.
- È un mondo difficile. È vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Serve un centro di gravità permanente: l’autonomia di classe. In questa realtà contraddittoria, la priorità strategica è allora quella di cogliere, sostenere e generalizzare l’organizzazione e la coscienza di classe. Diventa cioè fondamentale non solo conquistare programmaticamente l’avanguardia (il lavoro più concentrato e strutturato, la cosiddetta classe operaia centrale; le aree più consapevoli, gli attivisti e i delegati/e di ogni settore; i nuclei combattivi, anche in settori marginali o isolati), ma contribuire a formare questa stessa avanguardia, oggi troppo spesso immatura, involuta od isolata (a seconda dei contesti). La priorità diventa cioè quella di sviluppare non solo propaganda e agitazione, ma anche radicamento e strutturazione nella classe, per contribuire allo sviluppo della sua autonomia e del suo antagonismo. Consapevoli che questo impegno non avviene nel corso di una lunga onda espansiva (che facilita le conquiste del lavoro) o di una lunga onda recessiva (che stimola resistenze), ma nel pieno di una Grande Crisi (che determina accelerazioni e involuzioni, esplosioni e arretramenti). Abbiamo cioè il problema di dover strutturare i nostri reparti (involuti, isolati o immaturi) proprio nel corso di una fase di grande movimento e quindi di rapidi cambiamenti sociali. In una stagione cioè in cui il tempo potrà improvvisamente dilatarsi, con salti di qualità ma anche repentine devastazioni (sociali, politiche e militari). Per questo, sarà utile adottare la strategia della zecca. Imparare cioè a muoversi su due tempi e due cicli di vita, a seconda del contesto. Da una parte, sviluppando le antenne per cogliere i repentini cambiamenti nel ritmo e nelle dinamiche della crisi (a livello economico, come a livello sociale e politico). Dall’altra, trovando dentro di sé la forza di tenere connessi i due tempi, per riuscire a staccarsi con velocità dal proprio albero e sapersi incollare con testardaggine alle nuove dinamiche, quando arriva il momento di farlo. Fuor di metafora. Da una parte la necessità oggi è di sviluppare con molta più consapevolezza il proprio radicamento nella classe, l’osservazione della crisi, i suoi ritmi e le conseguenti trasformazioni sociali, sapendo opportunamente modulare parole d’ordine e modalità di intervento: sapendo cioè sviluppare una nuova attenzione alla tattica ed alle sue variazioni. Dall’altra, proprio per questo, serve un baricentro, un centro di gravitazione in grado di tenere insieme i due tempi, sapendosi muovere nell’uno in funzione dell’altro, senza smarrirsi nell’impegno quotidiano di sviluppo della coscienza e dell’organizzazione di classe. Questo baricentro, radicato nei due tempi e in grado di tenerli insieme, non può che esser la radicale consapevolezza dell’autonomia di classe. Da una parte, l’autonomia di classe è indipendenza dal capitale del lavoro vivo, che permette proprio nei processi produttivi di sviluppare sempre nuove resistenze, e che quindi offre sempre nuova linfa allo sviluppo del conflitto sociale e alla coscienza di questo conflitto. Dall’altro, l’autonomia di classe è indipendenza politica del lavoro, che permette di sviluppare sino in fondo il suo antagonismo con il capitale: la costruzione cioè di un nuovo modo di produzione basato sul lavoro associato, attraverso la conquista del potere per gestire la transizione. Sostenere l’autonomia di classe, in entrambe questi aspetti, contribuisce cioè a organizzare il lavoro anche in vista di possibili precipitazioni. Questo sostegno deve quotidianamente confrontarsi con tendenze economiciste (cioè la semplice difesa di salario, orario e controllo della prestazione) o riformiste (cioè l’opportunità di costruire compromessi, sistemi di regolazione e protezione a spese di una parte dei profitti). Tale tendenze sono insite nell’antagonismo del lavoro, in ogni spazio ed in ogni tempo. In una fase di Grande Crisi, però, sono oggettivamente indebolite ed anche per questo è possibile sviluppare più rapidamente l’autonomia sociale e politica della classe. In questo quadro, tanto più in questa stagione, diventa allora fondamentale la parola d’ordine del governo dei lavoratori e delle lavoratrici, in un’ottica transitoria e non di riforma del sistema, che deve quindi diventare asse e baricentro dell’intervento di massa.
- In questo mondo difficile ed ineguale, è anche fondamentale riprendere e sviluppare un percorso per la rifondazione della quarta internazionale. La dinamica ineguale e combinata della crisi, come la disorganizzazione ineguale e combinata della classe, proprio in una fase di crescenti contraddizioni imperialistiche rischia infatti di sostenere percorsi e movimenti nazionalisti, come l’illusione di possibili sganciamenti dai mercati mondiali. Tendenze, immaginari e strategie che possono facilmente prender piede anche nella classe, nelle sue avanguardie, in organizzazioni centriste e persino (involontariamente) in correnti rivoluzionarie. Proprio in una fase di Grande Crisi e di possibili conflitti mondiali, cioè, per portare avanti la strategia della zecca (lo sviluppo dell’autonomia di classe nei due tempi della crisi) è fondamentale non solo uno spirito internazionalista, ma la costruzione di una vera e propria organizzazione internazionale. Un’organizzazione centralizzata e democratica, non un semplice coordinamento o una concentrazione di diverse forze, che tramite il suo dibattito e la sua azione possa contrastare tendenze ed adattamenti nazionali, che in questa stagione diventano ogni giorno più forti. Un’internazionale centralista e democratica, come un partito, non è costituita sulla condivisione di un’analisi, di una posizione o di una collocazione, e nemmeno su un comune metodo di costruzione: è costruita invece su un programma. Per questo parliamo di Quarta internazionale. Non per attaccamento ad un particolare nome o una specifica tradizione (che nel processo rivoluzionario è probabile vengano in ogni caso superati, a fronte di nuove vicende e raggruppamenti che si determineranno). Ora però il riferimento è inevitabilmente alla Quarta, proprio per indicare un programma: la rivoluzione, cioè la conquista del potere politico per guidare la transizione ad un diversi modo di produzione, basato sul lavoro cooperativo, attraverso la socializzazione dei mezzi di produzione (socialismo); la dittatura del proletariato, cioè l’utilizzo della forza per garantire la transizione ad un nuovo modo di produzione, difendendo il processo rivoluzionario dalle attuali classi dominanti; la democrazia consiliare, cioè la convinzione che sia il processo rivoluzionario sia la dittatura del proletariato devono esser costruiti in stretta connessione con la classe, non solipsisticamente dal partito (per evitare avanguardismi e degenerazioni burocratiche); la rivoluzione permanente, cioè la necessità, in una dinamica diseguale e combinata, da una parte di avviare un processo di transizione ininterrotto (senza tappe democratiche o accordi interclassisti), dall’altra di condurlo internazionalmente (in quanto tutte le formazioni sociali sono comunque sussunte nel sistema capitalistico mondiale).
Oggi però il panorama dell’avanguardia rivoluzionaria è segnato dalla frammentazione. Una scomposizione politica che si è sviluppata nel corso della precedente onda lunga, nel quadro della persistente egemonia socialdemocratica e stalinista sulle classi subalterne. E che oggi, dopo il tramonto di queste egemonie, è rilanciata dalle divergenze tra i conflitti di classe nelle diverse aree del mondo. Un panorama quindi che è segnato da internazionali-frazione (costruite su specifici analisi e posizionamenti, spesso intorno ad un partito centrale), da internazionali-contenitori di programmi diversi, da strutture di semplice coordinamento, o anche da singoli soggetti isolati che, evolvendo verso posizioni rivoluzionarie negli ultimi decenni, non hanno però rapporto con le tradizioni e le esperienze della quarta internazionale. In questo quadro, si conferma quindi l’urgenza di riavviare processi di raggruppamento su base programmatica, nonostante l’esperienza negativa del CRQI. Un processo di raggruppamento che, al di là di appelli, incontri e conferenze, potrà esser concretamente rilanciato solo dalle dinamiche della lotta di classe internazionale e dei conflitti interimperialistici. Eventi ed episodi che, per la loro portata e la loro influenza, sono cioè in grado di produrre momenti di rottura e conseguente ridislocazione delle attuali composizioni organizzative, segnando nuove demarcazioni e quindi anche ricomposizioni dell’avanguardia rivoluzionaria. Così in parte è stato negli scorsi anni (pensiamo al regime di Chavez, al governo Tsipras o alla guerra siriana). Così è probabile che si ripeta, con l’acuirsi ed il precipitare della competizione interimperialistica, con l’approfondirsi della Grande Crisi. Intorno a questi eventi e a queste possibili riconfigurazioni sarà quindi fondamentale sviluppare un impegno internazionalista, volto a riavviare questo processo di raggruppamento per la rifondazione della quarta internazionale.
- In Italia. Le fascine ci sono, ma sono fradice: bisogna allora in primo luogo tornare a seccarle. La divergenza fra condizioni soggettive e condizioni oggettive in questo paese è particolarmente evidente. È proprio l’arretramento e la disorganizzazione del lavoro che ha permesso un’egemonia reazionaria sulle classi subalterne, stabilizzando la situazione politica e sociale. Nonostante questo, come abbiamo visto le tensioni sulla struttura sociale e produttiva del paese sono evidenti ed anzi rischiano di esser accentuate con l’avanzare della Grande Crisi. In particolare, con la prospettiva di una prossima recessione con relativi crolli finanziari, di cui proprio l’Italia ed il suo debito pubblico potrebbe esser una protagonista mondiale. Allora proprio in questo paese è utile adottare la strategia della zecca. Proprio in questo paese diventa centrale focalizzarsi sul sostegno e lo sviluppo dell’autonomia di classe. Se le fascine delle contraddizioni continuano ad accumularsi, il problema è che la perdita dell’identità e dell’organizzazione di classe le rende fradice, disinnescando in partenza la possibile generalizzazione del conflitto. Non essendo più automatico l’innesco e la diffusione del fuoco, più che soffiare sulla fiamma per indirizzarla (propaganda per l’avanguardia e demarcazione) è allora fondamentale asciugare quella legna e prepararne l’innesco, dare forma ad un antagonismo di classe fluido o disgregato (propaganda e radicamento di massa). Non si tratta più di radicalizzare un “popolo di sinistra” politicizzato (che ha cioè inscritto nel suo senso comune, nelle sue rappresentazioni sociali e nel suo immaginario, per quanto confusamente, la consapevolezza dell’antagonismo degli interessi di classe e la propensione a cambiare lo stato di cose esistenti). Perché questo popolo di sinistra non solo si è molto ridotto nei numeri, ma è sostanzialmente in via de(s)composizione (avendo progressivamente smarrito le sue ragioni costitutive). In questo passo indietro, si può quindi confrontarsi anche con alcuni limiti della strategia precedente, a partire dalla cura dell’innesco, la strutturazione e l’organizzazione dell’avanguardia rivoluzionaria nella classe.
- Un baricentro ed una linea di massa. Il processo di progressiva de(s)composizione del popolo di sinistra, con l’involuzione della coscienza di massa e lo sviluppo di un’egemonia reazionaria sulle classi subalterne, ha determinato anche una più generale separazione tra l’avanguardia politica e la grande parte della classe. Oggi, sempre più spesso, le avanguardie larghe della sinistra politica e sociale sono isolate, non rappresentando più sentimenti e rivendicazioni della dimensione sociale di cui dovrebbero esser espressione. Spesso, avendo anche avendo smarrito la stessa capacità di parlare e collegarsi con questa dimensione. Sono cioè sempre più spesso avanguardie di sé stesse: se ancora talvolta le piazze si riempiono con qualche migliaia o decina di migliaia di persone, spesso queste persone non colgono più un senso comune e una dimensione di massa alle proprie spalle. Con l’aggravante che le organizzazioni dell’avanguardia, oggi, tendono a percepire neppure la distanza dalla massa né si pongono il problema di colmarla. Non a caso, proprio in questa avanguardia larga, tendono oggi a consolidarsi o addirittura a crescere movimenti identitari e settari, fortemente strutturati se non stalinisti, come Lotta Comunista o il PC di Rizzo. Per noi, invece, rimane centrale ricostruire una dinamica di massa. Per due ragioni di fondo. In primo luogo, come ha ricordato la risoluzione politica dell’ultimo CC (novembre 2018), “l’avvio e lo sviluppo di un’opposizione sociale a questo governo, infatti, sono la condizione principale per la rottura del consolidamento reazionario in corso: questo deve essere quindi l’obbiettivo primario del partito in questa fase…Il sostegno e la nostra diretta partecipazione a tutte le lotte (anche quelle parziali), il loro sviluppo e la loro generalizzazione, la costruzione di una piattaforma generale a partire da lotte parziali e al tempo stesso propaganda della lotta generale attorno ad una proposta di piattaforma sono gli elementi combinati della nostra politica di massa nella classe”. In secondo luogo, perché l’autonomia di classe, baricentro e centro di gravità permanente di un’azione rivoluzionaria in questa nuova fase, non matura nei processi politici dell’avanguardia, ma si sviluppa dal conflitto nei processi di lavoro. È nello scontro quotidiano tra gli opposti interessi di classe che si ricostruisce una coscienza di massa: nel passaggio da un antagonismo informe (talvolta individuale) ad una resistenza collettiva, da una resistenza collettiva ad una lotta organizzata, da una lotta organizzata ad una contestazione sociale, da una contestazione sociale ad una prospettiva rivoluzionaria. L’obbiettivo prioritario dell’intervento, cioè, deve esser oggi quello del riconoscimento dello sfruttamento, della propria indipendenza dal capitale e quindi della necessità di una rottura sociale, di un cambio del modo di produzione. Un processo che avviene non solo con la propaganda, ma soprattutto nell’agitazione: cioè nell’esperienza della lotta, in cui si chiarisce nella prassi la differenza di interessi con il padrone, ma anche la forza della collettività. E nella prassi, soprattutto, spesso questi passaggi possono anche condensarsi (nelle vittorie come anche in alcune sconfitte, se sono riconosciute e gestite collettivamente).
- La moltitudine del lavoro: ricomporre un blocco anticapitalista intorno all’autonomia di classe. La lunga transizione e la successiva Grande Crisi hanno scomposto e frammentato le classi subalterne del nostro paese, come i ceti medi della piccola borghesia impiegatizia, professionale e commerciale. È proprio grazie a questa disgregazione che i movimenti reazionari e i loro immaginari comunitaristi hanno saputo incrociare un sentimento di massa, la crescente domanda di sicurezza e protezione sociale. Questa frammentazione ha interessato la stessa classe operaia centrale: linee di faglia sempre più evidenti si sono aperte tra stabilimenti, aziende, categorie e territori. Una strategia di sostegno allo sviluppo dell’autonomia di classe, a partire dall’innesco ed alla generalizzazione delle lotte, deve quindi porsi l’obbiettivo di ricostruire collegamenti e ricomposizioni tra questi diversi frammenti.
Negli ultimi vent’anni, in Italia e non solo, intorno alle esperienze disobbedienti, ai social forum, ai movimenti noglobal, si è accompagnata questa frammentazione con l’ipotesi di tessere un fronte delle diverse soggettività. Infatti, secondo questa impostazione teorica, in una società dove la produzione del valore è generata dalla conoscenza e dalla socialità, dove il potere si regge su un semplice atto impositivo e non su una struttura produttiva, tutte le soggettività ed i movimenti che si creano sono potenzialmente antagonisti. Per innescare una trasformazione, allora, è sufficiente connetterli, anche episodicamente: nel momento in cui rompono il comando gerarchico “del capitale” (sostanzialmente identificato con la grande finanza e la repressione), è la loro stessa dinamica che libera la capacità di costruire un’altra società, basata sull’auto valorizzazione cognitiva e la redistribuzione della ricchezza (salario sociale). Questo particolare impianto teorico (di impostazione sostanzialmente negriana), che ritiene superato dallo stesso sviluppo capitalista lo sfruttamento nei processi del lavoro, è diventato quindi egemone in larghi settori dei movimenti sociali. L’ipotesi strategica di organizzare una sola moltitudine è diventata cioè senso comune nei movimenti di lotta. Per certi versi, ha trovato un nuovo senso il vecchio adagio di Eduard Bernstein “il movimento è tutto, il fine è nulla”. Peggio, si è vissuto questo adagio senza più tenere in considerazione l’opposizione tra capitale e lavoro. Ci si è quindi abituati ad accompagnare movimenti interclassisti ed eterogenei, considerandoli in sé antagonisti, senza saper riconoscere e diffondere i conflitti nella produzione. Una dinamica che, con l’esplosione della Grande Crisi, ha costruito il ventre molle per lo sviluppo di un’egemonia reazionaria, avendo deteriorato le discriminanti di classe a persino nell’ampia avanguardia sociale.
L’intervento politico di massa deve allora sempre più oggi focalizzarsi sui conflitti che si sviluppano nei processi di produzione. L’obbiettivo, cioè, è quello di riconoscere, sostenere e connettere la moltitudine del lavoro. In primo luogo, contrastando sul piano teorico e su quello della propaganda le rappresentazioni, gli immaginari ed il senso comune che si è consolidato in questi anni. In secondo luogo, sostenendo la ricomposizione dei suoi diversi frammenti. Come abbiamo visto, la moltitudine del lavoro è oggi sconnessa tra una classe operaia centrale al nord diffusa in piccole-medie imprese disperse sul territorio, nel sud concentrata in grandi stabilimenti isolati; un proletariato generico disorganizzato, giovane e non, con alta formazione o bassa scolarizzazione; un lavoro migrante mobile, nel paese e non solo; dipendenti pubblici e assimilati (talvolta soggetti a circuiti di valorizzazione); settori socialmente o territorialmente marginali (nuove periferie e aree senza sviluppo economico). In questa frammentazione, cioè, le divisioni sociali si intrecciano con le differenze territoriali: tra nord e sud, tra metropoli e tessuto urbano diffuso, tra aree connesse alle filiere del valore e territori isolati. Il riconoscimento ed il sostegno ai diversi conflitti del lavoro, allora, partendo dalle particolarità (le condizioni contrattuali dei riders urbani; il controllo di salario, tempi e ritmi nelle imprese diffuse del nord e isolate al sud; l’aziendalizzazione del lavoro pubblico; la disoccupazione strutturale; le sperequazioni di genere concentrate in alcuni territori o età), deve riuscire a riportarle al conflitto più generale tra capitale e lavoro. Bisogna cioè sforzarsi di tessere i fili di un nuovo blocco sociale, in grado di riconnettere intorno all’autonomia del lavoro queste diverse composizioni di classe. Anche la definizione di parole d’ordine ed i relativi materiali dell’intervento devono quindi concentrarsi su questo sforzo. Ad esempio, in questi anni abbiamo definito la parola d’ordine di fase sul governo dei lavoratori. È possibile trovare oggi formulazioni più comprensive, che oltre alla fondamentale questione di genere (governino lavoratori e lavoratrici), siano anche capaci di rivolgersi alle diverse articolazioni della moltitudine del lavoro? (Ad esempio, “Che se vadano tutti/e! Governino lavoratori e lavoratrici: operai, impiegati, precari e disoccupati”).
- Il fronte unico ed i suoi problemi. La costruzione di un movimento del lavoro si è spesso tradotta, dal punto di vista delle indicazioni di lotta, nella parola d’ordine del fronte unico di classe. Il fronte unico, infatti, non è mai stata una politica rivolta semplicemente alle organizzazioni dell’estrema sinistra: cioè non è mai stato un intervento diretto all’avanguardia militante e a quella larga degli attivisti sociali (oggi, l’insieme della sinistra sindacale in CGIL e nei sindacati di base, partiti e movimenti della sinistra, centri sociali, collettivi ed associazioni diffuse). Il fronte unico, invece, è una politica che si propone di organizzare e mobilitare l’insieme di tutta la classe: si propone cioè l’unità del lavoro. Per ottenere questo risultato, questa politica è in primo luogo rivolta alle organizzazioni di massa: partiti, sindacati e associazioni che sono radicate tra i lavoratori e le lavoratrici. Per questo, storicamente, la politica di fronte unico si è sempre rivolta alle organizzazioni riformiste e socialdemocratiche, come anche a quelle di matrice stalinista, che avevano questo radicamento. Con l’involuzione delle lotte e della coscienza di classe, con la de(s)composizione del popolo di sinistra, con la crisi di larga parte delle organizzazioni sociali che fanno riferimento alla sinistra politica, si è però radicalmente indebolita la capacità di iniziativa delle organizzazioni di massa del movimento operaio, che costituivano sino ad oggi il riferimento principale di una politica di fronte unico. La CGIL, l’unica organizzazione oggi sopravvissuta con queste caratteristiche, è paralizzata dalle tensioni che l’attraversano (non solo quelle burocratiche, ma quelle tra sindacalismo della forza lavoro e sindacalismo del lavoro). Il problema da porsi è allora quello di quale senso, concretezza e credibilità può avere una politica di fronte unico, quando non esistono più soggetti di massa, la reazione ha egemonia sulla classe e la CGIL è paralizzata. Da una parte, rimane utile dal punto di vista propagandistico, come sottolineava la risoluzione del CC del marzo 2018: “per stimolare dinamiche di lotta generalizzata, ma soprattutto per contrastare le derive di un avanguardismo diffuso e della crescente incomprensione dei processi di massa che si sta affermando nell’avanguardia larga. Una linea di fronte unico che deve cioè esser diretta anche alla critica del settarismo diffuso nell’estrema sinistra sociale e politica, come della riproposizione di appunti di lotta programmatici di autorappresentazione”. Ed in particolare, in questo quadro, è fondamentale sviluppare un’iniziativa di propaganda contro l’immobilismo della CGIL, contro la sua incapacità di riattivare un’opposizione di massa. Dall’altra, però, è fondamentale sviluppare un’iniziativa ed un intervento di massa in grado di prescindere da questa attivazione della CGIL, dall’eventuale e ad oggi improbabile riattivazione di un fronte unico di classe.
- Autonomia di classe, metodo transitorio e tendenze di movimento. A fronte della de(s)composizione del popolo di sinistra, dei problemi nel fronte unico, dell’isolamento dell’avanguardia larga, diventa allora fondamentale sviluppare tattiche e metodologie di intervento che permettano comunque di intervenire in una dimensione di massa, per sostenere lo sviluppo dell’autonomia di classe. Uno dei compiti di questa fase è quindi quello di cogliere le dinamiche oggettive di ricomposizione, raccogliere substrati e connettere rappresentazioni collettive, per rilanciare lo sviluppo di una nuova coscienza di classe e la sua politicizzazione. Per riuscire a portare avanti questa strategia della zecca, per sforzarsi di tenere insieme i due tempi della crisi, ed in ogni caso per facilitare il rapporto tra lotte quotidiane e prospettiva rivoluzionaria, è importante utilizzare un metodo transitorio. In un contesto di involuzione della coscienza di massa, disorganizzazione di classe e indebolimento delle sue strutture politiche e sindacali, cioè, diventa ancora più importante saper definire obbiettivi e parole d’ordine transitorie, intorno a cui cercare di collegare, agglutinare, organizzare lotte e mobilitazioni sociali. Cosa si intende per parole d’ordine e obbiettivi transitori? Con questa espressione si intendono degli elementi programmatici, in grado di raccogliere il senso comune e di proiettarlo su rivendicazioni non soddisfabili entro il quadro politico dato: transitorie, quindi, proprio perché pongono e sospingono l’esigenza di una rottura sociale. Elementi di vita e lotta quotidiana che diventano quindi una leva per il riconoscimento dell’antagonismo sociale e nel contempo per indicare la prospettiva di una trasformazione di sistema. Come richiamato nel Programma di Transizione del 1938 (L’agonia del capitalismo e i compiti della IV Internazionale. La mobilizzazione delle masse attorno al Programma di Transizione in preparazione della conquista del potere) “Il compito strategico della IV Internazionale non consiste nel riformare il capitalismo, bensì nel rovesciarlo. Il suo fine politico è la conquista del potere da parte del proletariato per assicurare l’espropriazione della borghesia. l’assolvimento di questo compito strategico è impensabile senza la massima attenzione per tutte le questioni di tattica, anche minute e parziali. Tutti i settori del proletariato, tutti i suoi strati, le sue categorie e i suoi gruppi devono essere trascinati nel movimento rivoluzionario. Quello che contraddistingue l’epoca attuale non è un affrancamento del partito rivoluzionario dal prosaico lavoro di tutti i giorni, ma il fatto che questa lotta può essere condotta in connessione indissolubile con i compiti della rivoluzione”.
Il carattere transitorio o meno di una rivendicazione parziale, un obbiettivo o una parola d’ordine, è sempre legato alle condizioni ed alla dinamica della fase. Quello che è transitorio in un dato momento, infatti, può esser riformista in un altro contesto e troppo avanzato in un altro ancora: pensiamo alle parole d’ordine del 1917 (pane, pace, terra!), che acquisivano un valore transitorio e rivoluzionario proprio in quello specifico momento e contesto, segnato dalla prima guerra mondiale. Certo, gli elementi cardine del programma sono oggi gli stessi del 1938, perché il sistema capitalistico si regge sulle stesse contraddizioni di fondo: la scala mobile dei salari e dell’orario di lavoro; lo sviluppo dell’autorganizzazione, oltre i limiti e le derive burocratiche delle organizzazioni sindacali; il controllo operaio sulla prestazione e sui processi produttivi; l’espropriazione delle banche e delle imprese strategiche, parassitarie o in crisi, senza indennizzo e sotto controllo dei lavoratori e delle lavoratrici; l’autorganizzazione militante del lavoro per difendersi contro fascisti e repressione; l’azione contro la guerra e le politiche imperialiste. Il nostro sforzo allora deve esser oggi diretto soprattutto all’elaborazione ed articolazione di queste parole d’ordine, a livello generale e nei diversi settori, in grado di cogliere, interconnettere e collegare le resistenze disperse. Cioè connettere nelle piattaforme, nelle parole d’ordine, nella propaganda i diversi cicli di lotta e le diverse soggettività del lavoro. Ad esempio, pensiamo alla riduzione dell’orario di lavoro: oggi acquista nuova centralità e rilevanza nella forma di una redistribuzione del lavoro, non solo tra chi non ce lo ha e chi ce lo ha, ma anche tra chi ce l’ha troppo poco (pensiamo ai tanti part time involontari nel commercio, nella distribuzione, nel terziario) e chi ne ha troppo (pensiamo agli straordinari obbligatori ed i sabati lavorativi, i 21 turni e gli orari prolungati nell’industria). Così, si può cercare di ricomporre la moltitudine del lavoro introno all’obbiettivo della scala mobile dell’orario, cioè una redistribuzione del tempo di lavoro a 32 ore per tutti a salario pieno.
Tanto più a fronte della problematicità del fronte unico e dell’involuzione della coscienza politica diffusa, questo intervento per l’autonomia di classe può e deve esser sviluppato attraverso la costruzione di tendenze programmatiche, intorno a questi obbiettivi e queste parole d’ordine transitorie. Come riporta il documento politico dell’ultimo congresso del PCL (gennaio 2017), “tendenze classiste e anticapitaliste che, nei diversi ambiti, mirano a raggruppare le avanguardie che condividono la sostanza del programma transitorio nella sua articolazione di settore”. Tendenze che devono seguire “una logica di massa, mirata alla conquista della maggioranza, estranea ad ogni riflesso minoritario e settario. In questo quadro, la costruzione di tendenze classiste e anticapitaliste nei diversi settori di intervento è parte costitutiva della lotta per la conquista dell’egemonia alternativa del programma rivoluzionario tra le masse”. Tendenze che, quindi, in alcuni settori e realtà possono esser costruite anche congiuntamente con altre organizzazioni e soggetti del movimento operaio, che condividano le nostre stesse impostazioni classiste e internazionaliste. Come indicato nel gennaio 2015 dai compagni Scacchi e Grisolia, in un documento per il seminario nazionale dell’OpposizioneCGIL (Crisi, autonomia e sindacato: un contributo per una prospettiva di classe e anticapitalista dell’OpposizioneCgil), “il senso di una nostra presenza organizzata nella CGIL è quello di sfruttarne articolazioni e contraddizioni per sostenere il conflitto di classe, e quindi per sviluppare in una dinamica di massa un’azione sindacale anticapitalista. In questo quadro, è necessario intervenire come area sindacale nelle dinamiche del conflitto di classe”.
- I movimenti democratici e la loro polarizzazione classista. In questa stagione politica, contro le derive retrograde che attraversano alcuni settori sociali (pulsioni securitarie, integralismo religioso, familismo, ecc), come contro le politiche razziste e autoritarie dell’attuale governo reazionario (o alcune propensioni di quello passato, vedi i decreti Minniti), si sono sviluppate significative mobilitazioni. È cioè cresciuto nel tempo un popolo dei diritti, progressista e democratico, che difende le libertà individuali e collettive, prescindendo però da ogni dimensione di classe e ogni propensione di cambiamento sociale. Pensiamo alle tante manifestazioni in difesa dei migranti e contro il razzismo, alle parate ed alle iniziative del fronte LGBT, la diffusa sensibilità sul caso Cucchi e le repressioni poliziesche (come per il recente film “sulla mia pelle”), per certi versi anche la declinazione italiana del movimento femminista internazionale nonunadimeno o alcune manifestazioni antifasciste. Se, da una parte, questa mobilitazione sui diritti diventa un terreno di resistenza, un momento di attivazione di massa e di possibile identificazione di una nuova avanguardia, dall’altra questi movimenti si pongono in continuità con le derive che hanno accompagnato l’involuzione di classe di questi anni. In queste mobilitazioni tende infatti a imporsi una cifra moltitudinaria: l’annegamento di ogni caratterizzazione programmatica nella moltiplicazione di tavoli, piattaforme e rivendicazioni; la cancellazione di ogni simbologia di parte (persino delle bandiere nelle piazze); la valorizzazione di ampie alleanze, sociali ed organizzative, nella costruzione degli appuntamenti e delle iniziative. Di fatto, queste mobilitazioni tendono a caratterizzarsi come fronti popolari di massa, che trascendono quindi il fronte unico di classe perché coinvolgono forze e soggettività della piccola e media borghesia, se non frazioni delle stesse classi dominanti. Una dinamica anche di altre esperienze, ambientaliste e territoriali, come i movimenti notav, notap o, in passato, nodalmolin. Tenendo presente che, nel quadro dell’involuzione in corso, queste mobilitazioni assumono un ruolo di opposizione e attivazione di un’ampia avanguardia sociale, rimane importante parteciparci e sostenerle. Parteciparci e sostenerle pienamente, a partire da un coinvolgimento attivo nei percorsi di convocazione e organizzazione di questi appuntamenti. Però, per contrastare la loro caratterizzazione interclassista, il fronte popolare sotteso alla loro dinamica, diventa altrettanto fondamentale sviluppare al loro interno una polarizzazione intorno a parole d’ordine, obbiettivi e tendenze classiste. Cercando di arrivare, anche grazie allo sviluppo del conflitto, a momenti di rottura di questi movimenti, intorno ad una demarcazione classista. Uesto Questo obbiettivo si pone per due ragioni di fondo. Primo, per riuscire anche in queste mobilitazioni, che coinvolgono settori politicizzati, a sviluppare il riconoscimento della differenza di interessi tra le diverse classi. Secondo, perché queste mobilitazioni possono involontariamente rinforzare la saldatura tra movimenti reazionari e classi subalterne: da una parte coinvolgendo soggetti, impostazioni e rivendicazioni democratico-liberali, legate alle precedenti gestioni politiche; dall’altra, perché tendono a coinvolgere ceti urbani che per cultura e modalità di espressione, si pongono in diretta contrapposizione proprio con i sentimenti e le identità delle classi subalterne.
- Coscienza di classe, dimensione di massa e terreno elettorale. Le elezioni, sia quelle generali (politiche ed europee), sia quelle locali (comunali e regionali), sono sempre più un momento di definizione del senso comune e delle identità collettive. Sia nelle campagne elettorali, sia in considerazione dei suoi risultati. I risultati elettorali sono cioè sia un effetto dei processi di scomposizione e ricomposizione delle identità sociali, a partire da quelle di classe, sia uno dei fattori che possono accelerare e, in alcuni contesti, persino indirizzare queste dinamiche. Anche per questo, il terreo elettorale rimane un terreno centrale dello sviluppo di un’iniziativa rivoluzionaria, oltre che di costruzione di una rappresentanza di classe (in grado di dar voce e corpo, anche nelle istituzioni, a resistenze ed antagonismi). Per quanto difficile, è un terreno che non può esser semplicemente abbandonato. Le dinamiche normative, politiche ed organizzative in corso rendono però talvolta impossibile calcare questo terreno (o controproducente, per il logoramento delle energie a fronte di una presenza, o dei risultati, marginali). A fronte di questo contesto, diventa quindi utile se non necessario valutare come presidiare il fronte elettorale con una proposta più ampia, classista e internazionalista. Cioè, diventa fondamentale valutare la possibilità di costruire cartelli, liste o fronti che siano in grado di introdurre nel panorama politico, cioè nello scontro elettorale e nel confronto programmatico, un soggetto che si caratterizzi chiaramente per la propria autonomia di classe e, conseguentemente, per il rifiuto di ogni ripiegamento nazionalista o sovranista. Intendiamoci, tanto più in una stagione storica in cui anche i movimenti sociali tendono ad esser eterogenei e interclassisti, è necessario non solo evitare ma anche combattere ogni proposta di concentrazione elettorale, aprogrammatica o antiprogrammatica, costruita sull’esigenza di rappresentare una confusa bandiera (la sinistra) o, anche peggio, di raccogliere ampi fronti tra loro contraddittori (e quindi fatui, che collassano o si dividono alla prima curva, alla prima scelta politica determinante). Nel contempo, proprio a partire da una chiarezza programmatica di carattere classista, transitoria e internazionalista, è forse possibile cercare di sviluppare alcune esperienze che possono permettere di non abbandonare questo campo. Ci sono diverse formule e possibilità, dai puri cartelli elettorali (LO-LCR in Francia) ai fronti strutturati (stile FIT argentino). La recente esperienza che è stata condotta da noi, Per una sinistra rivoluzionaria, non è stata positiva. Non solo per i risultati ultra limitati e marginali (0,1%, 30mila voti), ma per tutta la dinamica politica che ha caratterizzato quell’appuntamento (a livello nazionale come nei territori). Per la reciproca diffidenza e rigidità che ha caratterizzato lo stesso rapporto tra le sue organizzazioni costitutive (PCL e SCR). Un’esperienza, cioè, che si è sostanzialmente caratterizzata per autocentrature, asfissia, utilitarismo e artificiosità. Non è un caso, credo, che non ci sia stata la capacità, da parte di entrambe le organizzazioni, di trarre un bilancio pubblico (in maniera condivisa od ognuno per sé), di condurre un confronto sull’esperienza vissuta, mi viene da dire anche solo di nominarla a distanza di tempo. Le esperienze, non di meno, insegnano. Senza precludere la possibilità di ripetere gli errori, ma senza nemmeno segnare il destino di ripeterli. Per questo, sarebbe in ogni caso utile riprendere quell’esperienza, rileggerne limiti e punti di forza (che pure c’erano), e verificare se e come sia possibile continuarla, o farne nascere di nuove, allargandola anche ad altre forze e soggetti.
- La propaganda di massa ed i suoi strumenti. Lo sviluppo di un intervento di massa, in una fase di involuzione della coscienza di classe e de(s)composizione del popolo della sinistra, deve esser accompagnato e sostenuto da una propaganda di massa. Nel corso della fase precedente, dove il nostro obbiettivo strategico prioritario era quello di diffondere ed indirizzare l’incendio della prateria, la nostra propaganda (sito, volantini e giornale, Unità di classe) è stata sostanzialmente diretta a conquistare l’avanguardia politica e sociale. Come ho sottolineato qualche anno fa in un bollettino di discussione interna (Quale propaganda per quali obbiettivi, Intercom 2, agosto 2015), “Il nostro intervento, certo, non si focalizza solo sulla ristretta avanguardia dei militanti politici, sindacali o di movimento. La nostra propaganda si rivolge all’avanguardia di massa: per uscire dalle etichette, a quegli ampi settori di popolazione, innanzitutto della classe lavoratrice, che condividono immaginari confusamente classisti o nebulosamente anticapitalisti. Quei settori, cioè, che hanno sviluppato, dalle tradizioni della sinistra o dal concreto della lotta di classe, anche solo vaghe rappresentazioni sociali della contraddizione insanabile tra capitale e lavoro: i settori di massa che hanno una minima coscienza politica di classe. Per questi settori, un volantino impostato su immagini e emozioni risulterebbe troppo..superficiale: sarebbe un messaggio troppo semplificato, senza argomentazioni, incapace di far presa su chi ha una certa disponibilità ed attenzione, in quanto ha sviluppato una minima coscienza politica. Sarebbero forse volantini carini, ma sicuramente inefficaci”. Una sottolineatura che riprendeva esplicitamente alcuni modelli famosi della comunicazione persuasiva “(ELM di Petty e Cacioppo, 1986; HSM di Chaiken, 1987): un messaggio, per modificare un comportamento o un atteggiamento, ha due diverse strade per arrivare alle persone. La prima (centrale o sistematica) utilizza argomenti e informazioni: la persona è portata ad attivare una riflessione sui contenuti proposti (pensiamo alla pubblicità del detersivo con i due lenzuoli appesi, uno solo “più bianco del bianco”). La seconda (periferica o euristica) si basa su elementi esogeni, “induttori”, come la piacevolezza del comunicatore, colori o musiche (pensiamo alle pubblicità delle auto, che presentano l’emozione di una guida e non le caratteristiche del prodotto). La scelta della via dipende dall’attenzione e dalla motivazione delle persone, tenendo conto che quella periferica è più..superficiale (meno incisiva). Questi modelli, ovviamente, sono utilizzati anche nella comunicazione politica (famoso lo spot USA delle presidenziali ’88, che associava il candidato democratico allo stupro di una donna bianca da parte di un carcerato nero in permesso). Il punto è che oggi, a fronte della dinamica in corso, può esser utile rivedere alcuni elementi della nostra propaganda, “centrata su un modello argomentativo (eccessiva prolissità), inutile per “l’ampia schiera di lavoratori, disoccupati, studenti e pensionati oggi più che mai divisi tra confusione e disillusione”. Poco motivati e poco attenti, questi settori sono infatti indisponibili a questa via. Per dei volantini di massa, servono messaggi più semplici e una grafica di impatto (elementi induttori, nel testo e nell’immagine, per trasmettere i nostri contenuti politici). Alcune esperienze e alcuni tentativi sono stati sviluppati in questi anni, ma anche in relazione allo sviluppo di campagne comunicative e iniziative di propaganda intorno ad alcuni elementi dei programmi transitori di settore, o degli obbiettivi transitori generali, può allora esser utile riprendere ed approfondire questa riflessione, costruendo una propaganda più adeguata non solo al contesto, ma anche agli obbiettivi strategici di fase.
- Classismo, internazionalismo e polarizzazioni d’avanguardia. Se la dimensione di massa è segnata dall’involuzione della coscienza e l’egemonia reazionaria, rimane un’avanguardia politica che, anche se scollegata e talvolta isolata da una più ampia rappresentanza, ha ancora una sua consistenza (qualche decina di migliaia di persone). Un’avanguardia che mantiene tradizioni ed impianti della storia del movimento operaio, della nuova sinistra e anche dell’ultima stagione neoliberista e dei suoi movimenti di contestazione. Un’avanguardia che in specifici settori (logistica, trasporti, alcune grandi fabbriche) mantiene un radicamento ed un’influenza di massa. Se il nostro baricentro deve rimanere la dimensione di massa, in ogni caso si deve anche tener in considerazione le dinamiche che da questa avanguardia possono innescarsi. L’ultimo congresso del PCL (risoluzione conclusiva) aveva sottolineato l’opportunità di sviluppare “un’unità d’azione con le altre forze classiste e internazionaliste”, per “costruire un processo di polarizzazione nell’avanguardia sociale e politica larga… Un’azione che, ovviamente, non può esser sostitutiva e non può pensarsi sostitutiva del fronte unico, della priorità di una ripresa della mobilitazione di massa nel nostro paese. Un’azione politica di avanguardia può però permettere la ricomposizione di percorsi e appuntamenti di lotta, che possono svolgere un ruolo anche significativo nel mantenere accesa, anche nella percezione di massa, la prospettiva di un’alternativa di classe”. L’intervento, nell’ottica strategica di sviluppo dell’autonomia di classe, è cioè duplice. Da una parte sostenere lotte che, pur in una dimensione ridotta, possano comunque segnare un’opposizione sociale di classe. Dall’altra, all’interno di questa avanguardia, contrastare le derive sovraniste, che sono inscritte nelle tradizioni staliniste e che, in una fase di crescente conflittualità imperialistica, possono rilanciare queste matrici proprio nell’avanguardia (dal PC di Rizzo alla RdC).
In ogni caso, per intervento di “polarizzazione” non si intende la costruzione di fronti stabili (il “polo” classista e internazionalista). Ad oggi non sembrano infatti delinearsi né le condizioni né le disponibilità soggettive. I soggetti che hanno questa possibile matrice (come Sinistra Anticapitalista, Sinistra Classe Rivoluzione, SGB, CUB, SiCobas, altri gruppi o collettivi) hanno propri progetti e strategie, che li portano su strade diverse e spesso parallele (se non, talvolta, divergenti o addirittura contrapposte). Per polarizzazione, allora, si intende più semplicemente l’obbiettivo di far emergere, nel panorama politico, nella discussione della sinistra e nelle dinamiche di lotta, alcune discriminanti classiste e internazionaliste. Ad esempio, la permanenza dello sfruttamento capitalistico e la centralità dei conflitti nel lavoro; o la demarcazione rispetto ad ogni ripiegamento sovranista o campista, in alleanza con settori nazionali del capitale. Per polarizzazione si intende cioè la costruzione di interventi, campagne e mobilitazioni con questi soggetti, anche a geometria variabile. Iniziative che possono rientrare nei diversi progetti, perché in ogni caso sviluppano punti di vista, appunto classisti ed internazionalisti, che possono esser comuni alle diverse strategie. Discriminanti programmatiche che, per il precipitare della Grande Crisi (guerre, conflitti interimperialistici, movimenti di massa in altri paesi), possono anche assumere evidenza di massa, in grado quindi di intercettare ed influenzare i processi di ricomposizione dell’identità e della coscienza di alcuni settori di classe. In particolare, larga parte del mondo del sindacalismo di base, che coinvolge diverse decine di migliaia di attivisti, può esser interessato e coinvolto sul terreno dello sviluppo dell’autonomia di classe e della centralità del conflitto nel lavoro.
In conclusione, davvero in conclusione, questi conti, questi scorci, queste tracce sono offerti alla riflessione ed alla discussione collettiva, perché si ritiene che oggi come non mai, davanti al rischio di una traversata nel deserto (più o meno lunga), davanti alla possibilità di improvvise precipitazioni e devastazioni, sia utile almeno provare ad alzare la testa e cercare con fatica le stelle. Per orientarsi. Perché per arrivare è sempre necessario sapere dove si vuole andare, dove si è in questo momento, quali cammini si possono tracciare. Poi, come sempre, è la strada che ti conduce. Talvolta per seguirla è necessario tornare indietro. Talvolta si scoprono nuovi paesaggi. Talvolta si incrociano salite impreviste o discese inaspettate. E talvolta si incontrano nuovi compagni di viaggio, che ti indicano soluzioni impensate. Un progetto, una strategia, sono solo il progetto di un viaggio: non il suo dispiegarsi. Senza, però, è difficile imboccare qualunque strada: si rischia di camminare a casaccio e scoprire, quasi per caso, di non essersi mai mossi dal punto di partenza.