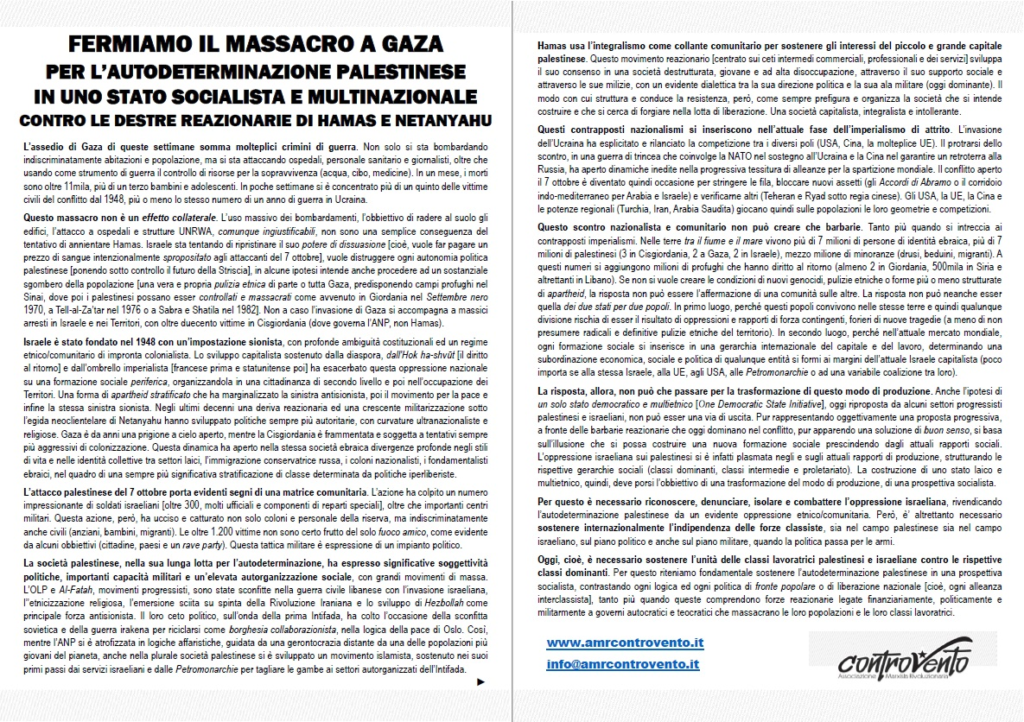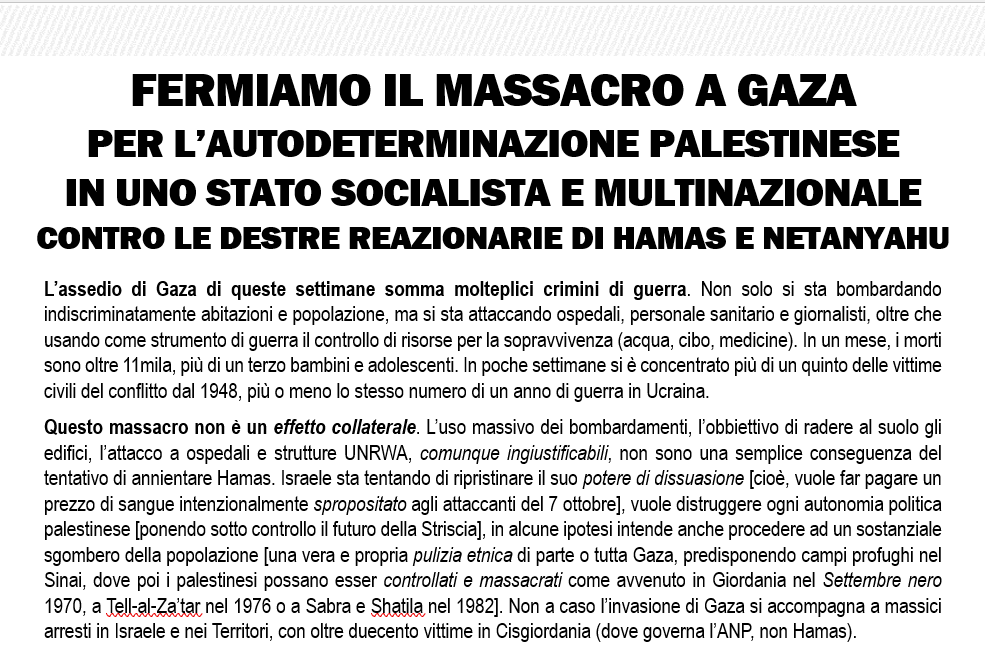PER L’AUTODETERMINAZIONE PALESTINESE IN UNO STATO SOCIALISTA E MULTINAZIONALE
CONTRO LE DESTRE REAZIONARIE DI HAMAS E NETANYAHU
L’assedio di Gaza di queste settimane somma molteplici crimini di guerra. Non solo si sta bombardando indiscriminatamente abitazioni e popolazione, ma si sta attaccando ospedali, personale sanitario e giornalisti, oltre che usando come strumento di guerra il controllo di risorse per la sopravvivenza (acqua, cibo, medicine). In un mese, i morti sono oltre 11mila, più di un terzo bambini e adolescenti. In poche settimane si è concentrato più di un quinto delle vittime civili del conflitto dal 1948, più o meno lo stesso numero di un anno di guerra in Ucraina.
Questo massacro non è un effetto collaterale. L’uso massivo dei bombardamenti, l’obbiettivo di radere al suolo gli edifici, l’attacco a ospedali e strutture UNRWA, comunque ingiustificabili, non sono una semplice conseguenza del tentativo di annientare Hamas. Israele sta tentando di ripristinare il suo potere di dissuasione [cioè, vuole far pagare un prezzo di sangue intenzionalmente spropositato agli attaccanti del 7 ottobre], vuole distruggere ogni autonomia politica palestinese [ponendo sotto controllo il futuro della Striscia], in alcune ipotesi intende anche procedere ad un sostanziale sgombero della popolazione [una vera e propria pulizia etnica di parte o tutta Gaza, predisponendo campi profughi nel Sinai, dove poi i palestinesi possano esser controllati e massacrati come avvenuto in Giordania nel Settembre nero 1970, a Tell-al-Za’tar nel 1976 o a Sabra e Shatila nel 1982]. Non a caso l’invasione di Gaza si accompagna a massici arresti in Israele e nei Territori, con oltre duecento vittime in Cisgiordania (dove governa l’ANP, non Hamas).
Israele è stato fondato nel 1948 con un’impostazione sionista, con profonde ambiguità costituzionali ed un regime etnico/comunitario di impronta colonialista. Lo sviluppo capitalista sostenuto dalla diaspora, dall’Hok ha-shvūt [il diritto al ritorno] e dall’ombrello imperialista [francese prima e statunitense poi] ha esacerbato questa oppressione nazionale su una formazione sociale periferica, organizzandola in una cittadinanza di secondo livello e poi nell’occupazione dei Territori. Una forma di apartheid stratificato che ha marginalizzato la sinistra antisionista, poi il movimento per la pace e infine la stessa sinistra sionista. Negli ultimi decenni una deriva reazionaria ed una crescente militarizzazione sotto l’egida neoclientelare di Netanyahu hanno sviluppato politiche sempre più autoritarie, con curvature ultranazionaliste e religiose. Gaza è da anni una prigione a cielo aperto, mentre la Cisgiordania è frammentata e soggetta a tentativi sempre più aggressivi di colonizzazione. Questa dinamica ha aperto nella stessa società ebraica divergenze profonde negli stili di vita e nelle identità collettive tra settori laici, l’immigrazione conservatrice russa, i coloni nazionalisti, i fondamentalisti ebraici, nel quadro di una sempre più significativa stratificazione di classe determinata da politiche iperliberiste.
L’attacco palestinese del 7 ottobre porta evidenti segni di una matrice comunitaria. L’azione ha colpito un numero impressionante di soldati israeliani [oltre 300, molti ufficiali e componenti di reparti speciali], oltre che importanti centri militari. Questa azione, però, ha ucciso e catturato non solo coloni e personale della riserva, ma indiscriminatamente anche civili (anziani, bambini, migranti). Le oltre 1.200 vittime non sono certo frutto del solo fuoco amico, come evidente da alcuni obbiettivi (cittadine, paesi e un rave party). Questa tattica militare è espressione di un impianto politico.
La società palestinese, nella sua lunga lotta per l’autodeterminazione, ha espresso significative soggettività politiche, importanti capacità militari e un’elevata autorganizzazione sociale, con grandi movimenti di massa. L’OLP e Al-Fatah, movimenti progressisti, sono state sconfitte nella guerra civile libanese con l’invasione israeliana, l’’etnicizzazione religiosa, l’emersione sciita su spinta della Rivoluzione Iraniana e lo sviluppo di Hezbollah come principale forza antisionista. Il loro ceto politico, sull’onda della prima Intifada, ha colto l’occasione della sconfitta sovietica e della guerra irakena per riciclarsi come borghesia collaborazionista, nella logica della pace di Oslo. Così, mentre l’ANP si è atrofizzata in logiche affaristiche, guidata da una gerontocrazia distante da una delle popolazioni più giovani del pianeta, anche nella plurale società palestinese si è sviluppato un movimento islamista, sostenuto nei suoi primi passi dai servizi israeliani e dalle Petromonarchie per tagliare le gambe ai settori autorganizzati dell’Intifada.
Hamas usa l’integralismo come collante comunitario per sostenere gli interessi del piccolo e grande capitale palestinese. Questo movimento reazionario [centrato sui ceti intermedi commerciali, professionali e dei servizi] sviluppa il suo consenso in una società destrutturata, giovane e ad alta disoccupazione, attraverso il suo supporto sociale e attraverso le sue milizie, con un evidente dialettica tra la sua direzione politica e la sua ala militare (oggi dominante). Il modo con cui struttura e conduce la resistenza, però, come sempre prefigura e organizza la società che si intende costruire e che si cerca di forgiare nella lotta di liberazione. Una società capitalista, integralista e intollerante.
Questi contrapposti nazionalismi si inseriscono nell’attuale fase dell’imperialismo di attrito. L’invasione dell’Ucraina ha esplicitato e rilanciato la competizione tra i diversi poli (USA, Cina, la molteplice UE). Il protrarsi dello scontro, in una guerra di trincea che coinvolge la NATO nel sostegno all’Ucraina e la Cina nel garantire un retroterra alla Russia, ha aperto dinamiche inedite nella progressiva tessitura di alleanze per la spartizione mondiale. Il conflitto aperto il 7 ottobre è diventato quindi occasione per stringere le fila, bloccare nuovi assetti (gli Accordi di Abramo o il corridoio indo-mediterraneo per Arabia e Israele) e verificarne altri (Teheran e Ryad sotto regia cinese). Gli USA, la UE, la Cina e le potenze regionali (Turchia, Iran, Arabia Saudita) giocano quindi sulle popolazioni le loro geometrie e competizioni.
Questo scontro nazionalista e comunitario non può creare che barbarie. Tanto più quando si intreccia ai contrapposti imperialismi. Nelle terre tra il fiume e il mare vivono più di 7 milioni di persone di identità ebraica, più di 7 milioni di palestinesi (3 in Cisgiordania, 2 a Gaza, 2 in Israele), mezzo milione di minoranze (drusi, beduini, migranti). A questi numeri si aggiungono milioni di profughi che hanno diritto al ritorno (almeno 2 in Giordania, 500mila in Siria e altrettanti in Libano). Se non si vuole creare le condizioni di nuovi genocidi, pulizie etniche o forme più o meno strutturate di apartheid, la risposta non può essere l’affermazione di una comunità sulle altre. La risposta non può neanche esser quella dei due stati per due popoli. In primo luogo, perché questi popoli convivono nelle stesse terre e quindi qualunque divisione rischia di esser il risultato di oppressioni e rapporti di forza contingenti, forieri di nuove tragedie (a meno di non presumere radicali e definitive pulizie etniche del territorio). In secondo luogo, perché nell’attuale mercato mondiale, ogni formazione sociale si inserisce in una gerarchia internazionale del capitale e del lavoro, determinando una subordinazione economica, sociale e politica di qualunque entità si formi ai margini dell’attuale Israele capitalista (poco importa se alla stessa Israele, alla UE, agli USA, alle Petromonarchie o ad una variabile coalizione tra loro).
La risposta, allora, non può che passare per la trasformazione di questo modo di produzione. Anche l’ipotesi di un solo stato democratico e multietnico [One Democratic State Initiative], oggi riproposta da alcuni settori progressisti palestinesi e israeliani, non può esser una via di uscita. Pur rappresentando oggettivamente una proposta progressiva, a fronte delle barbarie reazionarie che oggi dominano nel conflitto, pur apparendo una soluzione di buon senso, si basa sull’illusione che si possa costruire una nuova formazione sociale prescindendo dagli attuali rapporti sociali. L’oppressione israeliana sui palestinesi si è infatti plasmata negli e sugli attuali rapporti di produzione, strutturando le rispettive gerarchie sociali (classi dominanti, classi intermedie e proletariato). La costruzione di uno stato laico e multietnico, quindi, deve porsi l’obbiettivo di una trasformazione del modo di produzione, di una prospettiva socialista.
Per questo è necessario riconoscere, denunciare, isolare e combattere l’oppressione israeliana, rivendicando l’autodeterminazione palestinese da un evidente oppressione etnico/comunitaria. Però, è’ altrettanto necessario sostenere internazionalmente l’indipendenza delle forze classiste, sia nel campo palestinese sia nel campo israeliano, sul piano politico e anche sul piano militare, quando la politica passa per le armi.
Oggi, cioè, è necessario sostenere l’unità delle classi lavoratrici palestinesi e israeliane contro le rispettive classi dominanti. Per questo riteniamo fondamentale sostenere l’autodeterminazione palestinese in una prospettiva socialista, contrastando ogni logica ed ogni politica di fronte popolare o di liberazione nazionale [cioè, ogni alleanza interclassista], tanto più quando queste comprendono forze reazionarie legate finanziariamente, politicamente e militarmente a governi autocratici e teocratici che massacrano le loro popolazioni e le loro classi lavoratrici.
ControVento